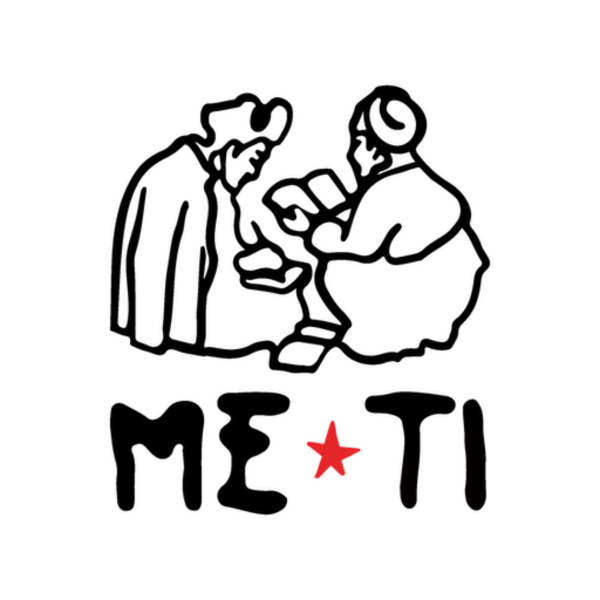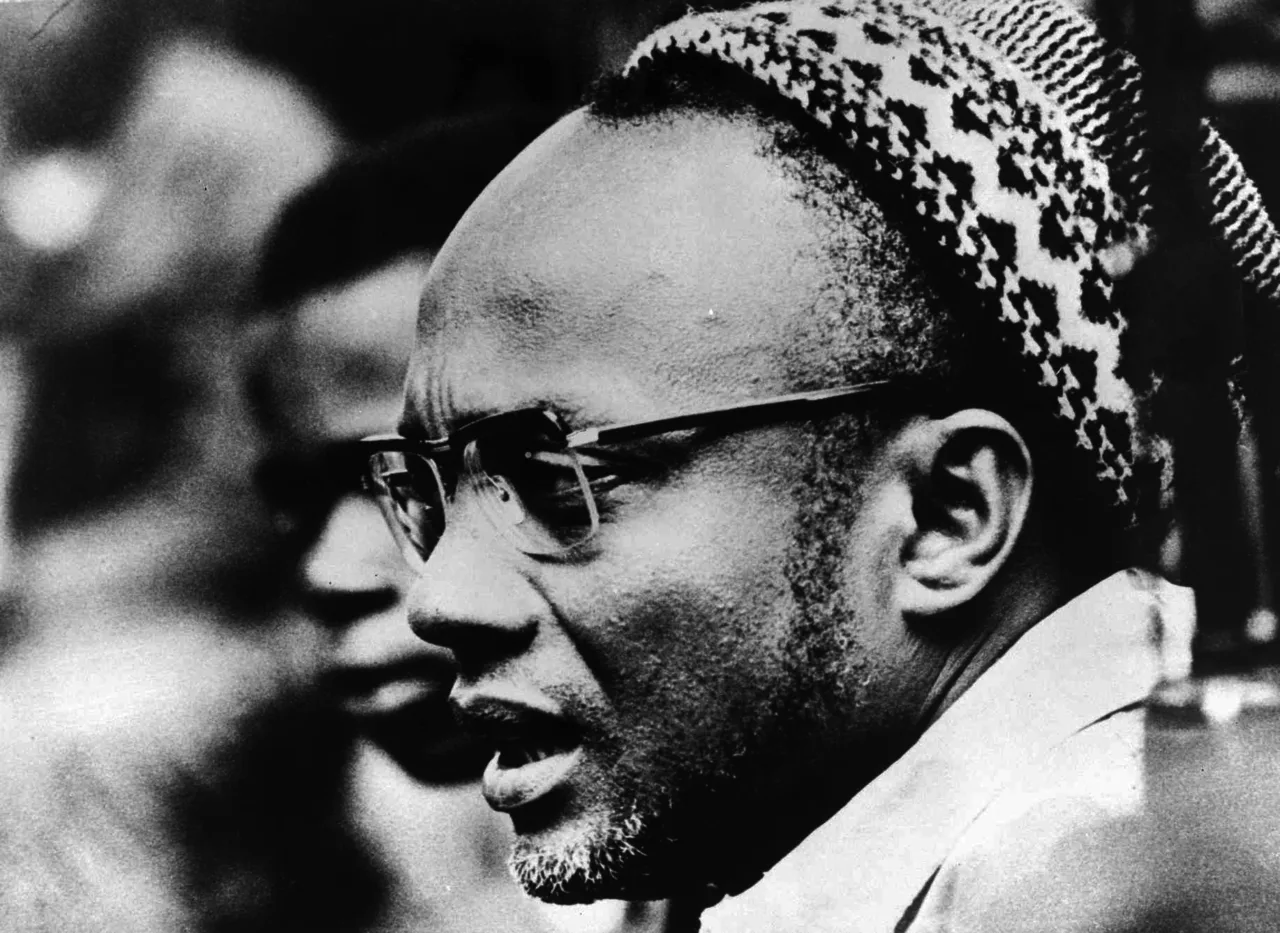A pochi mesi dall’uscita nelle sale francesi del film di Jean-Claude Barny – già oggetto di ampio dibattito per il suo contenuto e le difficoltà di distribuzione – ora è in sala un nuovo lungometraggio dedicato a Frantz Fanon1. Le due pellicole offrono al pubblico un ritratto del filosofo‑psichiatra e militante originario della Martinica, soffermandosi sul periodo in cui diresse il reparto psichiatrico dell’ospedale di Blida‑Joinville, tra il 1953 e il 1956.
Dunque, sebbene la stessa scelta rispetto al periodo, i due film adottano approcci opposti: mentre Barny tende a spettacolarizzare la figura di Fanon, trasformandolo in una sorta di eroe e mantenendo un ritmo narrativo serrato dall’inizio alla fine, l’opera di Abdenour Zahzah assume un orientamento completamente diverso. Qui Fanon – interpretato da Alexandre Desane – è rappresentato come un anti-eroe, più umano che leggendario.
Come ha spiegato in sala lo stesso regista Abdenour Zahzah – direttore della cineteca di Blida dal 1998 al 2003 e già autore nel 2002 del documentario Frantz Fanon: mémoires d’asile –, il desiderio che ha guidato il progetto era “realizzare un film che sarebbe piaciuto a Fanon”.
Il contrasto con lo stile hollywoodiano di Barny è netto: qui la macchina da presa è statica, quasi osservativa, come se lo spettatore scrutasse l’ospedale di Blida attraverso una finestra. Privilegiando così piani fissi e inquadrature ampie, evitando bruschi movimenti di camera, una stasi che favorisce anche l’ascolto dei dialoghi.
Nella parte finale del film sono integrate immagini d’archivio dell’ospedale di Blida in quell’epoca, rafforzando l’autenticità storica della ricostruzione. La scelta del bianco e nero è infatti fedele al contesto storico, in cui il cinema a colori era solo ai suoi esordi…
La ricerca di un’autenticità ricorda anche la fotografia de La Battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966), regista di formazione marxista che si ispirò alle letture di Fanon, arrivando a controtipare alcuni fotogrammi per rendere la grana dell’immagine sporca, imperfetta, documentaristica.2
Una differenza importante riguarda anche i luoghi del set: Barny ha girato in Tunisia per impossibilità di accedere al suolo algerino, mentre Zahzah è riuscito a girare direttamente a Blida, dentro l’ospedale che Fanon aveva diretto.
La pellicola, dunque, rimane nella sua semplicità una realtà infiammante facendo risuonare il pensiero politico di Fanon, nella sua potenza all’interno e fuori delle mura ospedaliere.
Di una poetica essenziale, in cui persino l’inquadratura si lascia abbandonare ai gesti della quotidianità e dal loro movimento, che come scrive Deleuze “non immagini in movimento, ma immagine‑movimento; non essere in divenire ma un essere che è divenire”3, immagine che mostra, con la stessa nettezza di questa scelta monocroma, le differenze tra lo status di colono e quello di colonizzato.
Zahzah va oltre ciò che Barny aveva lasciato nell’ombra, analizzando le sovrastrutture dell’ospedale: l’imposizione di un cadre religioso cattolico, su pazienti in gran parte di fede musulmana. Un elemento emblematico è la decisione di decorare il padiglione degli uomini algerini con statue della Madonna, gesto che strideva con la presenza di oltre la metà dei malati musulmani. Davanti a questa incongruenza che mette in evidenza la violenza forzata dell’universo occidentale, Fanon si interroga: “Cosa ci fa questa statua in un reparto musulmano?”
In una delle sequenze successive, durante una lezione rivolta al personale sanitario, Fanon ne critica l’atteggiamento di chiusura, sottolineando come questo possa generare a sua volta isolamento nei pazienti. È proprio in quel momento che la macchina da presa, rimasta fino a quell’istante statica, comincia a muoversi dolcemente verso l’esterno della sala, quasi a voler suggerire un’apertura simbolica, un richiamo verso il mondo esterno. L’idea dello psichiatra era proprio quella di aprirsi al mondo, creare spazi conviviali all’interno della struttura, “anche un caffè può cambiare la giornata di un paziente”.
Per lo psichiatra, la colonizzazione era una negazione sistematica dell’alterità, un rifiuto ossessivo di riconoscere qualsivoglia attributo di umanità all’altro.4 “Disumanizza il colonizzato. A rigor di termini, lo animalizza”5, il parallelo è netto con la situazione che vive il popolo palestinese ancora oggi, sono dei binomi semplificati, frutto di un processo di disumanizzazione ancora una volta imposto dal colono, portatore invece di valori democratici e liberali.
La struttura psichiatrica di Blida – fondata nel 1933 sulla base dei presupposti razzisti dell’École psychiatrique d’Alger – era organizzata secondo due trattamenti distinti: uno per i pazienti europei e uno per quelli indigeni. Nel film, difatti, vengono citate le differenti cure: ai francesi si applicavano le terapie più moderne disponibili all’epoca; agli algerini invece si somministravano trattamenti estremi – shock di Cardiazol, cure di Sakel, elettroshock ripetuti, lobotomie e topectomie – con grande frequenza e scarso criterio, purché giustificati come misure “necessarie” per l’inferiorità biologica attribuita ai nordafricani.6
Non solo: la figura del colono emerge nelle successive sequenze sotto altre forme. Ad esempio, c’è il caso di un mujahedin (combattente del FLN) che, al termine della cura, confessa a Fanon di aver ricevuto una lettera da sua moglie, nella quale denunciava le violenze subite dai soldati francesi. Lui, sentendosi responsabile, racconta a Fanon: “È colpa mia, perché era me che stavano cercando. Cosa avrebbe fatto lei al mio posto, se avesse scoperto da una lettera che avevano violentato sua moglie?”
Il commissario francese che rivela allo psichiatra di essere diventato folle a causa delle torture che era costretto a infliggere, episodio che avevamo già trovato in Barny ma sotto un aspetto fictionale. In questa versione, invece, il personaggio si confronta frontalmente con la propria brutalità e con l’orrore delle torture, come trauma vissuto in prima persona.
Pontecorvo, nella Battaglia di Algeri, aveva scelto di mostrare quell’orrore in modo diretto e viscerale, scioccando la Francia e provocando la censura della pellicola fino al 2005. Zahzah opta per una via diversa, intima. Il commissario chiede di voler essere salvato, confessando di essere diventato violento anche in casa, con la moglie e i figli. L’orrore qui non è visibile, ma resta costantemente presente, alleggiando nella quiete apparente del film.
La struttura coloniale dell’ospedale rispecchia totalmente l’esterno, l’Algeria e non solo; nonostante ci siano poche scene girate al di fuori, c’è un continuo richiamo al mondo circostante. La partenza di Fanon verso la Tunisia è il momento in cui il film si ferma. Non potendo più operare a Blida a causa del ruolo politico sempre più centrale e del suo impegno nella cura dei militanti del FLN.
Dopo tanti anni, il cinema torna a confrontarsi con la guerra d’Algeria attraverso due pellicole che mettono al centro il conflitto e tutto ciò che una guerra ha portato con sé, una tematica ancora oggi mal digerita dal pubblico francese.
Quanto è complesso, allora, trasporre tutto questo sullo schermo? Riuscire a rappresentarlo al meglio attraverso il linguaggio cinematografico? Metterlo in scena…
Complesso se a farlo è un regista algerino, figlio diretto di quella storia, che sceglie di affrontare un tema così delicato con un film destinato alla distribuzione nelle sale francesi, e si spera anche italiane.
Dunque, lasciare che il cinema europeo si lasci attraversare da un vero confronto con il proprio passato coloniale e dalla forza politica di questo personaggio ancora oggi attuale, confrontarsi con l’idea che il capitalismo contemporaneo e le élite borghesi post-coloniali costruiscono nuove gerarchie di sfruttamento che ripropongono le strutture materiale e psicologica del colonialismo.
Zahzah, per farlo, nella sua opera quasi documentaria sembra aver scelto di partire da se stesso e da Fanon; a differenza di Berny il suo film è riuscito perché é entrato nella sua intimità per mettere in moto un processo di ri‑attualizzazione critica di quella storia.
Seguendo l’insegnamento di Gramsci, poi ripreso anche da Edward Said, credo che anche noi dovremmo ripartire da qui, da una nostra elaborazione critica, consapevole. Come scrive l’intellettuale nei Quaderni del carcere, “l’inizio dell’elaborazione critica è la coscienza di quello che si è realmente, cioè un ‘conosci te stesso’ come prodotto del processo storico finora svoltosi, che ha lasciato in te stesso un’infinità di tracce accolte senza beneficio d’inventario: occorre fare inizialmente un tale inventario”.7
È proprio da questo lavoro interiore e storico insieme – questo “inventario delle tracce” – che può prendere forma un pensiero decoloniale capace di leggere il presente e immaginare nuove possibilità.
- Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique Blida‑Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était chef de la cinquième division entre 1953 et 1956 (titolo originale), distribuito in Francia come Frantz Fanon (regia di Abdenour Zahzah, 2024‑2025). ↩︎
- Ivelise Perniola, “Un regista incompreso: Gillo Pontecorvo nel centenario della nascita”, Fata Morgana Web, 15 aprile 2019, https://www.fatamorganaweb.it/gillo-pontecorvo-centenario. ↩︎
- G. Deleuze, L’immagine-movimento. Cinema 1, Einaudi, Torino 2016. ↩︎
- QG Décolonial, “Généraux à la poubelle, l’Algérie sera indépendante”: la nouvelle révolution algérienne comme moment fanonien, pubblicato su QG Décolonial, https://qgdecolonial.fr. ↩︎
- Frantz Fanon, Pelle nera, maschere bianche, trad. Silvia Chiletti, Pisa, Edizioni ETS, 2015, pp. 30-40. ↩︎
- Paul Marquis, “Frantz Fanon et le personnel soignant à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville”, Le carnet des Glycines, 16 febbraio 2015, https://glycines.hypotheses.org/301. ↩︎
- Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, a cura di Valentino Gerratana, Einaudi, Torino, 1975, Q11, 12, p. 1376. ↩︎