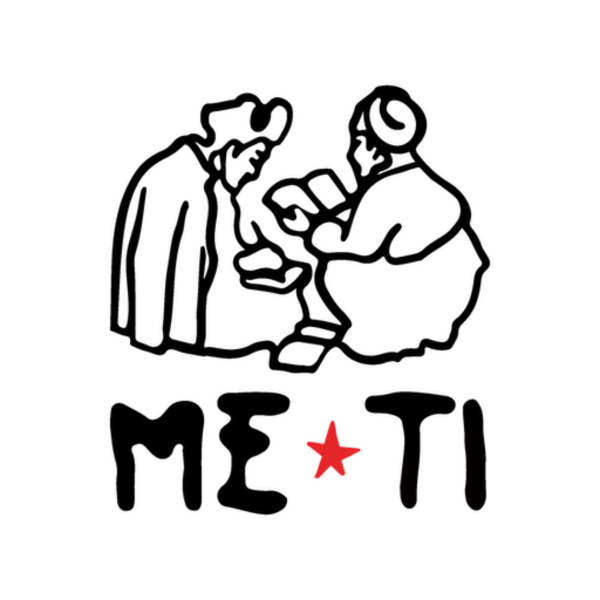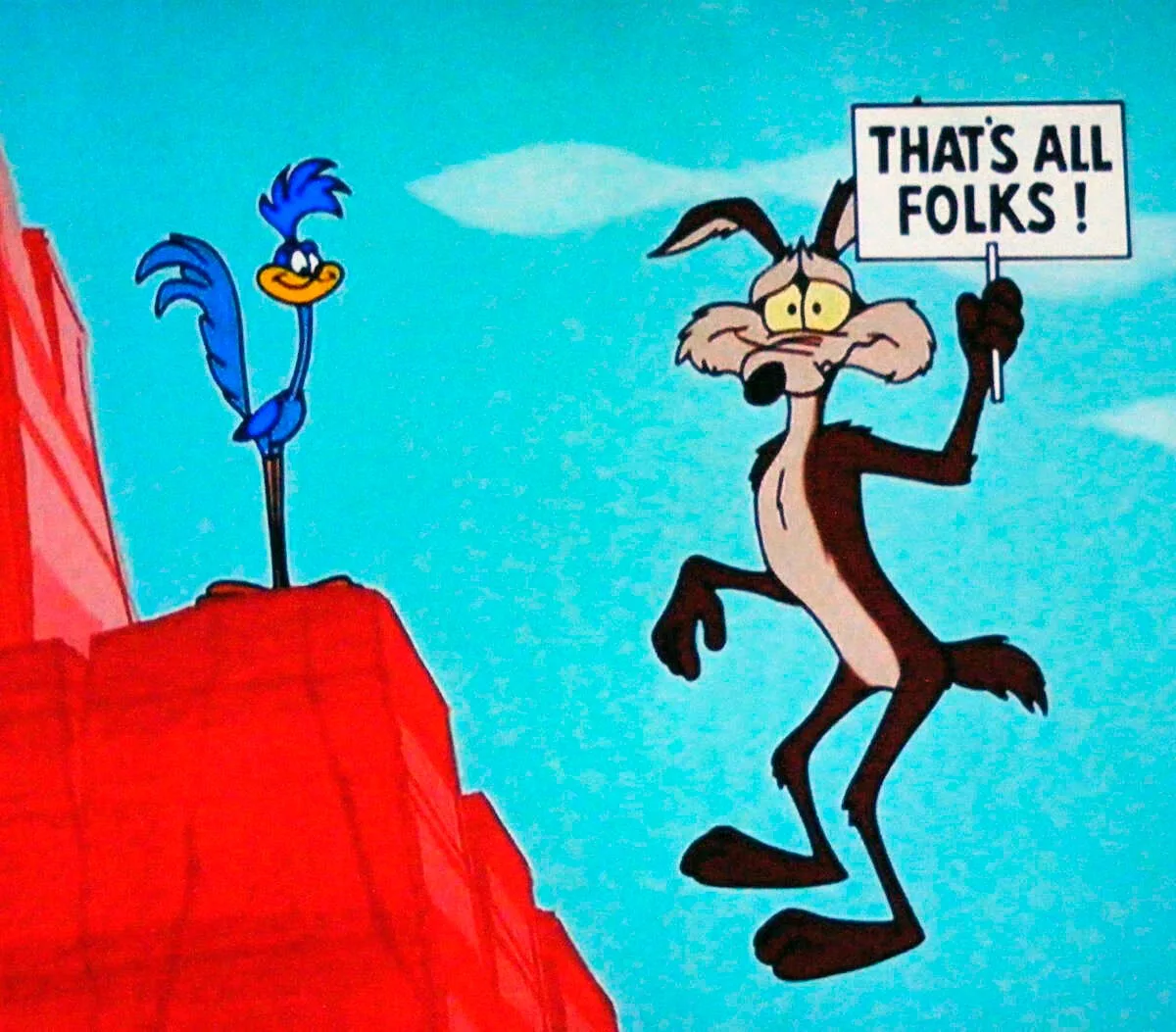In questo articolo scritto il 4 settembre, Stathis Kouvelakis – filosofo e membro della redazione di Contretemps – ripercorre la sequenza politica dell’ultimo anno, dalla nomina di François Bayrou a capo del governo fino alla sua caduta. Insiste in particolare su un aspetto che di solito si tralascia, ovvero il ruolo dell’Unione Europea, e analizza la strategia del PS nell’attuale congiuntura politica.
***
Il vuoto della ripetizione
Conosciamo tutti le disavventure di Willy il Coyote, un personaggio dei cartoni animati di Tex Avery, ossessionato dall’uccello del deserto “Beep-beep”: a un certo punto dell’inseguimento, il coyote, trasportato dal suo slancio, si lancia sopra un precipizio e continua allegramente a correre nel vuoto. Le leggi di gravità vengono trasgredite, eppure non accade nulla di grave, egli continua la sua corsa come se nulla fosse. Fino al momento in cui finisce per guardare in basso e scopre il vuoto sopra il quale è come sospeso. Questo vuoto diventa allora “effettivo”, e le leggi della fisica riprendono il sopravvento.
Il filosofo sloveno Slavoj Zizek fa spesso riferimento a questo episodio per illustrare il paradosso di un “velo di ignoranza” che, in alcune situazioni, ha una funzione protettiva, paradosso che rimanda al divario tra l’oggettività di una situazione e il momento soggettivo della sua percezione che la rende attiva. Va tuttavia notato che ciò che scatena questa percezione soggettiva non è tanto una “presa di coscienza”, nel senso di un processo mentale che si svolge nell’interiorità di una coscienza, quanto un gesto, un atto: guardare i propri piedi.
Da qui nascono spontanee due domande: cosa spinge il coyote a compiere questo gesto fatale? E cosa rappresenta allegoricamente questo strano uccello blu, un grande cuculo secondo la classificazione zoologica? Su quest’ultimo punto abbiamo un’indicazione chiara: come suggerisce il nome onomatopeico con cui è stato battezzato, l’uccello rappresenta la ripetizione in quanto tale, in altre parole il vuoto di una ripetizione cieca, indistruttibile, che è il suo stesso scopo. “Beep-beep” continua a mostrare un’espressione imperturbabile e soddisfatta, ed è proprio l’esibizione sfacciata di questo puro godimento libidinale che alimenta la rabbia di Willy il Coyote nel dargli la caccia.
L’insieme dei cartoni animati di questa serie è costruito sul contrasto tra il movimento incessante ma sempre identico a se stesso dell’uccello e gli stratagemmi sempre nuovi di Willy il Coyote, completamente immerso nella sua ossessione, non meno ripetitiva e priva di senso del suono emesso dall’uccello corridore. È logicamente nel vuoto, cioè nella voragine di una ripetizione, che “cade” l’opposizione tra i due movimenti pulsionali, per riapparire immediatamente nelle immagini che seguono la caduta: poiché i personaggi di Tex Avery sono indistruttibili, essi rappresentano, secondo Zizek, il “non-morto”, il circuito perpetuamente riattivato della pulsione di morte spersonalizzata.
Il parallelo con il destino annunciato di François Bayrou è evidente: è bastato l’annuncio di un movimento sociale, tanto più inquietante in quanto la sua portata e le sue modalità sono imprevedibili, perché Bayrou compisse il gesto fatale: “rendersi conto” di non disporre di alcuna maggioranza parlamentare e che gli stratagemmi con cui era riuscito fino a quel momento a mantenersi “in corsa” non saranno sufficienti a raggiungere il suo obiettivo – tranne, ovviamente, quello di far guadagnare tempo al campo borghese, il che è tutt’altro che trascurabile, soprattutto in una situazione di crisi politica.
In queste condizioni, la richiesta di un voto di fiducia si presenta come l’ultima mossa per prendere di sorpresa la mobilitazione annunciata e mettere sotto pressione la forza che gli ha permesso di mantenersi al potere fino ad ora, il Partito socialista. Resta il fatto che un governo incapace di far approvare un bilancio dall’Assemblea nazionale è destinato a subire la stessa sorte di quello guidato dal suo predecessore, Michel Barnier, lo scorso dicembre.
Se tutto ciò è evidente, restano alcuni punti da chiarire, che troppo spesso rimangono nell’ombra1. Ispirandoci alla coreografia di Tex Avery, esamineremo ciò che ha permesso a Bayrou di continuare la corsa sul vuoto molto più a lungo del suo predecessore. Analizzeremo anche le condizioni in cui potrebbe continuare la corsa/inseguimento mortale (per le classi popolari e lavoratrici) intrapresa dai personaggi della macronia, così caricaturali nel loro beato godimento del potere, con una sostituzione del Willy il Coyote di turno, o se, all’opposto, questa corsa/inseguimento è destinata a finire, almeno nella forma che conosciamo dall’estate del 2024. Ma prima ci interrogheremo su quale sia l’obiettivo reale che Bayrou e, dietro di lui, l’intero blocco borghese di cui Macron rimane il perno, sta cercando di raggiungere nell’immediato, ovvero il loro equivalente del Grande Corridore della strada Beep-beep.
“Beep-beep”: l’Unione europea, ovvero la ripetizione compulsiva dell’ortodossia di bilancio
L’ossessione di François Bayrou per il debito pubblico è, come sappiamo, di vecchia data. È stata spesso oggetto di commenti ironici, che fanno apparire Bayrou come una sorta di Cassandra fallita. Infatti, contrariamente a quelle pronunciate dall’eroina della mitologia greca, le previsioni funeste di Bayrou sono state smentite dal corso degli eventi, poiché nessuna crisi del debito ha colpito la Francia dal 2007, quando il presidente del MoDem2 ha fatto di questo spauracchio il cuore del suo discorso.
È senza dubbio inutile dimostrare a lungo che queste affermazioni allarmistiche servono, oggi come ieri, a giustificare politiche neoliberiste, più precisamente politiche di austerità, che combinano una fiscalità alleggerita per il capitale e le classi agiate con la restrizione della spesa pubblica, soprattutto a scapito dello Stato sociale. Gli economisti di sinistra hanno più volte dimostrato la fallacia delle affermazioni di Bayrou, in particolare quelle su cui si basa l’attuale progetto di bilancio: il debito pubblico non viene mai pagato, vengono pagati solo gli interessi, e questo onere è sostenibile, e persino sensibilmente inferiore rispetto al passato, nonostante l’aumento dello stock di questo debito3.
Lo stesso vale per le argomentazioni secondo cui le cause dell’aumento del deficit di bilancio, che porta all’indebitamento dello Stato, risiedono nelle spese eccessive, che si tratti di investimenti pubblici, spese di funzionamento dello Stato o trasferimenti sociali. In realtà, il problema va ricercato dal lato delle entrate, ovvero nei regali fiscali fatti al capitale e alle famiglie benestanti, che hanno raggiunto proporzioni senza precedenti dall’inizio della presidenza Macron – i suoi predecessori, in particolare François Hollande (riduzione continua degli “oneri” sulle imprese e della tassazione del capitale, CICE4 ecc.), si erano già incamminati su questa strada5.
Questa contro-analisi è tanto pertinente sul piano sostanziale quanto politicamente necessaria di fronte al discorso dominante, incessantemente ripreso dai media e dai portavoce del potere. Limitandosi a questo, si rischia tuttavia di trascurare la logica interna del discorso di Bayrou, che non è una semplice mistificazione ideologica, ma un progetto politico coerente, che va ben oltre la sua persona e ha conseguenze del tutto concrete.
Questo progetto ha un nome, è l’Unione europea, le regole e le procedure su cui si basa, e si inserisce nelle tendenze a più lungo termine del capitalismo contemporaneo: la crisi dello Stato keynesiano del dopoguerra e la sua rimodellazione da parte del neoliberismo e della finanziarizzazione. Il sociologo tedesco Wolfgang Streeck ha definito questa trasformazione come un passaggio dallo Stato fiscale del periodo precedente, orientato alla ridistribuzione e al mantenimento del compromesso sociale fordista del dopoguerra, allo Stato-debito, che si basa su un regime istituzionalizzato di consolidamento fiscale volto a porlo sotto la sorveglianza permanente dei mercati finanziari6.
All’origine di questo processo c’è la “crisi fiscale dello Stato” innescata dalla crisi degli anni ’707, con un calo delle entrate (conseguenza meccanica del calo della crescita) e il mantenimento di un livello elevato – e, in un primo momento, addirittura un aumento – della spesa a causa della relativa rigidità degli “stabilizzatori automatici” keynesiani volti a far fronte all’aumento della disoccupazione e agli effetti recessivi di un contesto inflazionistico. Il debito pubblico, mantenuto a un livello molto basso fino all’inizio degli anni ’80, ha quindi iniziato la sua curva ascendente a livello mondiale.
La risposta neoliberista a questa crisi si è basata sulla “rivolta fiscale” congiunta del capitale, che doveva far fronte a un calo della sua redditività, e delle classi agiate, che mettevano in discussione il patto redistributivo del dopoguerra e puntavano alla privatizzazione neoliberista delle condizioni di riproduzione sociale. Essa si è amplificata con il duplice movimento della “globalizzazione” e della finanziarizzazione, che ha liberato i movimenti di capitali e ha incoraggiato il dumping fiscale tra gli Stati. L’ascesa della finanza si è a sua volta alimentata della speculazione sul debito pubblico, dell’indebitamento delle famiglie, che controbilancia il ritiro dello Stato sociale (nell’istruzione, nella sanità, nell’accesso alla casa, nelle pensioni, ecc.) e della stagnazione dei salari, per quel che riguarda la massa dei lavoratori dipendenti.
Il “consolidamento di bilancio” si presenta quindi come uno strumento volto a “rafforzare la fiducia”, ovvero a rendere lo Stato attraente per i mercati finanziari assicurando loro che è in grado di rispettare le promesse legate al proprio debito. I mercati finanziari vogliono avere la certezza che il debito pubblico sia effettivamente posto sotto il controllo politico, il che deve essere dimostrato con la capacità dei governi di arrestarne la crescita a lungo termine o, addirittura, invertire il trend.
In un contesto di dumping fiscale tra Stati, che impedisce qualsiasi aumento della tassazione del capitale, e quindi dell’incremento delle entrate, tale consolidamento opera inevitabilmente attraverso la continua compressione della spesa pubblica, in particolare della spesa sociale. La dinamica di deregolamentazione e privatizzazione continua dei beni pubblici alimenta così la trasformazione dello Stato sociale (welfare State) in uno Stato che mira a disciplinare la forza lavoro (workfare State)8.
Questa svolta autoritaria e repressiva è raddoppiata dalla spoliazione democratica insita nel meccanismo stesso del consolidamento fiscale. La sua istituzionalizzazione implica che lo Stato mostri una volontà incrollabile nel far passare i propri obblighi nei confronti dei creditori prima di tutti gli altri. Ciò richiede una configurazione dei rapporti di forza politici che rende difficile qualsiasi aumento della spesa e facilita i tagli di bilancio, ad eccezione delle spese legate alla gestione del debito e di quelle cosiddette “sovrane” (difesa, polizia, ecc.).
Come sottolinea Streeck, uno Stato di questo tipo “interiorizza in maniera irremovibile il primato dei propri impegni nei confronti dei creditori rispetto agli impegni pubblici e politici nei confronti dei cittadini. [Questi ultimi] sono subordinati agli investitori, i loro diritti sono soppiantati dalle rivendicazioni derivanti dai contratti commerciali. […] I risultati delle elezioni sono meno importanti di quelli dei mercati obbligazionari, l’opinione pubblica conta meno dei tassi di interesse e i servizi legati al debito hanno la precedenza sui servizi pubblici”9.
È facile osservare che l’Unione europea è stata il vettore fondamentale della costruzione di un tale regime di consolidamento in un’area geografica in cui i rapporti di forza ne rendevano l’attuazione più difficile che nel mondo anglo-statunitense. Le sue tavole della legge sono state enunciate nei famosi “criteri” istituiti dal Trattato di Maastricht e rafforzati dai trattati e dai patti che sono seguiti: deficit di bilancio e debito pubblico limitati, rispettivamente, al 3% e al 60% del PIL, priorità accordata al controllo dell’inflazione.
Questi criteri non sono il risultato di una semplice scelta ideologica: mirano a rendere credibile a livello internazionale l’idea di un euro forte, ovvero una moneta unica senza precedenti nella storia, poiché non è sostenuta dalla banca centrale di uno Stato unificato e non dispone quindi delle capacità di intervento della Fed statunitense, alla quale viene spesso paragonata. Da qui l’ossessione per l’ortodossia ordoliberale, che aveva già assicurato al marco il suo status di moneta forte, in contrapposizione al franco, soggetto a frequenti svalutazioni.
Questo è anche il motivo per cui la banca centrale in questione è allo stesso tempo “indipendente”, ovvero esente da qualsiasi controllo politico (che è il segno distintivo delle istituzioni europee), e vincolata a un unico mandato, il controllo dell’inflazione entro un limite massimo del 2%. Il suo statuto vieta agli Stati di ricorrere al debito interno, rendendo impossibile qualcosa come il “circuito del Tesoro” che, tra la Liberazione e la fine degli anni ’60, ha permesso allo Stato francese di finanziarsi senza ricorrere ai mercati.
Con la moneta unica, gli Stati dell’area dell’euro sono ora tenuti a finanziarsi sui mercati internazionali e, per farlo, a dimostrare continuamente la loro conformità ai vincoli di consolidamento macroeconomico codificati nei trattati europei. Certo, dalla crisi del 2015, la BCE interviene (e in modo massiccio tra il 2015 e il 2022) sul mercato secondario del debito pubblico degli Stati membri dell’UE. È la politica di “allentamento monetario” che ha consolidato il calo dei tassi, e quindi del costo del prestito per gli Stati.
Questo ha permesso di “vendere” questa politica all’opinione pubblica come un alleggerimento della pressione che i mercati finanziari esercitano sugli Stati attraverso il meccanismo del debito. In realtà, l’obiettivo della BCE era ben diverso, ovvero fornire liquidità ai mercati finanziari garantendo una forte domanda di titoli di debito pubblico. Pertanto, oltre al carattere temporaneo di questa misura, non è messo in discussione il ruolo decisivo del mercato primario, poiché gli interventi della BCE sono ben lontani dal soddisfare tutte le esigenze di finanziamento degli Stati.
Così, tra il 2015 e il 2022, cioè al culmine di questa politica di riacquisto, la BCE ha acquistato solo l’equivalente del 48% del debito emesso dalla Francia, e attualmente detiene (tramite la Banca di Francia) meno di un quarto del debito francese, una percentuale che sta rapidamente diminuendo dalla fine del “quantitative easing” e dal ritorno a una politica di aumento dei tassi di interesse. Attualmente, la maggior parte dei titoli di debito pubblico francese (il 54,7% secondo i dati del 2025) è detenuta da “residenti stranieri”.
La composizione di questo gruppo è particolarmente opaca, poiché protetta dall’anonimato del Codice di commercio, ma si tratta essenzialmente di “investitori istituzionali” (banche, fondi pensione, fondi assicurativi, fondi di investimento sovrani e altri fondi speculativi) che per definizione tengono un comportamento opportunistico, ovvero estremamente sensibile al minimo movimento dei “mercati”. Lungi dal contrastare l’influenza dei mercati sugli Stati, la BCE continua così ad agire come loro fedele sostenitrice, adeguando la propria politica ai cicli di accumulazione del capitale.
Dalla crisi degli anni 2010-2015, il regime di consolidamento imposto dall’UE si è in realtà irrigidito. L’effimero allentamento del periodo Covid, durante il quale le regole dei Trattati erano state sospese, aveva portato alcuni eurofili incalliti a dichiarare la fine del corsetto dell’austerità10.
In forma attenuata, tali illusioni si erano diffuse anche a sinistra. Ne è testimonianza, in particolare, il programma della NUPES del 2022, che affermava (nel suo capitolo 8) che “il contesto di messa in discussione delle regole europee di fronte alle emergenze gioca a nostro favore”. Si attribuiva così una parvenza di credibilità al mantra della “rinegoziazione dei trattati europei” che avrebbe permesso di “modificare in modo duraturo le regole incompatibili con la nostra ambizione sociale ed ecologica legittimata dal popolo”. Una proposta destinata in anticipo a rimanere incantatoria, poiché, come tutti sanno, per cambiare anche solo una virgola dei trattati in questione è necessaria l’unanimità degli Stati membri.
Del resto, una volta superato il contesto della pandemia, le leggi intangibili scolpite nella pietra dei trattati hanno subito ripreso il sopravvento, e persino in forma inasprita. In realtà, il processo era iniziato già con la crisi dell’eurozona degli anni 2010-2015. L’adozione di una serie di dispositivi – chiamati nel gergo dell’UE “Six Pack”, “Two Pack” e “semestre europeo” – ha permesso di aumentare la sorveglianza delle politiche di bilancio da parte delle autorità di Bruxelles, rafforzando in particolare l’automaticità delle sanzioni e sistematizzando l’attuazione di piani di aggiustamento strutturale per i Paesi che affrontano difficoltà finanziarie, sul modello di quanto è stato fatto per la Grecia.
Nell’ambito dell’attuazione di questi programmi, è prevista l’introduzione di un regime di “sorveglianza rafforzata” fino al rimborso del 75% del debito. All’inizio del 2024, l’adozione del “patto di stabilità e crescita riformato” ha segnato definitivamente la fine della parentesi “spendacciona” degli anni del Covid e il ritorno dell’austerità: i Paesi con un disavanzo di bilancio superiore al 3% dovranno ridurlo di almeno 0,5 punti percentuali del PIL all’anno. Inoltre, gli Stati membri con un debito compreso tra il 60 e il 90% del PIL dovranno ridurlo di 0,5 punti all’anno, mentre quelli con un debito superiore al 90% dovranno ridurlo di 1 punto all’anno.
Certo, formalmente, i trattati e i patti dell’UE non si oppongono all’aumento della tassazione del capitale e dei più ricchi. Tuttavia, in virtù delle famose “libertà” che guidano l’integrazione europea sin dalla sua fondazione11, essi sanciscono la libera circolazione di beni, servizi e capitali. In pratica, ciò significa che se il governo di uno Stato membro aumenta le imposte sul capitale, quest’ultimo può (minacciare di) trasferirsi nel Paese vicino senza perdere l’accesso al mercato del Paese che sta per lasciare (grazie alla libera circolazione di beni e servizi). Pertanto, la combinazione delle regole di bilancio e dei principi della “libera concorrenza senza distorsioni” porta a una situazione che non lascia altra opzione per l’aggiustamento di bilancio se non la riduzione della spesa. I trattati e il patto dell’UE istituzionalizzano quindi la paralisi fiscale, mettendo in atto meccanismi che si applicano in modo permanente, anche in assenza di pressioni da parte dei mercati finanziari12.
Come l’uccello di Tex Avery, l’UE è condannata a ripetere all’infinito il “Beep-beep” dell’austerità e dell’ortodossia neoliberista inscritta nei suoi trattati fondatori. Solo che in questo caso, lungi dall’essere priva di significato, questa ripetizione non è al servizio di un meccanismo psichico inconscio, ma di interessi di classe perfettamente identificabili. E comporta conseguenze ben più gravi delle cadute fragorose da cui il Coyote esce sempre indenne, cioè la sanzione dei “mercati” e del loro tramite interno all’UE: la BCE di Francoforte.
La Grecia ne è stata l’esempio più drammatico, ma ricordiamo che anche gran parte della periferia europea (Spagna, Portogallo, Irlanda, Cipro) ne ha pagato le conseguenze. La recente dichiarazione di Christine Lagarde, in qualità di presidente della BCE, è, a questo proposito, molto chiara per chi sa decodificare questo tipo di linguaggio: “I rischi di caduta dei governi in tutti i Paesi della zona euro sono preoccupanti. Quello che ho potuto osservare in sei anni [in questa posizione] è che gli sviluppi politici, il verificarsi di rischi politici, hanno un impatto evidente sull’economia, sulla valutazione che i mercati finanziari fanno dei rischi-Paese e, di conseguenza, sono preoccupanti per noi”. La Francia di oggi non è certamente la Grecia del 2015, ma non è nemmeno un caso del tutto diverso, esentata grazie a qualche miracolo della sua “grandeur” dai vincoli a cui la sua classe dominante e il personale politico al suo servizio l’hanno sottomessa ormai da decenni.
La corsa all’austerità di Barnier e Bayrou
Questo punto di vista getta una nuova luce sugli eventi francesi dell’ultimo anno. Il fatto è stato poco commentato, ma è fondamentale: per sostenere il suo rifiuto del risultato delle elezioni legislative di giugno-luglio 2024, Macron ha nominato successivamente a Matignon13 due personalità di destra, Michel Barnier e François Bayrou, che condividono una fedeltà assoluta al quadro europeo. Il primo è un ex membro della Commissione di Bruxelles e suo rappresentante nei negoziati sulla Brexit con il governo britannico.
Il secondo, un fanatico del progetto europeo, ha fatto della radicalizzazione dell’ortodossia di bilancio di Maastricht il suo marchio di fabbrica, proponendo, fin dalla sua campagna presidenziale del 2007, l’inserimento nella Costituzione del divieto, per qualsiasi governo, di presentare, al di fuori dei periodi di recessione, un bilancio in deficit. Ha così anticipato di due anni la costituzionalizzazione di questa cosiddetta “regola d’oro” da parte della Germania, che ne aveva già enunciato il principio nella “Legge fondamentale” che le funge da Costituzione dal 1949, e la sua ripresa a livello dell’intera UE nel patto di bilancio europeo (TSCG) del 2012.
La scelta del di queste figure può essere compresa solo se si tiene conto della decisione, annunciata già nel giugno 2024, della Commissione europea di avviare, in conformità con le prescrizioni del patto di crescita riformato, una procedura contro la Francia per il superamento delle soglie di disavanzo di bilancio e di debito pubblico. Come precisato nel documento ufficiale del governo del dicembre 2024, “la Commissione europea ha fissato un percorso di riferimento impegnativo: un aggiustamento strutturale che rappresenta in media 0,6 punti di PIL all’anno nel periodo”.
Ancor prima della nomina di Michel Barnier, Macron aveva assicurato la continuità della politica economica mantenendo al comando il trio di alti funzionari del ministero delle Finanze, vicini al segretario dell’Eliseo Alexis Kohler, che hanno portato avanti le linee guida della politica economica sin dall’inizio del suo primo mandato. Il rapporto con l’Unione europea e il suo regime di consolidamento di bilancio sono al centro di questa continuità.
Secondo le parole di un ex ministro riportate da Le Monde nel settembre 2024, “le loro invarianti [di questi alti funzionari] si riassumono in due punti: rassicurare Bruxelles e collocare il debito a condizioni vantaggiose, indipendentemente dalle contingenze. Sanno come farlo, hanno tutte le reti e i contatti necessari per farlo”. Un bell’esempio della classica tesi marxista della continuità dell’apparato statale al di là dei cambiamenti di governo, e persino di regime politico, che caratterizza lo Stato capitalista14!
La corsa a conformarsi al rigido regime di austerità dell’UE è quindi al centro della crisi politica francese. È ragionevole pensare che questo dato abbia influito sulla decisione di Macron di sciogliere l’Assemblea dopo la debacle del suo schieramento alle elezioni europee del giugno 2024. L’eventualità di un governo RN15, che Macron riteneva la più probabile al momento dello scioglimento e che non avrebbe avuto altra scelta che attuare lo shock di austerità raccomandato da Bruxelles, per poi pagarne il prezzo, poteva sembrare un calcolo razionale in vista del 2027.
Il risultato delle elezioni legislative, con l’arrivo in testa all’Assemblea del NFP16, ha costretto a un cambiamento di approccio. Naturalmente, non è mai esistita la possibilità che la persona indicata dall’alleanza di sinistra vincitrice (per numero di seggi) alle elezioni per l’Assemblea potesse ricevere un mandato per Matignon. L’obiettivo era quello di guadagnare tempo, garantire la continuità di un macronismo diventato nettamente minoritario e, per farlo, cercare di rompere l’alleanza di sinistra, “ottenere lo scalpo del NFP”, come aveva ben intuito Olivier Faure nell’agosto 2024, prima di consegnare egli stesso lo scalpo in questione sei mesi dopo, rifiutandosi di votare la mozione di censura contro il governo Bayrou.
Più che portatori di un vero mandato di governo, che avrebbe comportato come minimo un programma degno di questo nome, una linea politica coerente e approvata dall’elettorato (ricordiamo che, a differenza del NFP, il mal denominato “socle commun”17 non si è mai presentato alle urne come tale), Barnier e Bayrou sono in realtà semplici funzionari. Il loro compito consiste nell’attuare il più rapidamente possibile la terapia di austerità prevista dal quadro europeo, aggravata dalla corsa alla militarizzazione avviata dall’UE dall’inizio della guerra in Ucraina.
Per portare a termine questo “sporco lavoro”, personalità prive di una reale legittimità politica, e persino di una base parlamentare, sono di gran lunga preferibili a governi che devono rendere conto agli elettori. I precedenti della Grecia e dell’Italia del 2011, quando l’UE ha direttamente organizzato la caduta di Georges Papandréou e Silvio Berlusconi, sostituiti da due banchieri (rispettivamente Lucas Papademos e Mario Monti) alla guida di coalizioni eterogenee e vacillanti, sono istruttivi a questo proposito.
Dall’estate scorsa, e dalla messa sotto stretta sorveglianza della Francia, la sua politica di bilancio non fa altro che conformarsi al “pilota automatico” previsto dal “patto di crescita” dell’UE, ovvero una “traiettoria” di tagli di bilancio equivalenti a una riduzione del deficit di almeno lo 0,5% del PIL. I “rapporti annuali sullo stato di avanzamento” inviati ogni anno in aprile dal governo francese a Bruxelles non hanno solo lo scopo di descrivere in dettaglio lo stato di avanzamento del Piano di bilancio e strutturale a medio termine (PMST) per il periodo 2025-2029, ovvero, come annunciato nel documento ufficiale dello scorso aprile, di “presentare una traiettoria di bilancio che rispetti i requisiti delle nuove regole di bilancio europee, nonché delle riforme e degli investimenti a lungo termine, giustificando un prolungamento del periodo di aggiustamento di bilancio da quattro a sette anni”.
Ma esistono delle sfumature tra i due team che si sono succeduti a Matignon: come spiegano gli studi (qui e qui) dell’Institut Avant-Garde, Michel Barnier ha voluto essere veramente zelante, prevedendo un “aggiustamento più ambizioso di quanto richiesto dalle norme di bilancio europee e [che] comprendeva uno sforzo significativo all’inizio del periodo volto a ridurre il deficit pubblico al 5% nel 2025”. Il piano di Bayrou segna un ritorno alla “normalità” prevista dai patti: “rinuncia a concentrare gli sforzi all’inizio del periodo e si adatta maggiormente alla forma di aggiustamento lineare definita dalle regole di bilancio dell’UE. Nell’insieme, però, la correzione del bilancio per il periodo dei sette anni, 2025-2031, rimane invariato”. L’obiettivo di riduzione del deficit di bilancio per il 2025 è stato ridotto da Bayrou dal 5,4% al 5% – ovvero da 1,4% a 0,8% del PIL – ma è superiore a quello di Barnier per l’anno successivo (0,9% invece di 0,6%). Si può pensare che Bayrou fosse convinto che questo “allentamento” potesse essere sufficiente per rinnovare, con alcune concessioni cosmetiche (in particolare sulla soppressione dei giorni di ferie), il riconoscimento del PS che gli ha permesso di accedere a Matignon. Si confermerebbe così una ricomposizione politica che vedrebbe il blocco borghese aggiungere una nuova componente, rinnovando così l’operazione fondatrice dell’“estremo centro” macronista: la convergenza, sotto il segno della riforma neoliberista e dell’alleanza europea, del “social-liberismo” e della destra liberale. Ma, agli occhi dell’attuale potere e dei suoi alleati, sembra che questo obiettivo possa essere raggiunto con altri mezzi, cioè senza un Bayrou ormai logoro e a corto di cartucce.
Un Coyote rinnovato: verso una ricomposizione del blocco borghese?
Esprimendosi il 26 agosto sul quotidiano dei circoli imprenditoriali, Patrick Martin, presidente del Medef, ha avuto il merito di essere chiaro e lucido: “Quel che è certo è che il Partito socialista rimane il perno in questa vicenda”. Il seguito ha dato ragione a lui e torto a coloro che pensavano (e fingono di credere) che l’accordo di febbraio tra il PS e il blocco macroniano fosse solo una scappatella momentanea, che si sarebbe potuta superare rapidamente con lirici richiami all’“unità”.
Come riporta Le Monde, la linea che Macron ha presentato davanti ai rappresentanti delle formazioni che lo sostengono è chiara: si tratta di “lavorare con i socialisti” per preparare il dopo-Bayrou. Gabriel Attal, segretario generale del partito macronista Renaissance, è dello stesso avviso: “Qualunque sia l’esito dell’8 settembre, è imperativo sedersi al tavolo con le forze politiche disposte a lavorare per un compromesso”. Tuttavia, come precisa lo stesso articolo, “l’iniziativa presidenziale ha ricevuto un’accoglienza favorevole da parte di Olivier Faure. (…) A Blois [dove si è tenuta l’università estiva del PS lo scorso agosto], durante un pranzo con la stampa, il leader del PS ha teso la mano al blocco centrale: ‘Non stiamo cercando di realizzare il programma dei nostri sogni. Dobbiamo cercare di costruire un progetto che possa trovare una maggioranza’”.
L’obiettivo condiviso è quindi quello di evitare lo scioglimento, cercando “compromessi” che siano capaci di avanzare più in là degli “allentamenti” previsti da Bayrou senza mettere in discussione l’aggiustamento strutturale in quanto tale. Raphaël Glucksmann è stato ancora più chiaro di Faure all’uscita dal suo colloquio con Macron: si tratta di avviare un “vero processo di negoziazione” che “l’annuncio del voto dell’8 settembre” ha purtroppo reso impossibile.
La sindaca di Nantes Johanna Rolland, esprimendosi su Mediapart in qualità di prima segretaria delegata del PS, è sulla stessa lunghezza d’onda: “far pensare che lo scioglimento sia l’ipotesi che risolverebbe la situazione del Paese è un inganno”. Si tratta di “governare ora”, con una squadra che andrebbe “da Glucksmann a Ruffin” e che cercherebbe “maggioranze caso per caso”. Le possibilità che l’attuale inquilino dell’Eliseo accetti questo tipo di scenario sono nulle. Ma l’obiettivo reale non è tanto quello di permettere la nascita di un governo di questo tipo, quanto quello di incoraggiare una ricomposizione politica “centrista” che possa durare fino alle prossime presidenziali.
Questo è lo scopo del “bilancio alternativo” presentato dal PS (senza il minimo riferimento, va precisato, al programma del NFP, né alcuna discussione preliminare con altre formazioni di sinistra, comprese quelle con cui afferma di voler governare) : dimezzare il livello dell’aggiustamento strutturale equivale più o meno a fissare la soglia minima prevista dal patto di bilancio europeo (cioè mezzo punto di PIL all’anno) e a chiedere un anno supplementare (2032 invece di 2031) per riportare il deficit al di sotto della soglia fatidica del 3%. Nella conferenza stampa al termine dell’università estiva del PS, Faure è stato molto preciso su questo punto: “Gli equilibri sono inemendabili, salvo dire che non si può governare”.
Stesso discorso da parte della senatrice del Val-de-Marne Laurence Rossignol: “Lo spirito di questo piano […] è quello di proclamare che ‘sì, condividiamo l’idea che sia necessario un percorso di riduzione del deficit’”. Alcune misure largamente simboliche come la tassa Zucman – di cui alcuni dirigenti del partito lasciano già intendere che l’importo potrebbe essere rivisto al ribasso – o la revisione di alcune nicchie fiscali per le imprese, ma a beneficio delle “microimprese e PMI innovative” (la start-up nation non è molto lontana), danno l’illusione della giustizia fiscale.
Ricordiamo che questa tassa Zucman al 2% dovrebbe fruttare 15 miliardi, da mettere a confronto con i 153 miliardi di profitti, i circa 70 miliardi di dividendi distribuiti agli azionisti e i 30 miliardi di riacquisti di azioni realizzati dalle imprese del CAC 40 solo nel 2023, “importi senza precedenti” come sottolinea Le Monde. Allo stesso modo, i 7,5 miliardi di entrate supplementari attese dalla “riforma della fiscalità sui dividendi e sulle plusvalenze”, dalla “revisione delle esenzioni dai contributi sociali per le imprese” e dal “contributo GAFAM” sono da confrontare con gli oltre 200 miliardi di aiuti pubblici annuali alle grandi imprese, secondo i calcoli effettuati nella relazione dei senatori Fabien Gay (PCF) e Olivier Rietmann (LR), ovvero, per l’anno 2023, miliardi di sovvenzioni, 75 miliardi di sgravi contributivi e 88 miliardi di agevolazioni fiscali. In altre parole, l’“altro bilancio” del PS non rompe in alcun modo con la logica di detassazione del capitale messa in atto dai governi che si sono succeduti – e garantita dai trattati europei – da diversi decenni.
Quanto alle misure apparentemente più audaci, esse sono più che altro un effetto annuncio: la “sospensione” della riforma delle pensioni mira solo a rilanciare il “dialogo tra le parti sociali” per “trovare le condizioni durature per il suo finanziamento”. In altre parole, si tratta di ripetere l’operazione del “conclave”, il principale alibi invocato dal PS per giustificare il suo rifiuto di censurare il governo Bayrou. Conclave che ha portato al fiasco che conosciamo, ma che ha permesso al macronismo di guadagnare tempo prezioso, con il sostegno delle direzioni sindacali.
Un’altra pseudo-misura “di sinistra”, il cosiddetto “aumento dei salari bassi”, dovrebbe essere realizzata attraverso una riduzione della CSG, ovvero un prosciugamento delle risorse della protezione sociale, in una logica tipicamente neoliberista. Secondo le ripetute dichiarazioni dei responsabili socialisti, riportate da Les échos, “non si tratta di un piano di terribili sinistroidi”. Come sottolinea Julie Cariat su Le Monde, “l’altro progetto per la Francia” del PS sembra già uno strumento per il dopo-Bayrou e le sue future trattative di governo.
Va inoltre sottolineato un ulteriore e fondamentale punto di convergenza tra il potere macroniano e il PS: quello dell’aumento dei bilanci militari, avviato già durante il primo mandato di Macron, ma che sta accelerando in modo vertiginoso dall’inizio della guerra in Ucraina. Esso è stimolato dall’adozione da parte della Commissione europea del piano ReArm Europe, che prevede una spesa supplementare di 800 miliardi di euro entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati sono persino autorizzati a derogare alla regola del 3% di deficit di bilancio, fino all’1,5% del loro PIL per un periodo di 4 anni: l’austerità non andrà a toccare il complesso militare-industriale.
Per quanto riguarda la Francia, secondo esportatore mondiale di armi e la cui industria della difesa è praticamente tutto ciò che resta di significativo in un tessuto industriale ormai a brandelli, le cifre fanno girare la testa: tra l’inizio del mandato di Macron e l’anno in corso, le spese militari (escluse le pensioni) sono passate da 32 a 50 miliardi, con un aumento di oltre il 55% (e un aumento dall’1,8% al 2,06% del PIL), pari all’80% dei risparmi previsti dal bilancio alternativo del PS. Secondo la legge di programmazione militare per un importo di 413 miliardi adottata nel luglio 2023 da tutti i partiti rappresentati all’Assemblea, ad eccezione di LFI e PCF, che hanno votato contro, e degli Ecologisti, che si sono astenuti, si prevede di portare la spesa a 68 miliardi nel 2030 (pari al 2,6% del PIL). Ma si parla di rivedere questa cifra al rialzo per raggiungere un “giusto peso di bilancio” di 90 miliardi di euro e l’obiettivo del 3% del PIL, come ha evocato Sébastien Lecornu lo scorso marzo.
Su questo terreno, il consenso è reale in tutto il campo atlantista, che va dal RN ai Verdi. Dopo aver votato il vertiginoso aumento dei bilanci militari, il PS ha applaudito calorosamente il piano ReArm Europe, con Olivier Faure che ha dichiarato “di ritrovarsi perfettamente” nelle parole di Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen sulla difesa europea. Più esitanti e divisi sull’aumento dei bilanci della difesa, i Verdi non hanno tuttavia mancato – con una decisione del loro Consiglio federale – di acclamare calorosamente il piano ReArm Europe e l’idea di una difesa, e persino di un esercito, europeo. Da parte sua, Marine Tondelier ha dimostrato di saper usare un linguaggio marziale quando ha invitato a unirsi alla (presunta) unanimità dietro Macron per affrontare la minaccia russa e difendere l’Ucraina.
La situazione è quindi cambiata. “L’Europa, ci assicuravano, è la pace”. Ora sappiamo che al blocco delle politiche neoliberiste e alla spoliazione democratica dobbiamo aggiungere la militarizzazione e il bellicismo.
Le condizioni politiche della risposta
Si capisce meglio quindi il senso dei suoi appelli all’“unità”, per un “governo [che va] da Ruffin a Glucksmann” nelle parole del segretario del PS. Si tratta semplicemente di un’unità fondata sull’esclusione di LFI e la cui vera posta in gioco non è tanto la (molto improbabile) candidatura “unitaria” della sinistra (e anche di quella parte della sinistra) nel 2027, quanto piuttosto seppellire ogni politica di rottura.
Come credere allora a una possibile ricostituzione del NFP quando una delle sue componenti – la seconda per dimensioni del suo gruppo parlamentare – ha rotto questa alleanza per consentire a un macronismo minoritario di aggrapparsi al potere e si dichiara pronta a proseguire su questa strada? Come giustificare la denominazione “Front populaire 2027”, presentato pubblicamente durante una riunione pubblica a Bagneux all’inizio di luglio e approvato poco dopo da una risoluzione dell’ufficio nazionale del PS, quando si basa sull’esclusione della forza che è in testa ai gruppi eletti con l’etichetta «Nuovo Fronte Popolare» all’Assemblea? Dopo lo scioglimento della NUPES e del NFP, quale credibilità politica può avere l’ennesimo rattoppo elettorale “unitario” che, agli occhi dei dirigenti del PS, si è rivelato un calcolo cinico che ha permesso di guadagnare seggi per poi cambiare casacca subito dopo e fungere da stampella a un potere agonizzante?
Alain Bertho ha giustamente invitato a tenersi “lontani da iniziative ‘unitarie’ che moltiplicano le unità parziali e gli anatemi mirati, nel tempo sospeso delle strategie presidenziali”. Tuttavia, il problema strategico che si pone alla sinistra, e in particolare alla sinistra di rottura riunita attorno a LFI, è evidente e, tanto vale dirlo chiaramente, nessuna soluzione sembra attualmente a portata di mano.
Questo fallimento strategico rimanda a una questione di fondo: che senso può avere un “programma di rottura” che non assume il compito di rompere con il quadro dei patti europei e del regime di “sorveglianza rafforzata” da parte della Commissione di Bruxelles? Che senso può avere la pretesa “unitaria” di un programma “di rottura” se ci si allinea alla militarizzazione, all’atlantismo e al bellicismo? Si può capire che nell’autunno dello scorso anno i gruppi parlamentari del NFP, con LFI in testa, abbiano voluto fare opera di pedagogia e dimostrare che un’ipotesi di governo NFP era legittima, denunciando così la negazione della democrazia perpetrata da Macron. Hanno quindi messo in evidenza il voto in Assemblea degli emendamenti fiscali che avrebbero permesso di recuperare 50 o 60 miliardi, ovvero l’equivalente dei tagli previsti dal bilancio Barnier. Il progetto di “bilancio alternativo” del PS riprende del resto alcune delle proposte per cui la sinistra ha lottato all’Assemblea, in particolare la tassa Zucman. Si è potuto parlare così di un “bilancio compatibile con il NFP”, secondo le parole del presidente della Commissione Finanze di LFI Eric Coquerel. Ma, come era del tutto prevedibile, il bilancio è stato ampiamente respinto dall’Assemblea. Il problema con questo tipo di esercizio pedagogico è tuttavia che, dimenticando troppo i propri limiti, si rischia di perdere l’essenziale, ovvero l’impossibilità di attuare politiche di rottura con il quadro neoliberista nel contesto della rigida ortodossia di bilancio e, più in generale, dei trattati – ai quali ora si aggiungono i piani di militarizzazione – di cui l’UE è promotrice e gelosa custode.
Alla fine, tutta la questione si riduce a quella della “disobbedienza” a questi trattati. I negoziati per l’elaborazione del programma della NUPES del 2022, che si erano svolti – grazie ai rapporti di forza stabiliti a sinistra al primo turno delle elezioni presidenziali – nelle condizioni più favorevoli alle posizioni “di rottura” sostenute da LFI, avevano dimostrato che la linea di demarcazione all’interno della stessa sinistra passava proprio da lì. Lo dimostrano le contorsioni delle formulazioni finali del programma. Si precisa infatti che “se alcune regole europee sono punti di appoggio, oggi tutti constatano quanto altre, e non da meno, siano in contrasto con le esigenze dell’emergenza ecologica e sociale e costituiscano seri ostacoli all’attuazione del nostro programma”.
L’elenco che segue è lungo e riguarda quasi tutti gli assi del programma: trattati di libero scambio, applicazione della “concorrenza libera e non falsata” ai servizi pubblici e ai beni comuni, modello produttivista e agroindustriale della PAC, statuto della BCE e regole di austerità di bilancio del “semestre europeo”, libera circolazione dei capitali che “ci impedisce di controllare un settore finanziario sempre più aggressivo e dannoso”. Cosa fare allora per non lasciarsi rinchiudere in questa gabbia di ferro?
Una delle formulazioni più aspramente dibattute di questo accordo è stata quella che consisteva nel dire che “dovremo essere pronti a non rispettare alcune regole [sottolineato nel testo]. A causa delle nostre storie, alcuni parlano di disobbedienza, altri di deroga transitoria, ma puntiamo allo stesso obiettivo: essere in grado di applicare pienamente il programma condiviso di governo e rispettare così il mandato che ci sarà stato conferito dai francesi”. “Disobbedienza” o “deroga transitoria”, al di là della terminologia, le misure concretamente previste rientrano essenzialmente nel quadro di un’impossibile “rinegoziazione” dei trattati o di una ancora più utopistica “Convenzione europea per la revisione e la riscrittura dei trattati europei, costruita con i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo”, le cui conclusioni sarebbero poi sottoposte a referendum a livello degli Stati membri.
È facile immaginare il sarcasmo che tali affermazioni allucinanti susciterebbero negli attuali governanti europei se giungessero alle loro orecchie. Più sobrio, il programma del NFP ripete lo stesso tipo di acrobazie, affermando, da un lato, di “rifiutare il patto di stabilità di bilancio”, mentre dall’altro elenca una lunga serie di “piani” e dispositivi (“per l’emergenza sociale e climatica”, di “reindustrializzazione dell’Europa”, “protezionismo ecologico e sociale alle frontiere dell’Europa”, tassazione dei ricchi “a livello europeo per aumentare le risorse proprie del bilancio dell’UE”) concepiti per essere realizzabili solo a livello dell’UE. In altre parole, si tratta solo di formule magiche prive di significato.
Tuttavia, questo capitolo “Europa” si conclude con un impegno modesto ma che ha il merito di una certa chiarezza: “rifiuteremo, per l’applicazione del nostro contratto di legislatura, il patto di bilancio, il diritto della concorrenza quando mette in discussione i servizi pubblici e respingeremo i trattati di libero scambio”. Questo impegno minimo si è tuttavia rivelato inaccettabile per il PS, che, come indica il suo progetto di “bilancio alternativo” (e prima ancora il suo accordo di non censura con Bayrou), si è affrettato a dimostrare la sua volontà di conformarsi al patto di bilancio qui respinto – un patto i cui vincoli, come abbiamo dimostrato, si sono nel frattempo ulteriormente rafforzati.
Dobbiamo quindi rassegnarci a questa mancanza di alternative strategiche? No, perché, anche se non può prescindere da essa, la lotta sociale e politica va oltre la logica dei programmi e dei rapporti di forza elettorali. La soluzione va cercata precisamente nel risveglio popolare che si preannuncia per le prossime settimane. L’esperienza lo ha dimostrato: è la mobilitazione popolare che è decisiva per aprire una breccia in situazioni che sembrano senza via d’uscita positiva. A condizione, naturalmente, che si tratti di un impegno a lungo termine e di costruire per questo le forme adeguate. La sfida per il movimento che si sta delineando è quella di dare prova sia di flessibilità che di inventiva.
Il cantiere che si apre è quello di una vera e propria auto-organizzazione popolare, di un’articolazione – che sicuramente non sarà priva di tensioni e difficoltà – tra forme esistenti e forme nuove, iniziative locali o settoriali e strutture flessibili di coordinamento. Questo processo non parte dal nulla, perché prolunga la ricca esperienza dei movimenti molto importanti degli ultimi anni. Mobilitazioni che certamente non hanno ottenuto vittorie, ma hanno permesso a un’intelligenza collettiva e a una volontà di lotta di diffondersi in ampi settori sociali.
La capacità creativa emerge dal popolo quando si lancia in azioni di massa, ma ha anche bisogno di essere alimentata da proposte coerenti e strutturate. Tra queste, le forze della sinistra di rottura, e in particolare LFI, hanno una responsabilità particolare: quella di chiarire le condizioni politiche e programmatiche di uno scontro vittorioso con l’avversario di classe, oggi con il blocco borghese, cioè con il potere macronista e i suoi alleati, dichiarati o ritrosi, e con l’Unione europea, che ne è l’espressione politica tanto più temibile in quanto si afferma come la condensazione della forza coalizzata di tutte le borghesie europee.
- Tra le rare eccezioni segnaliamo questo stimolante articolo Noam Drif, « L’Union européenne, tabou de la gauche à l’heure de la servitude », Le vent se lève, 12 agosto 2025. ↩︎
- NdT: Mouvement démocrate: il partito centrista a cui Bayrou ha dato vita nel 2007. ↩︎
- Cfr. l’editoriale di 5 economisti membri di ATTAC pubblicato il 31 agosto 2015 su Le Monde. ↩︎
- NdT: Credito d’imposta per la competitività e l’impiego. ↩︎
- Si legga la minuziosa analisi di Eric Berr nel blog su Mediapart. ↩︎
- Wolfgang Streeck, Buying Time. The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, Londra e New York, Verso, 2014. ↩︎
- Su questo argomento si veda il classico lavoro dell’economista marxista e teorico dell’ecosocialismo James O’Connor, The Fiscal Crisis of the State, Abingdon, Routledge, 2001 (1a edizione 1973). ↩︎
- Cfr. in particolare Loïc Wacquant, Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale, Marsiglia, Agone, 2004. ↩︎
- Wolfgang Streeck, The Rise of the European Consolidation State, Max Planck Institute for the Study of Societies, Discussion Paper, n. 15/1, Colonia, 2015, p. 17. ↩︎
- Ad esempio, l’eurodeputato macronista Pascal Canfin, che nel maggio 2022 ha dichiarato: «La Commissione ha a lungo privilegiato l’ortodossia di bilancio rispetto agli investimenti pubblici. La sua decisione odierna dimostra che ha operato un’inversione di rotta. Siamo in un’altra Europa», Le Monde, 23 maggio 2022. ↩︎
- Le “quattro libertà” su cui si basa l’integrazione europea sin dal trattato istitutivo di Roma (1957) sono la libera circolazione dei capitali, delle merci, dei servizi e delle persone. In conformità con i principi dell’ordoliberismo, esse dovrebbero garantire la “libera concorrenza”, impedendo la costituzione di situazioni di monopolio o di rendite, e assicurare così il funzionamento del mercato, che lo Stato ha il dovere di garantire. ↩︎
- Ringrazio Benjamin Bürbaumer per queste osservazioni su questo punto essenziale. Cfr. il suo studio scritto in collaborazione con Nicolas Pinsard Benjamin “The corporate welfare turn of state capitalism in France: Reassessing state intervention in the French economy, 1945–2022”, Economy and Society, n° 54. 2, 2025, p. 283-309. ↩︎
- NdT: L’Hôtel de Matignon è la residenza del capo di governo francese. ↩︎
- Nello stesso articolo di Le Monde, il sociologo Pierre Birnbaum, specialista delle élite dello Stato, osserva che “il macronismo è il trionfo dell’alta funzione pubblica, che assume tutte le funzioni dello Stato, comprese quelle politiche”. ↩︎
- NdT: Rassemblement National, partito di estrema destra presieduto da Marine Le Pen. ↩︎
- NdT: Nouveau Front Populaire, alleanza dei partiti di sinistra in vista delle elezioni indette da Macron nel 2024. ↩︎
- NdT: Espressione creata da Michel Barnier al momento della sua nomina a primo ministro, indica la convergenza tra il suo partito Repubblicano e la vecchia maggioranza del presidente Macron. ↩︎