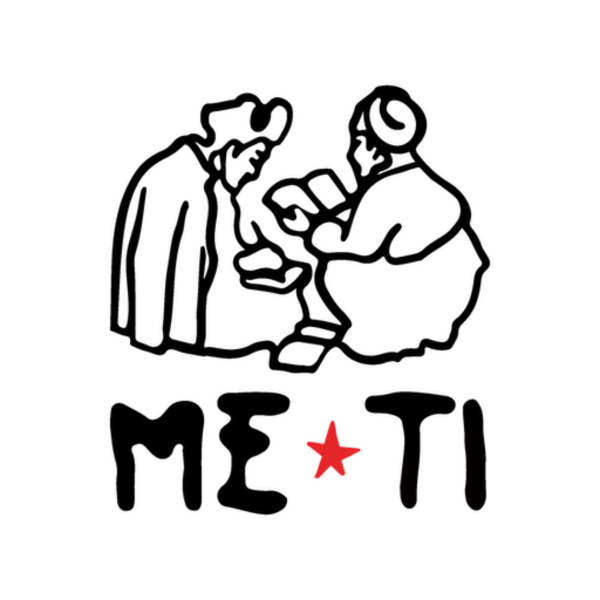Traduciamo un intervento di Wissam Bengherbi e Selim Nadi di Paroles d’honneur pubblicato in lingua francese su QG Décolonial. Questo intervento è stato presentato al meeting “faire bloc, faire peuple” del 4 giugno 2025. “Faire bloc, faire peuple” è il risultato di uno sforzo politico iniziato dopo le elezioni legislative francesi del 10 luglio 2024 che ha visto la vittoria del Nuovo Fronte Popolare con a capo La France Insoumise. Si tratta di un tentativo di creare convergenza politica tra la sinistra radicale e rivoluzionaria e le forze decoloniali e antirazziste – un’unità fondamentale per la ricostruzione di un blocco sociale e politico di rottura con l’ordine stabilito.
Per il 16 novembre 2025 la coalizione chiama a manifestare “contro la guerra e contro lo Stato di guerra”, ricordando tre date fondamentali della storia del recente movimento sociale francese: quello del “no” al Trattato costituzionale europeo (maggio 2005), quello delle rivolte nelle banlieues delle maggiori città del Paese dopo l’uccisione di Zyed e Bouna da parte della polizia (ottobre-novembre 2005) e infine i Gilets Jaunes contro il carovita e la precarizzazione (novembre 2018).
In questo testo si analizza il “mancato incontro” delle due rivolte del 2005 e la centralità, oggi, di “diventare popolo” per cogliere l’occasione nei prossimi mesi considerati un “momento decisivo” per il movimento francese. Dopo la presentazione di un massiccio programma di austerità da parte del Premier francese François Bayrou, è prevedibile che al rientro dalla pausa estiva il movimento sociale francese avvierà un nuovo ciclo di lotte.
***
Il 2005 è stato un anno di una doppia contestazione popolare. Due momenti di rottura, due rabbie, due insurrezioni – separate però da un muro invisibile. Questa doppia rivolta rivela, in forme diverse, lo stesso impedimento strategico: lo Stato razziale e neoliberista, nella sua forma nazionale come nella sua declinazione europea. Uno Stato che non si accontenta di governare, ma che produce attivamente gerarchie di razza e di classe, attraverso le leggi, la scuola, la polizia e ormai anche le istituzioni sovranazionali. Contrariamente a quanto si pensa, non è uno Stato che “dimentica” le periferie o i precari, è uno Stato che li mette ai margini.
Il 29 maggio, la maggioranza dei francesi con un referendum ha respinto il Trattato costituzionale europeo (TCE). Si tratta di un rifiuto massiccio e popolare, un grido contro l’Europa del mercato, della concorrenza, dello smantellamento sociale. Gli operai, i precari, i disoccupati dicono no all’iscrizione in eterno nelle tavole delle leggi dell’ordine neoliberista. È il rifiuto di un trattato che costituzionalizza l’impotenza politica. È un rifiuto più globale di un ordine neoliberista elitario, antidemocratico e autoritario. Questo trattato mirava anche a bloccare permanentemente l’ordine economico europeo contro qualsiasi futura rimessa in discussione, anche da parte dei Paesi dell’ex impero coloniale o dei movimenti sociali guidati dagli eredi dell’immigrazione postcoloniale.
Pochi mesi dopo entra in scena un’altra categoria della popolazione – con un linguaggio completamente diverso. Nei mesi di ottobre e novembre del 2005, dopo la morte di Zyed e Bouna, inseguiti dalla polizia a Clichy-sous-Bois, i quartieri popolari si ribellano. Tre settimane di rivolta. Incendi, scontri, notte dopo notte. I giovani, neri e arabi, discendenti dei dannati della terra, relegati ai margini della Repubblica, si ribellano. È una rivolta contro il disprezzo, il razzismo di Stato, le violenze della polizia e l’umiliazione quotidiana. Una rivolta per la dignità.
Queste due rivolte – quella alle urne e quella nelle strade – miravano, in fondo, a un nemico comune. Ognuna a modo suo, denunciavano lo stesso sistema di dominio: un ordine europeo neoliberista, razzista e imperialista, erede della logica coloniale di gestione del mondo. Un ordine che oggi ricicla queste pratiche nella sua politica migratoria, nei suoi rapporti commerciali con il Sud globale e nel suo controllo dei margini interni. Un ordine che distrugge i diritti sociali in nome della competitività e che gestisce i non-bianchi attraverso la polizia, le frontiere e il carcere.
Eppure questi due popoli non si sono incontrati. Al contrario. Il popolo del “no” non ha parlato al popolo delle rivolte. La sinistra sociale, allora più profondamente rinchiusa nella sua bianchezza rispetto ad oggi, ha osservato le fiamme senza capire. Un’incomprensione che l’ha persino spinta a diffidare, se non addirittura a condannare. Quanto agli abitanti delle banlieues, anche se non erano contrari al “no”, non si sentivano realmente coinvolti nei dibattiti sul TCE. Due rivolte, un unico silenzio.
Ora, è proprio questo silenzio che dobbiamo rompere. Perché qualsiasi strategia popolare seria dovrà assumere una rottura non solo con le politiche dello Stato nazionale, ma anche con le istituzioni europee così come esistono oggi, che strutturano e bloccano l’ordine sociale attuale. Perché questo ordine pesa ancora su di noi. Pesa sulle lotte di oggi. Pesa su qualsiasi strategia politica che pretenda di “fare popolo” senza partire dalle fratture reali del Paese: fratture di classe, ma anche di razza.
Quello che proponiamo qui non è un ritorno nostalgico al 2005. È uno sforzo per trarne insegnamenti strategici. È porre un’ipotesi: e se nel 2025 le lezioni delle lotte popolari degli ultimi anni, insieme a ciò che ci ha insegnato l’antirazzismo politico, ci permettessero finalmente di riflettere sull’unione politica di queste due categorie per “fare davvero popolo”? Non mettendo da parte o cancellando le loro differenze, ma facendole dialogare politicamente. Partendo da dove parlano, da dove vivono, da dove resistono.
Nel 2005 abbiamo vissuto due rabbie. Nel 2025 dobbiamo pensarle strategicamente. E questa strategia inizia con un lavoro teorico e politico, che deve anche interrogare il quadro istituzionale in cui questa unione è resa strutturalmente difficile, se non impossibile: l’architettura giuridica e politica dell’Unione europea stessa, che opera una separazione duratura tra le forme di conflittualità sociale e quelle derivanti dalla storia coloniale. È necessario comprendere cosa fosse realmente il TCE; comprendere cosa fossero realmente le rivolte; comprendere perché la giunzione di queste due rabbie sia fallita – e come renderla possibile oggi.
Le rivolte del 2005: la rivolta dei dannati dell’interno
Se il “no” al Trattato costituzionale è stato sentito – senza però essere rispettato –, le rivolte di ottobre-novembre 2005 non sono state nemmeno ascoltate, sono state semplicemente condannate. Alla risposta alle urne delle classi popolari bianche è seguita una risposta con il fuoco dei quartieri popolari. E in entrambi i casi, lo Stato ha reagito con la negazione.
Clichy-sous-Bois, Aulnay, La Courneuve, Villiers-le-Bel, Tolosa, Lione… Non sono zone di non diritto, “territori perduti della Repubblica”, al contrario! Sono i territori più controllati, più pattugliati, più sorvegliati della Repubblica. Questi luoghi non sono al di fuori del sistema: sono il suo rovescio, la sua condizione necessaria, i margini in cui il sistema espelle i corpi che rifiuta di integrare.
Le rivolte del 2005 non sono un fatto di cronaca. Sono una rivolta politica senza mediazioni, un’insurrezione senza programma, ma per questo non senza causa. Sono il grido dei figli dell’impero a cui è stato fatto credere di essere cittadini come gli altri, mentre venivano relegati negli strati più bassi della società con l’ordine di stare al loro posto senza fare rumore.
Si è voluto parlare di vandalismo, di odio, di barbarie. Il sociologo Gérard Mauger ha persino relativizzato il carattere politico di queste rivolte parlando di evento “proto-politico”. Ma cosa c’è di più politico di una popolazione che dice: “Non vogliamo più essere governati in questo modo”?
Bisogna dire le cose chiaramente: le rivolte del 2005 sono state un momento di verità. Una verità politica che si è espressa violentemente per farsi sentire: quella del razzismo strutturale, della polizia come strumento di disciplina razziale, delle banlieues come zone di gestione coloniale. Non è stata una crisi: è stato un sintomo. Il sintomo di una crisi politica di cui il rifiuto del TCE costituiva l’altra faccia.
Eppure questa rivolta non ha trovato eco a sinistra. Né nei partiti, né nei sindacati, né tantomeno nelle mobilitazioni contro il TCE. Questa rivolta ha messo a disagio la sinistra bianca. Perché questa rivolta era l’opera di arabi e neri. Perché sfuggiva alla caricatura che tutta una parte della sinistra faceva delle questioni di classe – pur essendo pienamente una lotta di classe, ma vista dai margini: dal punto di vista dei dannati.
Questa assenza di collegamento – tra il popolo del “no” e quello delle rivolte – non è solo un malinteso. È il prodotto di una separazione strutturale, organizzata nel diritto, nello spazio, nella storia. Una separazione che le istituzioni europee hanno rafforzato: integrando una parte del mondo operaio in una finzione di cittadinanza economica, mentre relegavano le classi popolari razzializzate in una forma di permanente eccezione securitaria.
Due rivolte: un unico avversario
Se le due rivolte del 2005 non hanno fatto convergenza, è innanzitutto perché non sono state riconosciute come ugualmente legittime. Il “no” al TCE è stato trattato come un’espressione democratica e l’espressione di una preoccupazione che aveva una forma di legittimità, anche se poi è stata aggirata. Le rivolte nelle banlieues, invece, sono state immediatamente squalificate: ridotte a una patologia sociale, depoliticizzate, criminalizzate.
Eppure questi due movimenti si inseriscono nella stessa sequenza storica. Una sequenza segnata dall’ascesa di un potere economico sovranazionale che riduce la sovranità popolare a un semplice ornamento e dal consolidamento di un apparato di gestione razziale delle marginalità. Due espressioni di una stessa spoliazione, vissuta da luoghi diversi.
La critica al TCE denunciava l’inserimento nel diritto di un ordine economico immutabile. Ma non nominava le linee di colore e le gerarchie ereditate dall’impero. Al contrario, le rivolte parlavano dall’esperienza quotidiana della relegazione, del controllo, della violenza di Stato, ma senza riuscire a farsi sentire nello spazio politico strutturato dalle categorie della sinistra convenzionale.
Come abbiamo detto poc’anzi, il fallimento della loro unione non è solo politico, è strutturale. La dice lunga sul contesto in cui viviamo. Un contesto che separa i conflitti sociali legittimi dalle forme di contestazione considerate estranee alla democrazia. Un contesto che gerarchizza le rabbie. L’Unione europea funziona come uno Stato razziale nel senso “integrale” [seguendo le riflessioni di Gramsci e Poulantzas di Stato integrale, ndt]: organizza, a livello sovranazionale, la dissociazione tra forme di cittadinanza differenziate, rendendo alcune vite governabili e altre abbandonate alla gestione poliziesca, frontaliere o umanitarie. Eredita le gerarchie coloniali mentre pretende di incarnare la razionalità democratica. Depoliticizza i conflitti economici e rende invisibili i conflitti razziali. Produce una cittadinanza a due velocità e neutralizza la possibilità stessa di una sintesi politica tra i diversi segmenti delle classi popolari.
Riconoscere questo non significa rinunciare all’idea di “fare popolo”. Al contrario, significa gettare le basi per un popolo reale, costruito a partire dalle fratture e non contro di esse. Un popolo che non si definisce per la sua purezza, ma per la sua capacità di organizzare i conflitti che lo attraversano. È questo il compito che ci attende.
Diventare popolo: condizioni strategiche
Se prendiamo sul serio ciò che il 2005 ha rivelato, allora dobbiamo andare oltre la constatazione. Dobbiamo porci una domanda semplice: cosa significa oggi “diventare popolo” in un Paese frammentato e organizzato in modo così razziale? Non come un incantesimo, ma come un compito strategico. Un compito difficile, ma inevitabile.
Non basta constatare l’esistenza di molteplici ingiustizie e denunciarle. Bisogna riuscire a pensarle insieme senza dissolverle. Ciò che le rivolte del 2005 ci hanno insegnato è che l’esperienza della spoliazione non si declina in modo uniforme. Non esiste un’unica forma di precarietà o di esclusione. Ci sono esperienze diverse, forme specifiche di oppressione – che però, in determinate circostanze, possono convergere oggettivamente.
La questione non è quindi: “bisogna scegliere tra classe e razza?” Si tratta di una falsa alternativa. La domanda è: come costruire un soggetto collettivo a partire da una pluralità di condizioni, individuando chiari obiettivi comuni e politici.
Diventare popolo non significa celebrare la “diversità”. Significa organizzare politicamente le contraddizioni interne a un blocco sociale dominato, per trasformarle in una forza offensiva. Ciò presuppone chiarezza sul nemico – l’ordine capitalista così come si esprime oggi nelle istituzioni economiche, giuridiche e securitarie –, ma anche chiarezza sui rapporti interni al campo popolare: rapporti di diffidenza, di concorrenza, a volte di dominio tra frazioni del proletariato. Diventare popolo richiede quindi “un’analisi concreta della situazione concreta”, anche quella del nostro campo.
Ciò implica quindi un lavoro politico, in senso forte. Un lavoro di analisi, di organizzazione, di traduzione tra universi sociali spesso separati. Ciò presuppone contesti in cui non ci si accontenta di denunciare o indignarsi, ma in cui si producono priorità, alleanze, forme di intervento coordinate.
In questo senso, bisogna riconoscere una cosa: le condizioni del 2025 non sono quelle del 2005. Lo spazio della conflittualità è cambiato. L’atomizzazione sociale, la disorganizzazione del mondo sindacale, l’assorbimento di una parte degli ambienti militanti da parte di logiche identitarie o moralizzanti hanno frammentato ancora di più ciò che era già diviso. Ma questo non significa che qualsiasi strategia di ricomposizione sia destinata a fallire. Tanto più che esistono anche numerosi progressi, a cominciare dal posto che occupa ora la questione razziale nelle organizzazioni di sinistra. Ne è testimonianza la reazione di Jean-Luc Mélenchon durante le rivolte del 2023 seguite alla morte di Nahel, quando ha rifiutato di invitare alla calma preferendo invece invocare la giustizia! Una presa di posizione che contrasta nettamente con il silenzio complice delle organizzazioni di sinistra nel 2005.
Il cantiere resta quindi ancora aperto. Non si tratta di inventare tutto da zero. Si tratta di identificare i punti di tensione, i possibili punti di svolta, dove è possibile costruire alleanze sulla base di un confronto con l’ordine esistente.
Diventare popolo, in questo caso, non significa cercare un consenso debole. Significa formare un blocco sociale conflittuale, eterogeneo ma organizzato, capace di parlare a nome di coloro che non hanno posto nella narrazione nazionale e di influire sulla scena politica reale. Ciò richiede di rompere con i riflessi difensivi. Di non cercare l’unità fine a se stessa, ma come condizione per il potere collettivo.
2025: un momento decisivo
Vent’anni dopo, ciò che ci dicono le rivolte del 2005 non ha perso nulla della sua forza. Hanno messo a nudo due realtà complementari: l’esaurimento di un progetto europeo costruito contro i popoli e l’impasse di un modello repubblicano incapace di riconoscere coloro che continua a mantenere ai margini. Sono due espressioni dello stesso ordine – economico, politico, razziale – che ha saputo riorganizzarsi nonostante le crisi.
Ciò che il 2025 ci chiede non è di commemorare o ripetere le stesse analisi. È di trasformare una doppia constatazione in un orientamento strategico. Perché la lucidità, da sola, non fa movimento. Deve essere accompagnata da un progetto, da un metodo, da un radicamento.
Ciò implica riconoscere che l’orizzonte strategico non può essere la riforma interna di un apparato europeo fondato sull’esclusione strutturale. Qualsiasi politica popolare seria dovrà, prima o poi, ipotizzare un disgregamento di questo Stato razziale allargato che è l’UE, anche a costo di tornare al quadro nazionale, unico quadro in cui i conflitti sociali possono realmente esprimersi politicamente.
Diventare popolo oggi significa costruire un fronte, con l’obiettivo di immaginare un quadro politico veramente emancipatorio – il che implica anche, a lungo termine, porre la questione dell’uscita dall’Unione europea. Non in una logica di ripiego nazionale, ma come condizione strategica per consentire l’effettiva esistenza di un progetto popolare, sociale e decoloniale. Ciò presuppone una composizione politica, una capacità di iniziativa. Significa uscire dagli attuali vicoli ciechi: il ripiego gestionale, la postura minoritaria, il ripiego morale.