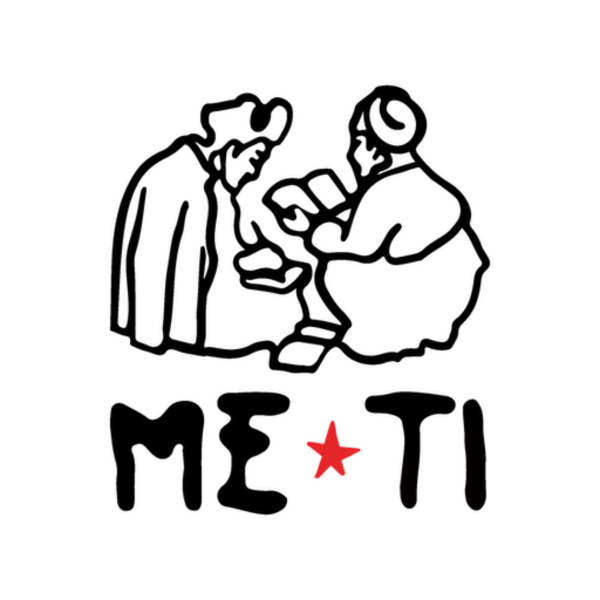Traduciamo questo articolo di Michael Roberts pubblicato a fine marzo 2025 sul suo blog The Next Recession. Dall’inizio della guerra in Ucraina l’élite politica europea sta utilizzando gli argomenti della difesa della democrazia e del rilancio economico per aumentare progressivamente le spese militari. Un’analisi più approfondita dimostra che si tratta invece di un trasferimento di capitale pubblico verso il privato e di un attacco feroce ai diritti e ai salari delle lavoratrici e dei lavoratori.
***
Il bellicismo ha raggiunto livelli febbrili in Europa. Tutto è iniziato con la decisione degli Stati Uniti di Trump di non ritenere più conveniente pagare per la “protezione” militare delle capitali europee da potenziali nemici. Trump vuole che gli Stati Uniti smettano di pagare la maggior parte dei costi della NATO e di fornire la propria potenza militare, e vuole porre fine al conflitto tra Ucraina e Russia per poter concentrare la strategia imperialista degli Stati Uniti sull’“emisfero occidentale” e sul Pacifico, con l’obiettivo di “contenere” e indebolire l’ascesa economica della Cina.
La strategia di Trump ha gettato nel panico le élite dirigenti europee. Improvvisamente temono che l’Ucraina possa soccombere alle forze russe e che Putin possa presto trovarsi alle frontiere della Germania o, come sostengono il premier britannico Keir Starmer e un ex capo dell’MI5, “nelle strade britanniche”.
Qualunque sia la validità di questo presunto pericolo, si è creata l’opportunità per i servizi militari e segreti europei di “alzare la posta” e chiedere la fine del cosiddetto “dividendo di pace” iniziato dopo la caduta della temuta Unione Sovietica e di avviare ora il processo di riarmo. La responsabile della politica estera dell’UE, Kaja Kallas, ha esposto la politica estera dell’UE così come la vede lei: “Se insieme non siamo in grado di esercitare una pressione sufficiente su Mosca, come possiamo affermare di poter sconfiggere la Cina?”
Sono stati avanzati diversi argomenti a favore del riarmo del capitalismo europeo. Bronwen Maddox, direttrice di Chatham House, il “think tank” di relazioni internazionali che presenta principalmente le opinioni dello Stato militare britannico, ha dato il via affermando che “la spesa per la ‘difesa’ è il più grande beneficio pubblico di tutti”, perché è necessaria per la sopravvivenza della “democrazia” contro le forze autoritarie. Ma la difesa della democrazia ha un prezzo: “il Regno Unito potrebbe dover contrarre ulteriori prestiti per finanziare le spese di difesa di cui ha così urgentemente bisogno. Nel prossimo anno e oltre, i politici dovranno prepararsi a recuperare denaro attraverso tagli alle indennità di malattia, alle pensioni e all’assistenza sanitaria”. Ha continuato: “Se ci sono voluti decenni per arrivare a questa spesa, potrebbero volerci decenni per invertire la tendenza”, quindi la Gran Bretagna deve andare avanti. “Starmer dovrà presto fissare una data entro la quale il Regno Unito raggiungerà il 2,5% del PIL per la spesa militare, e c’è già un coro che sostiene che questa cifra debba essere più alta. Alla fine, i politici dovranno convincere gli elettori a rinunciare ad alcuni dei loro benefici per pagare la difesa”.
Martin Wolf, il guru economico keynesiano liberale del Financial Times, è intervenuto: “La spesa per la difesa dovrà aumentare in modo sostanziale. Si noti che negli anni ‘70 e ’80 era pari al 5% del PIL britannico, o anche di più. A lungo termine potrebbe non essere necessario raggiungere tali livelli: la Russia moderna non è l’Unione Sovietica. Tuttavia, potrebbe essere necessario arrivare a livelli così elevati durante la fase di potenziamento, soprattutto se gli Stati Uniti dovessero davvero ritirarsi”.
Come pagare tutto questo? “Se la spesa per la difesa dovrà essere permanentemente più alta, le tasse dovranno aumentare, a meno che il governo non riesca a trovare tagli alla spesa sufficienti, cosa dubbia”. Ma non preoccupatevi, la spesa per carri armati, truppe e missili è in realtà vantaggiosa per l’economia, afferma Wolf. “Il Regno Unito può anche realisticamente aspettarsi un ritorno economico dai suoi investimenti nella difesa. Storicamente, le guerre sono state la madre dell’innovazione”. Cita poi i meravigliosi esempi dei vantaggi che Israele e l’Ucraina hanno tratto dalle loro guerre: “L’economia start-up di Israele è nata nell’esercito. Gli ucraini hanno ora rivoluzionato la guerra con i droni”. Non menziona il costo umano dell’innovazione derivante dalla guerra. Wolf prosegue: “Il punto cruciale, tuttavia, è che la necessità di spendere molto di più per la difesa dovrebbe essere vista come qualcosa di più di una semplice necessità e anche di più di un semplice costo, sebbene entrambi siano veri. Se fatta nel modo giusto, è anche un’opportunità economica”. Quindi la guerra è la via d’uscita dalla stagnazione economica.
Wolf sostiene che la Gran Bretagna deve darsi da fare: “Se gli Stati Uniti non sono più i sostenitori e i difensori della democrazia liberale, l’unica forza potenzialmente abbastanza forte da colmare il vuoto è l’Europa. Se gli europei vogliono avere successo in questo difficile compito, devono iniziare con il mettere in sicurezza la propria casa. La loro capacità di farlo dipenderà a sua volta dalle risorse, dal tempo, dalla volontà e dalla coesione… Indubbiamente, l’Europa può aumentare in modo sostanziale la propria spesa per la difesa”. Wolf ha sostenuto che dobbiamo difendere i tanto decantati “valori europei” della libertà personale e della democrazia liberale. “Farlo sarà economicamente costoso e persino pericoloso, ma necessario… perché l’Europa ha ‘quinte colonne’ quasi ovunque”. Ha concluso che “se l’Europa non si mobilita rapidamente per difendersi, la democrazia liberale potrebbe naufragare del tutto. Oggi sembra un po’ come negli anni ’30. Questa volta, purtroppo, gli Stati Uniti sembrano essere dalla parte sbagliata”.
Il “conservatore progressista” Janan Ganesh, editorialista del FT, lo ha detto chiaramente: “L’Europa deve ridimensionare il suo welfare state per costruire uno stato bellico. Non c’è modo di difendere il continente senza tagli alla spesa sociale”. Ha chiarito che i guadagni ottenuti dai lavoratori dopo la fine della seconda guerra mondiale, ma gradualmente erosi negli ultimi 40 anni, devono ora essere completamente eliminati. “La missione ora è difendere la vita dell’Europa. Come si può finanziare un continente meglio armato se non attraverso uno Stato sociale più piccolo?” L’età dell’oro dello Stato sociale del dopoguerra non è più possibile. “Chiunque abbia meno di 80 anni e abbia trascorso la propria vita in Europa può essere perdonato se considera un gigantesco (sic – MR) Stato sociale come il corso naturale delle cose. In realtà, era il prodotto di strane circostanze storiche, prevalenti nella seconda metà del XX secolo e che non esistono più”.
Sì, è vero, i vantaggi per i lavoratori nell’età dell’oro erano l’eccezione alla norma nel capitalismo (“strane circostanze storiche”). Ma ora “gli oneri pensionistici e sanitari sarebbero stati già difficili da sostenere per la popolazione attiva anche prima dell’attuale shock della difesa…I governi dovranno essere più avari con gli anziani. Oppure, se ciò è impensabile dato il loro peso elettorale, il coltello dovrà cadere su settori di spesa più produttivi…In ogni caso, lo Stato sociale come lo abbiamo conosciuto dovrà ritirarsi in qualche modo: non tanto da non poter più chiamarlo con questo nome, ma abbastanza da fare male”. Ganesh, il vero conservatore, vede il riarmo come un’opportunità per il capitale di operare i necessari tagli al welfare e ai servizi pubblici. “I tagli alla spesa sono più facili da vendere in nome della difesa che in nome di una nozione generica di efficienza…Tuttavia, questo non è lo scopo della difesa, e i politici devono insistere su questo punto. Lo scopo è la sopravvivenza”. Quindi il cosiddetto “capitalismo liberale” deve sopravvivere e questo significa tagliare il tenore di vita dei più poveri e spendere soldi per andare in guerra. Da Stato sociale a Stato bellico.
Il primo ministro polacco Donald Tusk ha alzato ulteriormente il tono bellicoso. Ha affermato che la Polonia “deve puntare alle possibilità più moderne, anche quelle relative alle armi nucleari e alle armi moderne non convenzionali”. Possiamo presumere che con “non convenzionali” si intendano le armi chimiche? Tusk: “Lo dico con piena responsabilità, non è sufficiente acquistare armi convenzionali, quelle più tradizionali”.
Quindi, quasi ovunque in Europa, si chiede un aumento delle spese per la “difesa” e il riarmo. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha proposto un piano di riarmo dell’Europa che mira a mobilitare fino a 800 miliardi di euro per finanziare un massiccio aumento delle spese per la difesa. “Siamo in un’era di riarmo e l’Europa è pronta ad aumentare massicciamente la sua spesa per la difesa, sia per rispondere all’urgenza di agire a breve termine e sostenere l’Ucraina, sia per affrontare la necessità a lungo termine di assumersi maggiori responsabilità per la nostra sicurezza europea”, ha affermato. In base a una “clausola di emergenza”, la Commissione europea chiederà un aumento della spesa per gli armamenti anche se ciò comporta la violazione delle norme fiscali esistenti. Seguiranno i fondi COVID inutilizzati (90 miliardi di euro) e ulteriori prestiti attraverso un “nuovo strumento”, per fornire 150 miliardi di euro in prestiti agli Stati membri per finanziare investimenti comuni nella difesa in capacità paneuropee, tra cui la difesa aerea e missilistica, i sistemi di artiglieria, i missili e le munizioni, i droni e i sistemi anti-drone. Von der Leyen ha affermato che se i paesi dell’UE aumentassero la spesa per la difesa dell’1,5% del PIL in media, nei prossimi quattro anni si potrebbero liberare 650 miliardi di euro. Tuttavia, non ci sarebbero fondi aggiuntivi per investimenti, progetti infrastrutturali o servizi pubblici, perché l’Europa deve dedicare le proprie risorse alla preparazione alla guerra.
Allo stesso tempo, come ha affermato il FT, il governo britannico “sta compiendo una rapida transizione dal verde al grigio navale, ponendo ora la difesa al centro del suo approccio alla tecnologia e alla produzione”. Starmer ha annunciato un aumento della spesa per la difesa al 2,5% del PIL entro il 2027 e l’ambizione di raggiungere il 3% entro il 2030. Il ministro delle Finanze britannico Rachel Reeves, che ha costantemente tagliato la spesa per gli assegni familiari, i sussidi invernali per gli anziani e le indennità di invalidità, ha annunciato che il mandato del nuovo Fondo nazionale per la ricchezza del governo laburista sarà modificato per consentirgli di investire nella difesa. I produttori di armi britannici esultano. “Lasciando da parte l’etica della produzione di armi, che scoraggia alcuni investitori, la difesa come strategia industriale ha molti aspetti positivi”, ha affermato un amministratore delegato.
In Germania, il cancelliere eletto del nuovo governo di coalizione, Friedrich Merz, ha fatto approvare dal parlamento tedesco una legge che pone fine al cosiddetto “freno fiscale”, che rendeva illegale per i governi tedeschi contrarre prestiti oltre un limite rigoroso o aumentare il debito per finanziare la spesa pubblica. Ma ora la spesa militare in deficit ha la priorità su tutto, essendo l’unico bilancio senza limiti. L’obiettivo di spesa per la difesa farà impallidire la spesa in deficit disponibile per il controllo del clima e per le infrastrutture di cui c’è un disperato bisogno.
La spesa pubblica annuale prevista dal nuovo pacchetto fiscale tedesco sarà superiore al boom di spesa che ha accompagnato il Piano Marshall del dopoguerra e la riunificazione tedesca all’inizio degli anni ’90.
Questo mi porta alle argomentazioni economiche a favore della spesa militare. La spesa militare può rilanciare un’economia in recessione, come gran parte dell’Europa dalla fine della Grande Recessione del 2009? Alcuni keynesiani lo pensano. Il produttore tedesco di armi Rheinmetall afferma che lo stabilimento Volkswagen di Osnabrück, attualmente inattivo, potrebbe essere un candidato ideale per la conversione alla produzione militare. L’economista keynesiano Matthew Klein, coautore con Michael Pettis di Trade Wars are Class Wars, ha accolto con favore questa notizia: “La Germania sta già costruendo carri armati. Li incoraggio a costruirne molti altri”.
La teoria del “keynesismo militare” ha una sua storia. Una variante di questa teoria era il concetto di “economia permanente degli armamenti” sostenuto da alcuni marxisti per spiegare perché le principali economie non entrarono in depressione dopo la fine della seconda guerra mondiale, ma entrarono invece in un lungo periodo di boom con solo lievi recessioni, che durò fino alla crisi internazionale del 1974-75. Secondo loro, questa “età dell’oro” poteva essere spiegata solo con la spesa militare permanente per mantenere la domanda aggregata e sostenere la piena occupazione.
Ma le prove a sostegno di questa teoria del boom del dopoguerra non esistono. La spesa militare del governo britannico è scesa da oltre il 12% del PIL nel 1952 a circa il 7% nel 1960 e ha continuato a diminuire negli anni ’60 fino a raggiungere circa il 5% alla fine del decennio. Eppure l’economia britannica ha registrato risultati migliori che in qualsiasi altro periodo successivo. In tutti i paesi capitalisti avanzati, alla fine degli anni ’60 la spesa per la difesa rappresentava una percentuale sostanzialmente inferiore del prodotto totale rispetto all’inizio degli anni ’50: dal 10,2% del PIL nel 1952-53, al culmine della guerra di Corea, al solo 6,5% nel 1967. Eppure la crescita economica è stata sostenuta praticamente per tutti gli anni ’60 e i primi anni ’70.
Il boom del dopoguerra non fu il risultato della spesa pubblica keynesiana per gli armamenti, ma si spiega con l’alto tasso di redditività del capitale investito dalle principali economie nel dopoguerra. Semmai, fu il contrario. Poiché le principali economie crescevano relativamente velocemente e la redditività era alta, i governi potevano permettersi di sostenere la spesa militare come parte del loro obiettivo geopolitico della “guerra fredda” per indebolire e schiacciare l’Unione Sovietica, allora principale nemico dell’imperialismo.
Soprattutto, il keynesismo militare è contrario agli interessi dei lavoratori e dell’umanità. Siamo favorevoli alla produzione di armi per uccidere persone al fine di creare posti di lavoro? Questa argomentazione, spesso promossa da alcuni leader sindacali, mette il denaro prima delle vite umane. Keynes una volta disse: “Il governo dovrebbe pagare le persone per scavare buche nel terreno e poi riempirle”. La gente risponderebbe: “È stupido, perché non pagare le persone per costruire strade e scuole?”. Keynes risponderebbe: “Va bene, pagateli per costruire scuole. Il punto è che non importa cosa fanno, purché il governo crei posti di lavoro”.
Keynes aveva torto. Importa eccome. Il keynesismo sostiene che per creare posti di lavoro bisogna scavare buche e riempirle. Il keynesismo militare sostiene che per creare posti di lavoro bisogna scavare tombe e riempirle di cadaveri. Se non importa come vengono creati i posti di lavoro, perché non aumentare drasticamente la produzione di tabacco e promuovere la dipendenza per creare posti di lavoro? Attualmente, la maggior parte delle persone si opporrebbe a questo perché direttamente dannoso per la salute delle persone. Anche la produzione di armi (convenzionali e non convenzionali) è direttamente dannosa. E ci sono molti altri prodotti e servizi socialmente utili che potrebbero fornire posti di lavoro e salari ai lavoratori (come scuole e case).
Il ministro della Difesa del governo britannico John Healey ha recentemente insistito sul fatto che aumentare il bilancio della difesa “renderebbe la nostra industria della difesa il motore della crescita economica in questo paese”. Ottima notizia. Purtroppo per Healey, l’associazione di categoria dell’industria degli armamenti del Regno Unito (ADS) stima che il Regno Unito abbia circa 55.000 posti di lavoro nell’esportazione di armi e altri 115.000 impiegati nel Ministero della Difesa. Anche includendo questi ultimi, si tratta solo dello 0,5% della forza lavoro del Regno Unito (vedi il briefing di CAAT Arms to Renewables per i dettagli). Anche negli Stati Uniti il rapporto è molto simile.
C’è una questione teorica spesso dibattuta nell’economia politica marxista. Si tratta di capire se la produzione di armi sia produttiva di valore in un’economia capitalista. La risposta è sì, per i produttori di armi. Gli appaltatori di armi forniscono beni (armi) che vengono pagati dal governo. Il lavoro che li produce è quindi produttivo di valore e plusvalore. Ma a livello dell’intera economia, la produzione di armi è improduttiva di valore futuro, allo stesso modo dei “beni di lusso” destinati al solo consumo capitalistico. La produzione di armi e i beni di lusso non rientrano nel processo produttivo successivo, né come mezzi di produzione né come mezzi di sussistenza per la classe operaia. Pur essendo produttiva di plusvalore per i capitalisti dell’industria degli armamenti, la produzione di armi non è riproduttiva e quindi minaccia la riproduzione del capitale. Quindi, se l’aumento della produzione complessiva di plusvalore in un’economia rallenta e la redditività del capitale produttivo inizia a diminuire, la riduzione del plusvalore disponibile per gli investimenti produttivi al fine di investire nella spesa militare può danneggiare la “salute” del processo di accumulazione capitalistica.
Il risultato dipende dall’effetto sulla redditività del capitale. Il settore militare ha generalmente una composizione organica del capitale superiore alla media di un’economia, poiché incorpora tecnologie all’avanguardia. Pertanto, il settore degli armamenti tenderebbe a spingere al ribasso il tasso medio di profitto. D’altra parte, se le tasse riscosse dallo Stato (o i tagli alla spesa civile) per finanziare la produzione di armi sono elevate, la ricchezza che altrimenti andrebbe al lavoro può essere distribuita al capitale e quindi aumentare il plusvalore disponibile. La spesa militare può avere un effetto leggermente positivo sui tassi di profitto nei paesi esportatori di armi, ma non in quelli importatori. In questi ultimi, la spesa militare è una detrazione dai profitti disponibili per gli investimenti produttivi.
In un quadro più ampio, la spesa per gli armamenti non può essere determinante per la salute dell’economia capitalista. D’altra parte, una guerra totale può aiutare il capitalismo a uscire dalla depressione e dalla recessione. È un argomento chiave dell’economia marxista (almeno nella mia versione) che le economie capitalistiche possono riprendersi in modo sostenibile solo se la redditività media dei settori produttivi dell’economia aumenta in modo significativo. E ciò richiederebbe una distruzione sufficiente del valore del “capitale morto” (accumulato in passato) che non è più redditizio da impiegare.
La Grande Depressione degli anni ’30 nell’economia statunitense durò così a lungo perché la redditività non si riprese per tutto il decennio. Nel 1938, il tasso di profitto delle imprese statunitensi era ancora inferiore alla metà di quello del 1929. La redditività riprese solo con l’avvio dell’economia di guerra, a partire dal 1940.
Quindi non è stato il “keynesismo militare” a far uscire l’economia statunitense dalla Grande Depressione, come alcuni keynesiani amano pensare. La ripresa economica degli Stati Uniti dalla Grande Depressione non è iniziata fino a quando la guerra mondiale era già in corso. Gli investimenti sono decollati solo a partire dal 1941 (Pearl Harbor) per raggiungere, in percentuale del PIL, più del doppio del livello del 1940. Perché? Beh, non è stato il risultato di una ripresa degli investimenti del settore privato. Ciò che è accaduto è stato un massiccio aumento degli investimenti e della spesa pubblica. Nel 1940, gli investimenti del settore privato erano ancora inferiori al livello del 1929 e durante la guerra sono addirittura diminuiti. Il settore pubblico ha assorbito quasi tutti gli investimenti, poiché le risorse (il valore) sono state dirottate verso la produzione di armi e altre misure di sicurezza in un’economia di guerra totale.
Ma l’aumento degli investimenti e dei consumi pubblici non è forse una forma di stimolo keynesiano, solo a un livello più alto? Beh, no. La differenza emerge dal continuo crollo dei consumi. L’economia di guerra fu finanziata limitando le possibilità dei lavoratori di spendere i redditi derivanti dai loro lavori bellici. Ci fu un risparmio forzato attraverso l’acquisto di titoli di guerra, il razionamento e l’aumento delle tasse per pagare la guerra. Gli investimenti pubblici significavano la direzione e la pianificazione della produzione per decreto governativo. L’economia di guerra non stimolò il settore privato, ma sostituì il “libero mercato” e gli investimenti capitalistici a scopo di lucro. I consumi non ripristinarono la crescita economica come si aspettavano i keynesiani (e coloro che vedono la causa della crisi nel sottoconsumo); al contrario, si trattò di investimenti principalmente in armi di distruzione di massa.
La guerra pose fine in modo decisivo alla depressione. L’industria americana fu rivitalizzata dalla guerra e molti settori furono orientati alla produzione per la difesa (ad esempio, l’aerospaziale e l’elettronica) o divennero completamente dipendenti da essa (energia atomica). I rapidi cambiamenti scientifici e tecnologici della guerra continuarono e intensificarono le tendenze iniziate durante la Grande Depressione. Poiché la guerra danneggiò gravemente tutte le principali economie del mondo ad eccezione degli Stati Uniti, il capitalismo americano acquisì l’egemonia economica e politica dopo il 1945.
Guiglelmo Carchedi ha spiegato: “Perché la guerra ha provocato un tale aumento della redditività nel periodo 1940-1945? Il denominatore del tasso non solo non è aumentato, ma è diminuito perché il deprezzamento fisico dei mezzi di produzione era superiore ai nuovi investimenti. Allo stesso tempo, la disoccupazione è praticamente scomparsa. La diminuzione della disoccupazione ha reso possibili salari più alti. Ma i salari più alti non intaccarono la redditività. Infatti, la conversione delle industrie civili in militari ridusse l’offerta di beni civili. I salari più alti e la produzione limitata di beni di consumo significavano che il potere d’acquisto del lavoro doveva essere fortemente compresso per evitare l’inflazione. Ciò fu ottenuto istituendo la prima imposta generale sul reddito, scoraggiando i consumi (il credito al consumo fu vietato) e stimolando il risparmio dei consumatori, principalmente attraverso l’investimento in titoli di guerra. Di conseguenza, la manodopera fu costretta a rinviare la spesa di una parte consistente dei salari. Allo stesso tempo, aumentò il tasso di sfruttamento della manodopera. In sostanza, lo sforzo bellico fu una produzione massiccia di mezzi di distruzione finanziata dal lavoro.”
Keynes lo riassume così: “Sembra politicamente impossibile per una democrazia capitalistica organizzare una spesa su scala tale da rendere possibili i grandi esperimenti che dimostrerebbero la mia tesi, se non in condizioni di guerra”, da The New Republic (citato da P. Renshaw, Journal of Contemporary History 1999 vol. 34 (3) p. 377-364).