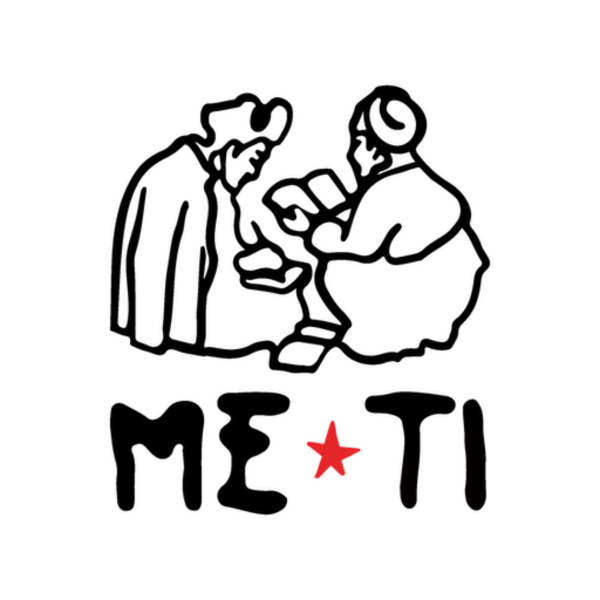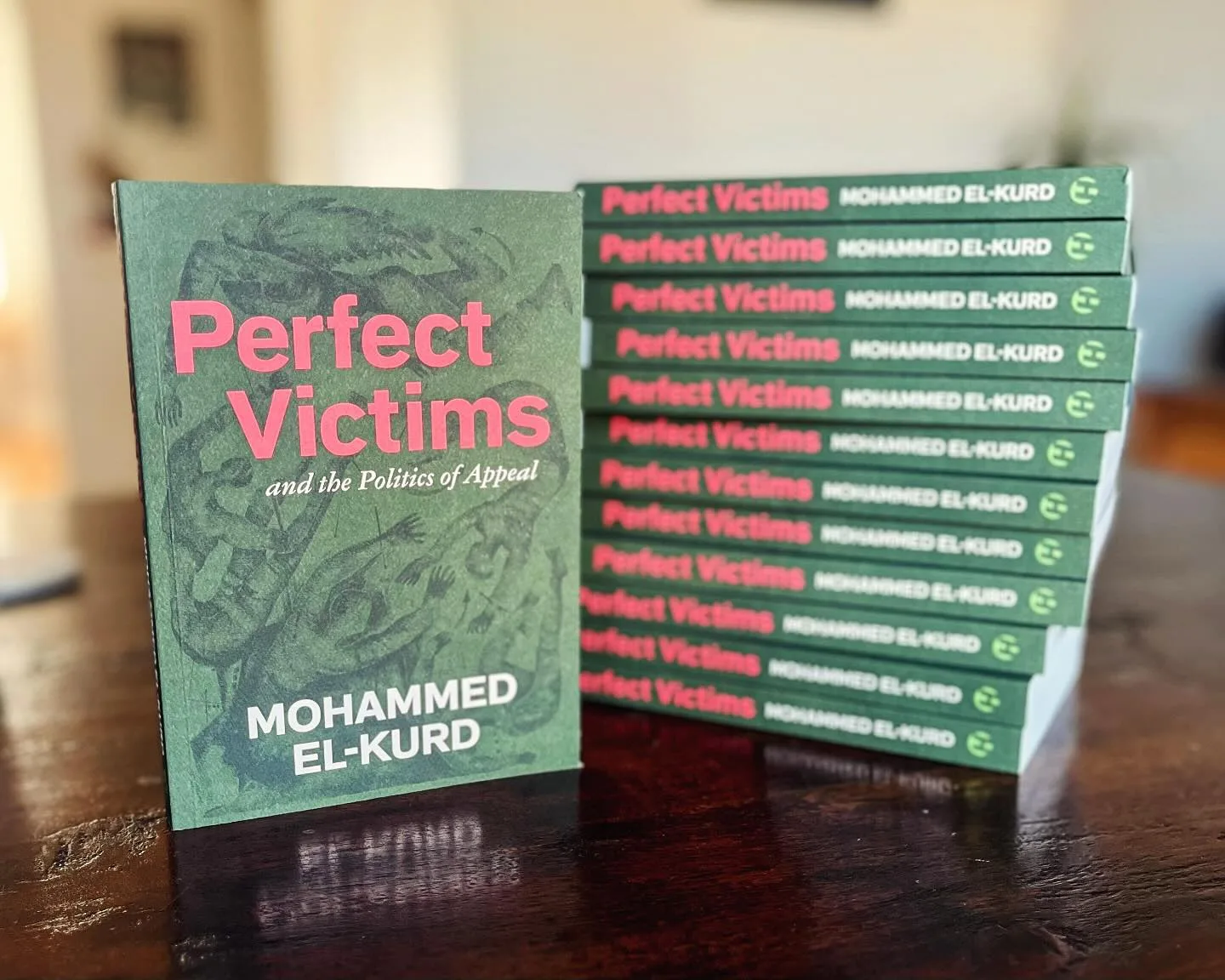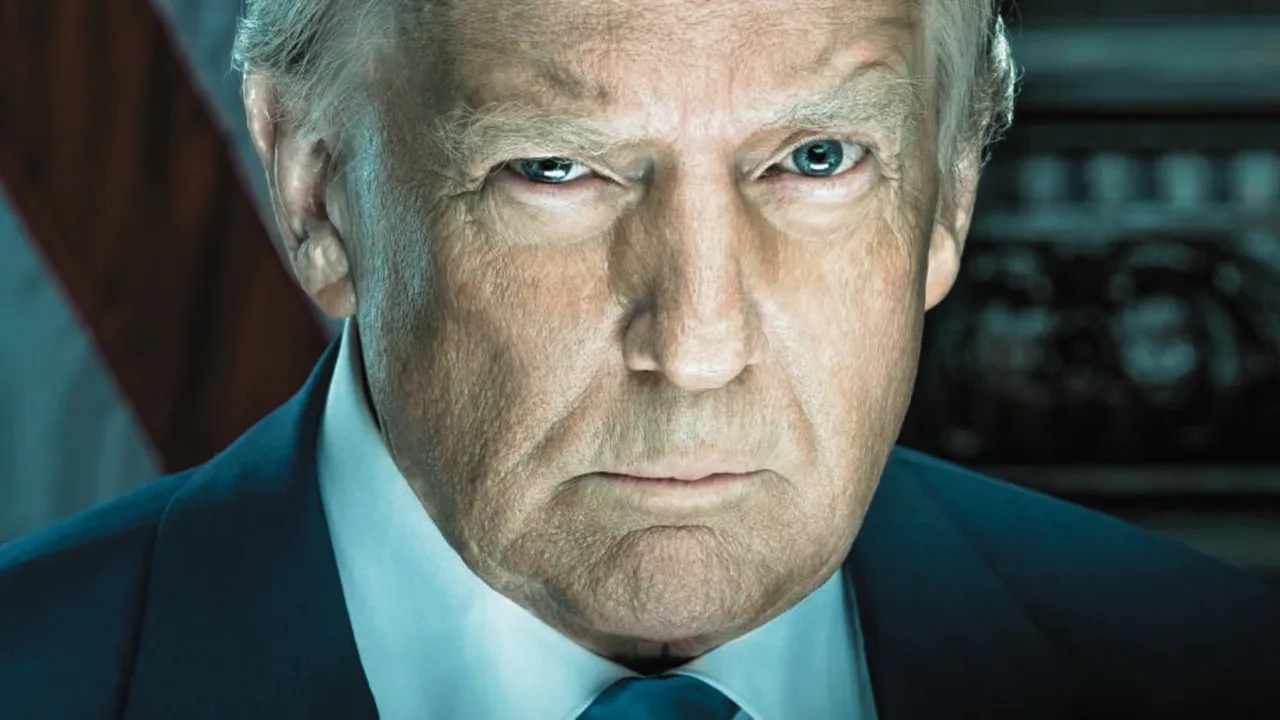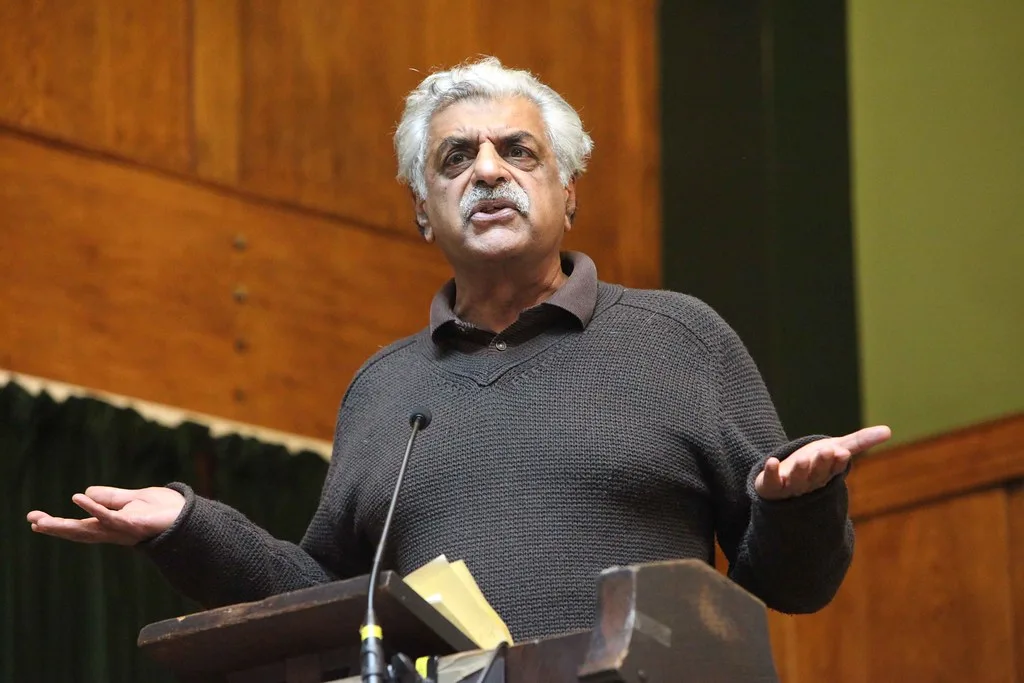Pubblichiamo una recensione dell’ultimo libro dell’autore palestinese Mohammed El-Kurd Perfect Victims. And the Politics of Appeal uscito con la casa editrice Haymarket Books. La recensione è stata scritta da Dalia Maini, scritticǝ, editricǝ, performer e agitatricǝ e tutto ciò che è nel mezzo. Dal 2021 è caporedattrice della rivista Arts of the Working Class. Il testo è nato grazie alla guida di María Inés Plaza Lazo.
***
Allora chiedo ancora: e se le nostre vittime perfette in realtà disprezzassero chi ha ucciso le loro famiglie? […] Questo sentimento velenoso compromette il vostro status di vittima? Riscrive la storia per assolvere il soldato? Giustifica il crimine?
Nell’ottobre 2023, il mondo ha assistito all’escalation del conflitto israelo-palestinese con conseguenze devastanti per Gaza. In questo contesto, la voce del poeta e attivista palestinese Mohammed El-Kurd emerge con particolare forza. Nato a Sheikh Jarrah, quartiere di Gerusalemme Est al centro di dispute territoriali, El-Kurd è diventato un simbolo della resistenza attraverso la parola. Nel suo nuovo libro Perfect Victims, pubblicato a inizio 2025, El-Kurd analizza criticamente il modo in cui le persone palestinesi vengono rappresentati nei media occidentali e le aspettative imposte sul loro comportamento per essere considerati “vittime accettabili”.
Il modo in cui viviamo e ci relazioniamo al mondo è modellato dal potere politico delle immagini. In ambito geopolitico e nei diritti umani, le immagini non si limitano a rappresentare: decidono chi è degno di compassione, chi può parlare, chi può esistere. La CNN che mostra corpi palestinesi mutilati senza contesto, mentre dedica lunghe interviste empatiche alle vittime israeliane, esemplifica questa disparità di rappresentazione.
Nel caso della Palestina, tutto si gioca tra ciò che è visibile e ciò che è occultato, dicibile e indicibile. Per questo colpisce l’affermazione che apre Perfect Victims: i palestinesi, scrive El-Kurd, non sono considerati degni nemmeno di essere guardati negli occhi. Le sue parole richiamano il saggio di Miriam Deprez Visual Necropolitics and Visual Violence, in cui l’autrice descrive come l’occupazione israeliana agisca anche sul piano visivo, filtrando ciò che il mondo può – o deve – vedere.
La necropolitica visiva – cioè il potere di decidere quali morti siano visibili e quali no – non si limita a colpire i corpi, ma anche lo sguardo: attraverso droni, cecchini, media embedded. I palestinesi vengono assassinati a distanza, mai affrontati. Il nemico non si guarda negli occhi. Vediamo questo meccanismo in azione quando, ad esempio, i notiziari occidentali mostrano solo cifre di vittime palestinesi, mentre per le vittime israeliane vengono condivise storie personali, fotografie di famiglia, sogni interrotti.
La costruzione della “vittima perfetta”
Nel primo capitolo di Perfect Victims, El-Kurd descrive questa distanza come meccanismo di disumanizzazione. I corpi mutilati vengono poi selezionati e rilanciati dai media occidentali secondo un calcolo coloniale: è una morte piangibile, o no? Come scrive, i palestinesi sono sempre uccidibili, ma non sempre piangibili. Le loro immagini – case sventrate, volti sporchi di sangue – non innescano reazioni, né giuridiche né morali. Anzi: l’indignazione si attiva solo quando quelle stesse immagini si discostano dallo stereotipo della “vittima perfetta”.
Perfect Victims nasce come risposta diretta a questa logica. El-Kurd vi analizza lo “script” della vittima palestinese: dev’essere docile, solitaria, rispettabile, non violenta. Soprattutto, non deve opporre resistenza. In questo schema, anche il lutto è condizionato. Consideriamo il caso mediatico di Razan al-Najjar, paramedica palestinese uccisa da un cecchino israeliano nel 2018: è diventata “accettabile” sui media occidentali solo dopo che è stata presentata come una “salvatrice angelica”, spogliata di qualsiasi dimensione politica o posizionamento sulla resistenza.
Il libro di El-Kurd smonta tale narrazione coloniale e propone invece una nuova forma di advocacy: i palestinesi non devono più dimostrare la propria umanità per essere ascoltati. Come scrive in un passaggio particolarmente incisivo: “Siamo stanchi di provare la nostra umanità come se fosse un teorema matematico. L’umanità non è un premio di civiltà che ci viene concesso dopo aver superato un test di gradimento.”
Sfidare il linguaggio del potere
Anche sul piano stilistico, Perfect Victims rifiuta gli strumenti della neutralità occidentale – dati, giurisprudenza, burocrazia umanitaria – che da sempre astraggono e svuotano la sofferenza palestinese. Il testo è lirico, orale, proverbiale. Non cerca legittimità accademica, ma trasmette un sapere incarnato e generazionale. Ogni frase sfida il linguaggio del potere, rovesciando la gerarchia di chi può parlare e come.
“Non userò il vostro linguaggio che rende invisibile l’oppressore”, scrive El-Kurd. “Non dirò ‘conflitto’ quando significa occupazione, non dirò ‘scontri’ quando significa massacro, non dirò ‘insediamenti’ quando significa colonie.” Questo rifiuto della terminologia imposta rappresenta già di per sé un atto di resistenza linguistica, simile a quello operato da altri autori palestinesi come Ghassan Kanafani o più recentemente da Adania Shibli nel suo Un dettaglio minore.
El-Kurd mostra come ai palestinesi venga concesso di esistere solo entro due categorie: come terroristi, o come vittime passive. Troppo resistenti per essere compatiti, troppo deboli per essere temuti. Una tale rappresentazione nega loro complessità, agency, contraddizione – in breve, umanità. “Non meritano la vita anche i turbolenti, gli arrabbiati?”, chiede El-Kurd. “Chi decide il diritto alla vita?”
La risposta è una: lo sguardo coloniale. La “relatabilità” è la condizione imposta perché un palestinese possa essere visto come umano. Se non somiglia all’occidentale rispettabile – progressista, colto, moderato – diventa indistinto. E nell’ideologia coloniale, ciò che è indistinto è sacrificabile.
Il prezzo dell’accettabilità
Lo si vede nel caso di Izzeldin Abuelaish, medico palestinese cui furono uccise tre figlie durante l’Operazione Piombo Fuso. Solo dopo essersi presentato come “medico di Harvard, dedito alla pace” ottenne spazio editoriale internazionale. I suoi interventi sono stati pubblicati dal New York Times e ha ottenuto inviti a conferenze internazionali, mentre le voci di genitori palestinesi senza credenziali accademiche occidentali rimanevano inascoltate. La sua umanità è divenuta accettabile solo perché etnicamente “trattabile”. Ma, scrive El-Kurd, “essere umani non è un aggettivo. E di certo non è un complimento.”
La violenza non passa solo dallo sterminio fisico, ma anche dalla museruola linguistica. Ai palestinesi viene imposto come parlare dei propri carnefici: non “ebrei”, ma “sionisti”; non “occupanti”, ma “governo israeliano”. La semantica viene monitorata più della realtà. “Ci si concentrava su come descrivevamo i nostri carcerieri, non sulle condizioni in cui ci tenevano”, scrive El-Kurd. Il crimine non è più l’oppressione, ma il modo in cui la si denuncia. Così, i palestinesi vengono accusati dell’antisemitismo europeo – una colpa storica non loro, ma che oggi pagano.
Il dissenso palestinese viene sistematicamente equiparato al terrorismo. Ne è esempio il caso di Mahmoud Khalil, attivista e dottorando a New York, arrestato durante le proteste universitarie dell’aprile 2025 e trattenuto per settimane senza accuse formali. Trump lo ha definito “minaccia alla sicurezza nazionale”, mentre diverse organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato la natura politica della detenzione. La repressione del pensiero palestinese è così formalizzata: deportazioni, liste nere, censure. Il tutto sotto la maschera della sicurezza nazionale.
Rompere il silenzio
All’inizio del 2025, Israele ha ucciso i giornalisti Hossam Shabat e Mohammad Mansour mentre documentavano il genocidio a Gaza. Nonostante indossassero giubbotti con la scritta PRESS, non c’è stata significativa indignazione internazionale. Nessuna dichiarazione forte dalle associazioni stampa. Eppure, prima di morire, Shabat aveva lasciato un messaggio che è circolato come un testamento: “Vi chiedo: non smettete di parlare di Gaza. Non lasciate che il mondo distolga lo sguardo. Continuate a raccontare le nostre storie – finché la Palestina non sarà libera.”
Allora chiediamoci: Khalil non merita forse un processo come ogni cittadino? I giornalisti non sono forse protetti dal diritto internazionale? Chi stabilisce chi ha diritto a essere difeso, e chi può essere scartato?
Verso una nuova rappresentazione
El-Kurd non si limita a criticare: propone anche un’alternativa. Nel capitolo Reclaiming Our Image suggerisce che i palestinesi devono riappropriarsi della propria rappresentazione attraverso forme di narrazione autonome, svincolate dalle aspettative occidentali. “Non dobbiamo più chiedere il permesso di esistere nelle nostre contraddizioni”, scrive. “La nostra rabbia è legittima quanto il nostro dolore, la nostra resistenza tanto necessaria quanto le nostre lacrime.”
Le domande che pone Perfect Victims eccedono la questione palestinese: toccano le fondamenta del discorso pubblico, della giustizia, della rappresentabilità. Se per essere ascoltati i palestinesi devono diventare “accettabili”, allora gli strumenti stessi dell’ascolto sono compromessi. Non basta offrire una piattaforma: bisogna smantellare i filtri che regolano chi può parlare e chi no.
Il libro di El-Kurd rappresenta quindi non solo una critica ai meccanismi di rappresentazione esistenti, ma un manifesto per un nuovo modo di guardare – e vedere davvero – i palestinesi: non come vittime da compiangere o minacce da neutralizzare, ma come esseri umani complessi e contraddittori, con il diritto di raccontarsi con le proprie parole, di resistere, di esistere al di là dello sguardo coloniale. Solo così sarà possibile passare dalla visibilità condizionata al riconoscimento autentico, dalla compassione alla giustizia.
Come lettori occidentali, il testo ci sfida a esaminare criticamente il nostro stesso sguardo: quanto siamo disposti ad ascoltare voci palestinesi quando non si conformano alle nostre aspettative? Quanto siamo pronti a riconoscere l’umanità anche quando si manifesta in forme che ci sfidano o ci turbano? La vera umanità, ci ricorda El-Kurd, non è compatire chi ci somiglia, ma riconoscere il diritto alla giustizia come diritto universale.