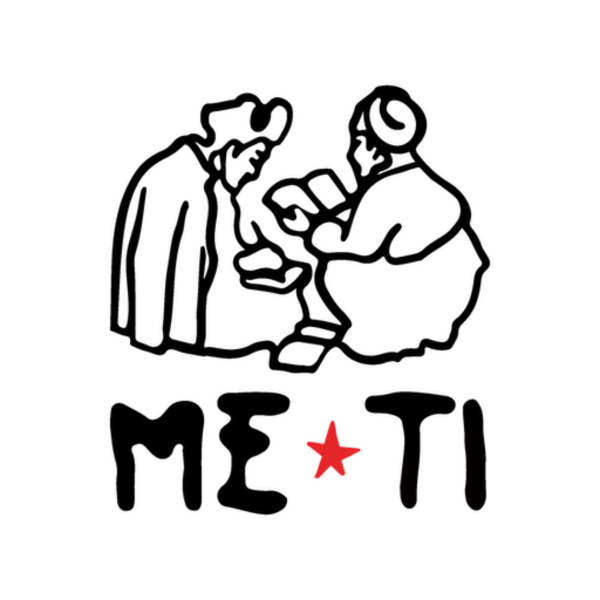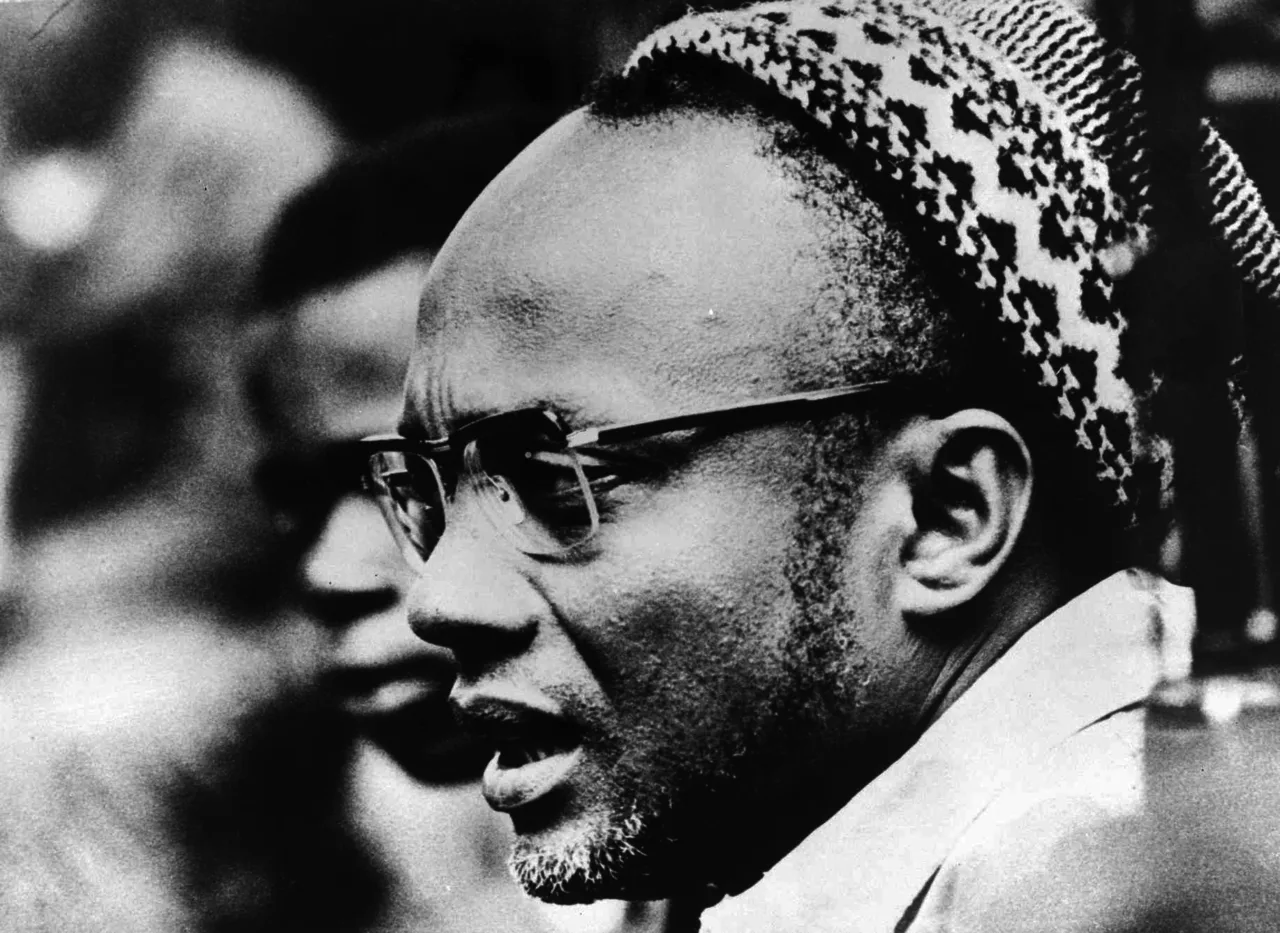Traduciamo questo articolo di Henrique Canary pubblicato nell’agosto del 2024 sul sito di Jacobin America Latina. Canary riflette sul ruolo strategico delle forze rivoluzionarie in questa fase storica unica che combina tre elementi: una disfatta economica di dimensioni globali, una crisi della soggettività proletaria e, di conseguenza, un rafforzamento egemonico delle estreme destre. Che fare per uscire da questa apparente impasse? L’illustrazione è di Tomi Pomo.
***
Quando si parla dell’ascesa dell’estrema destra nel mondo contemporaneo, si pone molta enfasi sulla crisi economica del 2008. È in effetti la strada giusta. Il crollo finanziario derivato dal fallimento della piramide subprime delle banche statunitensi sembra essere stato il detonatore di una vertiginosa crescita delle forze neofasciste in tutto il mondo. Da allora, la maggior parte dei grandi eventi della lotta di classe internazionale hanno portato al rafforzamento delle forze più reazionarie dello spettro politico.
Le Primavere Arabe, che avevano portato un’ondata di speranza in tutto il mondo, specialmente tra i giovani, si è conclusa con il massacro dei Fratelli Musulmani in Egitto e il ripristino di un regime bonapartista nel Paese; con l’assassinio sommario e sanguinario di Muammar Gheddafi in Libia e la trasformazione di una repubblica relativamente prospera in un proto-Stato semitribale controllato da potenze straniere e “signori della guerra”. In Siria ha portato a una guerra civile durata quasi un decennio e alla fondazione, seppur effimera, di un califfato guidato dallo Stato Islamico1.
Il lento declino dell’Unione Europea, unito alla crisi migratoria, ha favorito l’ascesa del neofascismo europeo, che continua i suoi sforzi per conquistare il controllo del continente dopo quasi ottant’anni. La rivolta di Piazza Maidan in Ucraina, che inizialmente contava su una forte presenza della sinistra, ha creato un regime che normalizza il nazismo storico e incorpora forze apertamente fasciste nell’esercito del Paese.
Le massicce proteste del giugno 2013 in Brasile, anch’esse inizialmente contestate dalla sinistra, hanno portato all’ascesa al potere del golpista Michel Temer attraverso l’impeachment di Dilma Rousseff e poi alla vittoria elettorale del fascista Jair Bolsonaro. Negli Stati Uniti, il neofascista Donald Trump è il candidato naturale assoluto della classe operaia bianca tradizionale e, ora, con la cattiva performance del governo Biden, sta avanzando pericolosamente anche tra i giovani e la comunità nera2. In Argentina, l’alta inflazione e il forte calo del tenore di vita hanno risvegliato il mostro Milei.
Ma qualcosa manca in questa analisi. L’affermazione che l’estrema destra avanza esclusivamente a causa della crisi economica del 2008 non sembra corrispondere alla complessità del fenomeno. Non è la prima volta nella storia che scoppia una crisi economica. Abbiamo avuto molti crolli finanziari dalla fine della seconda guerra mondiale (la crisi petrolifera del 1973, la crisi del debito degli anni ’80, la “bolla dot-com” del 2000), ma il fascismo non è mai tornato in questo modo sulla scena della Storia. Ora invece succede. Perché?
La nostra ipotesi è che ci sia stata una combinazione speciale: per la prima volta nella storia, una debacle economica di dimensioni globali si è combinata con l’apice (o, se si preferisce, il fondo) di una crisi soggettiva del proletariato: una crisi che coinvolge la sua identità, le sue organizzazioni, il suo immaginario e la sua coscienza. Questa combinazione specifica ha impedito alla sinistra in generale – sia quella riformista che quella anticapitalista – di posizionarsi come alternativa in grado di contestare questi processi. La crisi economica ha trovato un proletariato disperso, precario, confuso, diviso, soffocato dalla concorrenza tra pari, disposto a dare la colpa della propria amarezza a persone della sua stessa classe, purché fossero nere, immigrate, LGBTQI, arabe o indigene.
Crisi del capitalismo, opportunità per la sinistra?
L’ideologia liberale sostiene che le crisi sono anche momenti di opportunità: per guadagnare denaro, per sconfiggere un concorrente, per avviare una nuova attività. In altri modi, la sinistra ha interiorizzato la stessa idea. È comprensibile. I momenti di stabilità del capitalismo sono più difficili per la sinistra: benessere generale, crescita salariale, concessioni, piena occupazione. In queste condizioni non si verificano crisi rivoluzionarie, perché queste richiedono, tra l’altro, che la società entri in un periodo di decadenza e regressione. Ecco perché la sinistra ha sempre visto di buon occhio le crisi del capitalismo.
La storia ha giustificato, in una certa misura, queste speranze. La crisi economica, sociale e politica derivante dalla Prima Guerra Mondiale ha scatenato la Rivoluzione Russa; la crisi del dominio coloniale portoghese ha portato alla Rivoluzione dei Garofani; la crisi delle dittature latinoamericane è sfociata in diverse rivoluzioni democratiche nel Cono Sud negli anni Ottanta, provocando la crescita e il radicamento sociale delle forze di sinistra nel continente. Questo schema generale (crisi = possibilità di rivoluzione) è rimasto impresso nell’immaginario della sinistra, che ad ogni turbolenza del capitale pensa in segreto: “finalmente è arrivato il nostro momento”.
Il problema è che questo schema ignora un fattore importante della realtà. Affinché una situazione rivoluzionaria sia vittoriosa per la sinistra, non basta che “quelli di sopra non possano e quelli di sotto non vogliano” vivere come prima. Questa formula leninista serve a identificare la crisi in sé, ma non a risolvere il problema del suo esito. Affinché una rivoluzione trionfi, le masse nelle loro azioni devono adottare un determinato programma che può essere fornito solo da un’organizzazione o da un fronte di organizzazioni della sinistra rivoluzionaria. In altre parole, la risoluzione positiva di una crisi rivoluzionaria dipende fondamentalmente da un fattore soggettivo.
L’estrema sinistra dogmatica ha interpretato questo “fattore soggettivo” come la semplice esistenza di un nucleo rivoluzionario attivo, anche se con un peso irrisorio nella realtà. È sufficiente che un piccolo gruppo di compagne/i “sollevi un programma” perché, prima o poi, le masse riconoscano il merito dell’organizzazione e la seguano sulla via dell’assalto al cielo. Un’analisi superficiale potrebbe associare questa visione messianica ai gruppi trotskisti, ma non è così. La realtà ha dimostrato che il messianismo estremista è una caratteristica distribuita democraticamente tra tutte le correnti del marxismo, comprese tra diversi agglomerati stalinisti che agiscono proprio sulla base del principio della “crisi di direzione”.
Secondo questo punto di vista, la qualità fondamentale di un rivoluzionario non è l’intelligenza politica, ma solo la perseveranza. Si tratta di una visione teleologica secondo la quale una piccola organizzazione rivoluzionaria è destinata a diventare grande una volta che le masse “comprendono” il vero carattere delle direzioni di traditori e riformisti.
In questo modo, una parte della sinistra radicale è diventata sempre più oggettivista, cioè crede che le “condizioni oggettive” siano sufficienti per il trionfo di una rivoluzione. Questo oggettivismo è certamente positivo rispetto alla visione scettica secondo cui le condizioni materiali per la rivoluzione socialista non sono ancora mature (come sosteneva il riformismo classico del XIX secolo). Tuttavia, data la complessità e l’importanza del fattore soggettivo, questo oggettivismo è certamente insufficiente e persino dannoso.
A sua volta, porta questa stessa parte della sinistra radicale a sostenere acriticamente qualsiasi processo di lotta o insurrezione, indipendentemente dalla sua direzione, dal suo programma, dal suo significato e dalla sua strategia. Tutto è giustificato perché l’entrata in scena delle masse sarebbe l’unico fattore determinante.
Lezioni degli ultimi decenni
Il problema è che questo schema si è sgretolato negli ultimi trent’anni. Almeno dalla fine dell’URSS e dal trionfo del neoliberismo e della globalizzazione, le masse sono state precipitate in una profonda crisi soggettiva con gravi implicazioni oggettive. L’idea del socialismo è stata screditata ed è passata dall’orizzonte politico all’orizzonte storico. Ciò significa che le masse non vedono più le organizzazioni di sinistra come “alternative” naturali e ovvie, né il socialismo come un fine da perseguire. La crisi soggettiva è così grande che non solo vengono messe in discussione le idee del socialismo, ma perfino le idee dell’Illuminismo: la ragione, la dignità umana, la scienza, la cultura.
L’ingenua convinzione che le masse non agiscano contro i propri interessi è stata annientata e il suo esatto contrario è stato dimostrato ad ogni passo. Così, in ogni nuova “crisi”, l’“alternativa” è rappresentata dalle forze premoderne del fascismo, sia politico che religioso. Il crollo della ragione neoliberista è stato interpretato come il crollo della ragione stessa. Nulla di più naturale, quindi, della crescita dell’oscurantismo, perfettamente espresso dalle forze fasciste.
Quando esplodono i processi di lotta, le forze del progresso storico rappresentate dal socialismo si dimostrano incapaci di contestare la direzione degli eventi e vengono facilmente messe da parte dall’estrema destra. La sinistra era presente nel giugno 2013 in Brasile, ma è stata esclusa dalle manifestazioni dall’estrema destra organizzata; ha combattuto in piazza Maidan nel gennaio 2014, ma è stata massacrata al grido di “Slava Ukraini” e ha finito per bruciare nell’incendio della Casa dei Sindacati di Odessa nel maggio dello stesso anno.
In ogni processo di lotta, l’estrema destra riesce ad allontanare le forze di sinistra dal centro della scena politica. Ciò sarebbe stato inimmaginabile trent’anni fa e può essere spiegato solo con la crisi soggettiva del proletariato. Prima della fine dell’URSS, la lotta di massa favoriva ampiamente la sinistra ed era il suo terreno naturale. Oggi, a causa della confusione del proletariato (e anche del fatto che una parte importante della sinistra ha abbandonato il terreno della lotta diretta), è molto più facile per l’estrema destra imporsi in questo tipo di processi.
Trent’anni fa, la sinistra poteva scommettere sull’aggravarsi della crisi perché c’erano molte possibilità che le fosse favorevole. La destra, invece, si sentiva a proprio agio solo sul terreno istituzionale e parlamentare così come nella repressione poliziesca. Oggi, invece, la mobilitazione di massa è un terreno conteso a mani basse tra fascismo e sinistra, con un vantaggio per il primo nella maggior parte dei casi.
Non si tratta solo di un vantaggio soggettivo. Il fascismo non è solo estremamente motivato. Opera in condizioni materiali molto più favorevoli (non dimentichiamo che, per Marx, la coscienza delle masse è una forza materiale) perché si rivolge al senso comune e ai pregiudizi profondamente radicati tra le lavoratrici e i lavoratori. Negli anni ’30, essere operaio era quasi sinonimo di essere antifascista. Il fascismo era concentrato tra la piccola borghesia e i contadini. Oggi il fascismo è all’interno della nostra classe. Ciò che ha aperto spazio alla destra è stata la crisi della soggettività proletaria. Ecco perché la situazione è molto più difficile che negli anni ’30 e il risultato potrebbe essere anche peggiore.
Dalla frustrazione alla reazione
Ci sono quindi due crisi in atto: la crisi generale del capitalismo e la crisi soggettiva del proletariato; la loro combinazione rafforza l’ascesa dell’estrema destra. Ma a queste due crisi bisogna aggiungere un terzo fattore: i limiti delle esperienze, negli ultimi anni, dei governi di sinistra e progressisti. Questo ha generato un sentimento di frustrazione nei confronti della gestione e delle idee progressiste che è stato sfruttato nei migliori dei modi dalle forze fasciste.
Nel 2015, il popolo greco ha dato a Syriza l’opportunità di dimostrare il proprio valore. Il sentimento generale tra le masse greche era di sostegno incondizionato al nuovo governo, di rifiuto della Troika (la Commissione Europea, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Centrale Europea) e di richiesta di riforme di ampio respiro che tenessero conto della storia di oppressione del Paese da parte dell’Unione Europea. Contro le aspettative popolari, Alexis Tsipras e Syriza optarono per la conciliazione con la Troika e l’attuazione di un piano di ripresa nel quadro dell’austerity. Il risultato è stato il progressivo indebolimento del governo fino alla sua sconfitta contro la destra tradizionale, incarnata dalla coalizione Nea Dimokratia, nel 2019.
Allo stesso modo, altri esperimenti di sinistra hanno portato alla frustrazione delle aspettative e al conseguente riallineamento di una parte significativa delle masse con le forze di estrema destra che si propongono come alternativa radicale alla crisi strutturale.
In quasi tutta l’America Latina, le correnti di estrema destra hanno saputo reagire ai timidi tentativi di riforme popolari degli anni 2000 e 2010 e sono arrivate al potere grazie alla manipolazione del malcontento popolare (fake news, boicottaggi governativi, violenza politica, etc.). Questo rappresenta un importante campanello d’allarme per i governi di sinistra o progressisti ancora attivi nel continente, come nel caso di Lula in Brasile, Gabriel Boric in Cile e persino Gustavo Petro in Colombia. Sebbene quest’ultimo abbia finora cercato di distinguersi dalle dinamiche generali – applicando una politica più offensiva basata sulla mobilitazione delle masse e attaccando il parlamento da sinistra – se non si affrontano i problemi storici di questi Paesi e si continuano ad accumulare promesse elettorali non mantenute, il pericolo che si verifichi una nuova “onda bruna” in tutto il continente sarà sempre più reale. L’Argentina indica proprio questa seconda direzione.
L’unità della sinistra, ieri e oggi
La lotta contro il fascismo nel XX secolo si è svolta in condizioni completamente diverse da quelle attuali. La classe operaia era relativamente omogenea, sia dal punto di vista sociale che economico, politico e culturale. Inoltre, c’erano due forze essenziali nella sinistra: quelle comuniste e quelle socialdemocratiche. Entrambe avevano un’influenza di massa e si contendevano l’egemonia sul proletariato. Così, la lotta per l’unità era anche la lotta per un programma per rompere con il capitalismo e far avanzare il socialismo.
Oggi le cose sono molto diverse. La lotta contro l’estrema destra attuale si svolge in un quadro molto più difensivo, di sconfitta storica e di crisi della soggettività proletaria. Un’unità che ha come condizione la rottura immediata con il capitalismo è un’unità impossibile e quindi perfino dannosa per la lotta. Inoltre, il rapporto di forze tra forze riformiste e rivoluzionarie non è più lo stesso.
Nel XX secolo, la lotta per l’egemonia era tra due forze comparabili, simili per peso e influenza. Oggi non è più così. Le organizzazioni riformiste si sono allontanate molto dalle forze rivoluzionarie, che, a loro volta, sono state ridotte a piccoli gruppi di propaganda. Che confronto si può fare oggi tra il PT e le correnti rivoluzionarie brasiliane? Tra il peronismo e la sinistra trotskista argentina? O tra il PS e i piccoli gruppi rivoluzionari che popolano il Bloco de Esquerda in Portogallo?
Le condizioni per l’unità sono cambiate, e non proprio a favore delle forze rivoluzionarie. Non si tratta di “imporre al riformismo un programma rivoluzionario di rottura”, ma di serrare i ranghi attorno a bandiere difensive, minime, democratiche. Questa è la realtà che dobbiamo affrontare. Se orientiamo le nostre azioni intorno alla necessità di una rottura immediata con il capitalismo, saremo condannati ad agire come semplici testimoni, al massimo come propagandisti.
L’unità contro il fascismo non deve basarsi su un programma di rottura con il capitalismo, ma su bandiere che ravvivino la mobilitazione e l’attività indipendente delle masse, condizione necessaria – anche se non sufficiente – per far avanzare la loro coscienza e superare la loro crisi soggettiva. L’obiettivo immediato delle forze rivoluzionarie non deve essere quello di cercare di sostituire il capitalismo con una rivoluzione antifascista che diventi immediatamente anticapitalista, ma quello di avanzare il più possibile nell’auto-organizzazione, nella coscienza, nella solidarietà e nella volontà di lotta.
Un passo indietro per farne due avanti
È necessario riconoscere che questo orientamento è in contraddizione con gli orientamenti dei classici del marxismo che hanno elaborato la lotta antifascista, in particolare Leon Trotsky negli anni ’30. Per il fondatore dell’Armata Rossa, la lotta antifascista non era solo una lotta unitaria di tutta la classe (questo aspetto, come abbiamo cercato di sottolineare, rimane valido), ma anche una lotta anticapitalista diretta, un tentativo di tradurre la resistenza antifascista in rivoluzione proletaria. Ne è prova il peso centrale dello slogan dell’armamento immediato del proletariato per la lotta contro il fascismo.
Riteniamo che questo orientamento non sia più valido, data la crisi di soggettività del proletariato. Non abbiamo più un proletariato concentrato e organizzato, disposto a lottare ma privo di un orientamento chiaro, come negli anni Trenta. Quello che abbiamo è una dura controversia ideologica e politica, perché una parte della classe operaia è stata conquistata dal fascismo. Cercando di imporre un programma anticapitalista alle forze riformiste alleate (maggioritari all’interno del movimento di massa), le/i rivoluzionari/e non ottengono altro che eliminare la possibilità di unità e perdono l’opportunità di entrare in contatto con un ampio strato della classe operaia guidato dal riformismo.
Pertanto, l’idea che la lotta antifascista si basi su un programma minimo di mobilitazione, educazione e indipendenza di classe deve essere portata alle sue estreme conseguenze. Noi rivoluzionari dobbiamo fare un passo indietro perché il proletariato ne ha già fatti troppi e si sta allontanando sempre più, quasi fuori dalla nostra portata. Dobbiamo riconquistare la fiducia della classe, che ora si lascia sedurre dai canti delle sirene dei fascisti. Nonostante tutte le debolezze, le/i compagne/i ci stanno provando: lavoro nei quartieri, nei territori, con le popolazioni indigene, in lotte locali specifiche, attraverso campagne e reti di solidarietà.
Si tratta di un approccio riformista? Nella forma, sì. In sostanza, è l’azione più rivoluzionaria del nostro tempo: riconnettersi con le masse. Si parla molto del fatto che la sinistra si è allontanata dal lavoro di base. In parte è vero, anche se ci sono disparità e una buona dose di pregiudizio in questa affermazione. In ogni caso, è vero che la sinistra è emarginata. In effetti, anche la sinistra elettoralmente egemonica non è mai stata così marginale.
La nuova normalità
Stiamo entrando in una fase storica in cui le azioni del neofascismo e la sua battaglia delle idee contro la sinistra sono la nuova normalità. Non si tratta di un ciclo breve né di una semplice congiuntura. Si tratta di un fenomeno strutturale e globale. Entrano in gioco la crisi del proletariato, la distanza storica dalla sconfitta del nazifascismo tedesco (il tempo è nemico della memoria), le crisi economica, sociale, migratoria, ambientale e del sistema mondiale degli Stati. Tutto contribuisce a farci affrontare un lungo periodo di lotta contro il fascismo, che è quindi il compito fondamentale della fase storica attuale.
Una corretta comprensione della natura delle fasi storiche, delle loro caratteristiche, possibilità e limiti è sempre stata una condizione imprescindibile – anche se, ancora una volta, non sufficiente – per il successo. Lo stesso vale oggi. La fine dell’URSS, la valanga neoliberista degli anni ’90, la crisi economica del 2008, l’attuale “policrisi”, tutto contribuisce a plasmare questo nuovo momento che stiamo vivendo, un momento di scontro con l’estrema destra in cui è in gioco la sopravvivenza stessa del progetto storico del socialismo.
Coloro che insistono su un orientamento dogmatico, basato su una realtà di cento anni fa e quindi su una classe lavoratrice completamente diversa, tendono a perdere un’importante opportunità: quella di partecipare a un lento ma essenziale processo di riorganizzazione e recupero della coscienza, che può avvenire solo con intelligenza politica, pazienza storica e senso della strategia.
- [NdT] Sulla caduta del regime di Assad in Siria l’8 dicembre 2024, vedi la nostra analisi “Nel chiaroscuro dell’alba. Una prospettiva internazionalista sulla crisi siriana”. ↩︎
- [NdT] Sull’amministrazione Trump 2.0 vedi i nostri approfondimenti dedicati rispettivamente ad un’analisi degli esiti elettorali, alla strategia della controffensiva imperialista USA e ad un affondo sui dazi. ↩︎