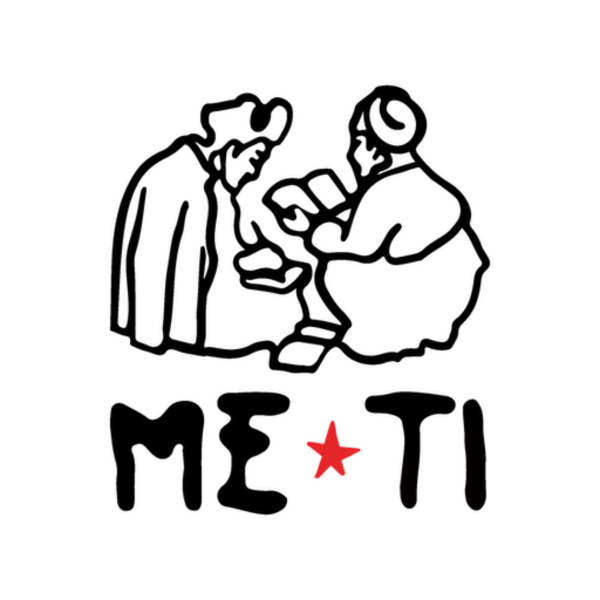Trumpismo, ICE e “nemico interno”
“Il paese si sta disintegrando! Cos’è successo all’America?! Cos’è successo al sogno americano?!”
“Si è avverato. Ce l’hai davanti”
(Watchmen, Alan Moore)
Costruire la Reazione, scatenare la repressione
Lungi dall’essere una “scheggia impazzita”, come vorrebbero lasciar intendere i Democratici, Trump sta perseguendo una strategia politica minuziosamente progettata e ampiamente annunciata fin dalla sua campagna elettorale. La sua ricetta per il fronte interno è sempre stata ossessiva e martellante nella sua semplicità: “deportazioni di massa”, “rafforzamento del confine” e “più polizia” per fermare la fantomatica “invasione di migranti”, obiettivo da raggiungere immediatamente e a qualsiasi costo (umano o economico), per salvare “l’anima” del paese e proteggersi dai “criminali,” dai “ladri di lavoro”, in ultima analisi, dagli “animali”. Non a caso, già nel primo (!) giorno di mandato, Trump ha firmato diversi ordini esecutivi necessari proprio per autorizzare queste politiche, seguiti rapidamente da ulteriori direttive e leggi volte ad aumentare i poteri, gli uomini e i mezzi dell’ormai famigerata ICE (Immigration and Customs Enforcement). Il culmine di questo processo si è raggiunto il 4 Luglio (sul valore e il significato ideologico-propagandistico di questa scelta si tornerà più avanti), quando è diventata legge la cosiddetta One Big Beautiful Bill, che istituisce un incremento progressivo dei fondi destinati all’ICE, che raggiungeranno i 100 miliardi nel 2029: ciò significa arrivare ad avere un budget superiore a quello dell’intero esercito tedesco (88.5 miliardi nel 2024, il quarto budget militare al mondo) e ad avere un numero di agenti doppio rispetto all’FBI. Le conseguenze di questi sette mesi di provvedimenti reazionari sono, purtroppo, sotto gli occhi di tutti e raggiungono di giorno in giorno nuovi livelli di barbarie e di violenza: dai raid condotti perfino all’interno di strutture sanitarie e scuole, ai centri di detenzione che non sono altro che tende e gabbie circondate dalle paludi della Florida, fino alle deportazioni con voli diretti in paesi terzi senza celebrare alcun processo. Solo pochi giorni fa, Trump ha aggiunto l’ennesimo tassello al suo disegno cesarista dichiarando una presunta “emergenza crimine e senzatetto a DC”, così da mobilitare la guardia nazionale e provare (per ora senza esito) a prendere il controllo diretto della polizia della capitale USA, sfruttando una clausola dell’Home Rule Act, che consente un tale atto in “condizioni speciali di natura emergenziale”.
Ma come e perché è stato possibile costruire una tale macchina repressiva? Scavando sotto la superficie della barbarie, emergono le fondamenta dell’intero impianto trumpiano: la mistificazione dei dati fino alla post-fattualità e la narrazione ideologico-propagandistica.
Non è vero ciò che è vero, è vero ciò che serve
Già la prima presidenza Trump era stata caratterizzata da un diffusissimo e sistemico impiego di fake news, si pensi a quelle sul COVID, o sui brogli elettorali, non è quindi sorprendente notare che rientrano nella stessa categoria anche “l’emergenza migranti” o “l’emergenza crimine a DC”. È sufficiente consultare i report pubblici (!) dello stesso governo USA (!), infatti, per scoprire che negli Stati Uniti -rispetto ad una popolazione di 340 milioni di abitanti- risiedono circa 11 milioni di undocumented immigrants, ovvero migranti “irregolari”, un numero non solo risibile, ma pressoché stabile dal 2005; inoltre, quasi due terzi degli “irregolari” sono long-term residents, ovvero risiedono nel paese da più di dieci anni. Allo stesso modo, sono i report della stessa polizia di DC a smentire le dichiarazioni del Tycoon sullo stato di “completa e totale illegalità” in citta: tra il 2024 e il 2023 il tasso di omicidi, rapine e furti a DC è diminuito, un dato peraltro in linea con quanto sta avvenendo in tutto il paese, in cui si registra un calo costante dei reati da almeno 20 anni; similmente, non solo il numero di senzatetto a DC è più basso che nel 2010 (!), ma è uno dei più bassi in tutti gli USA. Il che ci consegna la domanda: ma allora perché Trump mente? Non perché è un “bugiardo patologico”, né perché è brutto, sporco e cattivo, come si ostinano a ripetere da anni i Dem, ma perché mentire è una tattica ragionata, una tattica che funziona: il 77% degli americani (e il 92% dei Repubblicani) ritiene che il crimine sia in aumento, il 56% degli americani è favorevole ad un’espansione del muro al confine Messico-USA, il 78% dei Repubblicani e dei simpatizzanti Repubblicani approva le politiche di deportazione trumpiane, così come il 9% dei Democratici e dei simpatizzanti Democratici (!). Trump mente -sistematicamente e scientificamente- perché mentire in questo modo contribuisce a creare egemonia tra gli elettori e ad intercettare le percezioni e i desiderata degli statunitensi, a loro volta influenzati dalle fake news di cui sopra, in un perverso meccanismo dialettico. In ultima analisi, operare in questo modo consente a Trump di avere mano libera nel portare avanti i propri interessi di classe non solo indisturbato, ma perfino appoggiato. In quest’operazione sovrastrutturale, il piano ideologico-propagandistico ricopre un ruolo cruciale e la capillarità dello sforzo profuso da the Donald in tal senso è sintomatica: nella macchina repressiva statunitense gli ingranaggi della post-fattualità sono ben oliati dalla narrazione trumpiana
Trump, le sirene del MAGA e le colpe dei Democratici
Una delle interpretazioni fondamentali della campagna presidenziale USA del 2020 è stata quella della “battaglia per l’anima del paese”, lanciata, ribadita e rivendicata da Biden prima, durante e dopo la sua presidenza. Trump ha subito sposato questa lettura e l’onda lunga di questo topic è arrivata -quattro anni dopo- fino alla prima tappa del suo campaign trail, in cui ha definito le elezioni in corso come la “battaglia finale”, promettendo non solo di rendere nuovamente grande l’America, ma di ripristinare il sogno americano, rendendolo però “più grande, migliore, più forte di quanto sia mai stato prima”. Le promesse elettorali (tragicamente mantenute) delineano precisamente la fisionomia del sogno americano trumpiano: “il più grande programma di deportazioni della storia statunitense”, dazi commerciali, sgravi fiscali ad aziende e ricchi, tagli a Medicaid, Medicare e Obamacare, via libera alle escavazioni, alla costruzione di gasdotti, raffinerie, pozzi petroliferi, centrali nucleari, ritiro dall’accordo di Parigi, guerra alle università e agli studenti non allineati, guerra al dissenso, guerra alle politiche LGBTQI+ e all’aborto. Un sogno (proibito) per un’America percepita in mortale pericolo: quella America bianca, cristiana, razzista, nazionalista, patriarcale, autoritaria, votata all’ordine e alla disciplina, capitalista e produttivista, ovvero, usando le parole della controparte: un’America “non più woke”. Ma, al netto degli spauracchi del Tycoon, quest’America è veramente così lontana da quella liberal? Qual è l’american dream di Obama-Biden-Harris? Qual è l’anima dei loro USA? Cos’è esattamente l’America woke difesa dai Democratici? Una palude: un paese rinchiuso in un eterno presente, che non ha mai rinunciato al capitalismo più sfrenato né all’imperialismo più rapace, in cui la salute non è un diritto, in cui il razzismo istituzionale è una realtà, un paese in cui le grandi corporations non devono temere leggi contro il loro strapotere, in cui nessun ricco “deve essere punito”, né deve “cambiare tenore di vita”, in cui non c’è bisogno di una rivoluzione politica perché potrebbe “scombussolare tutto”; un paese, insomma, in cui non deve fondamentalmente cambiare nulla. Sulla stessa falsariga, è utile ricordare che durante il primo governo Trump sono state deportate 1.1 milioni di persone, numero serenamente eguagliato durante il governo Biden, e che, durante i due mandati di Obama, sono state deportate più di tre milioni di persone, raggiungendo il macabro ed imbattuto record di 438.421 persone deportate nel corso del 2013, tanto da fargli meritare il soprannome di deporter-in-chief, ovvero deportatore in capo, o ancora che nel 2021 Harris si è resa protagonista dell’ormai famigerato video-appello diretto ai migranti guatemaltechi, in cui li invitava a “non venire, non venire negli USA” perché sarebbero stati respinti al confine. In una perfetta sovrapponibiltà strutturale, il sogno americano liberal si discosta (e solo in piccola parte) da quello trumpiano unicamente sul piano sovrastrutturale, ma, anche in questo campo, qualsiasi conquista è sempre subordinata ad un intollerabile livello di moderazione e precarietà, si pensi al diritto federale all’aborto: sono passati 52 anni dalla sua legittimazione grazie alla sentenza Roe v. Wade della corte suprema, in questo torno di tempo si sono succeduti 4 presidenti Democratici (per un totale di 24 anni di presidenza) e in tutti i loro mandati c’è stata almeno una maggioranza democratica al Congresso, eppure, non è mai stata varata alcuna legge per proteggere questo diritto, traslandolo dal piano legale a quello politico; come noto, nel Giugno 2022 la corte suprema ha ribaltato la Roe v. Wade, abolendo il diritto federale all’aborto, rendendolo de facto illegale in 13 stati e fortemente limitato in altri 7. Come si può credere che una differenza del genere sia abbastanza per vincere? Nei confini ben delimitati di questo impietoso confronto sovrastrutturale, Trump riesce dove i Dem falliscono: offre una narrazione, un immaginario, uno scopo, un’ideologia, quella del MAGA e del bigger, better, stronger american dream, per cui mobilitare e mobilitarsi; e nel confronto con l’eterno immobilismo post-ideologico e amministrativista dei Democratici, la marcia in più è lampante. Per cogliere a pieno la portata di questo scarto (e l’estrema rilevanza del processo in corso), nulla è più esaustivo della macchina della propaganda trumpiana. Il sito ufficiale dell’ICE si apre con un banner che rimanda immediatamente alla sezione “carriere”, al suo interno, un’icona dello Zio Sam invita ad arruolarsi con queste parole: “questo è un momento cruciale della storia del paese e c’è un bisogno vitale della vostra esperienza e delle vostre competenze. A nome di una nazione riconoscente, vi chiediamo orgogliosamente di servire il vostro paese”; il canale instagram del Department of Homeland Security (a cui l’ICE fa capo) presenta un post in evidenza: “nessun limite d’età, arruolati subito nell’ICE”, inoltre dal 4 Luglio (Independence Day oltre che, come si diceva in apertura, giorno di entrata in vigore della One Big Beautiful Bill) lo stesso canale ospita una rubrica propagandistica fissa, basata sulla ricondivisione di stampe d’epoca (che vedono quasi sempre lo Zio Sam come protagonista) con descrizioni a tema ICE, qui le più significative: “una patria che vale la pena difendere”, “difendi la patria, arruolati nell’ICE oggi”, “difendi il tuo paese, l’America ha bisogno di te, arruolati subito nell’ICE”, “possiamo tornare quello che eravamo”, “la grandezza è una scelta”, “l’eccezionalismo americano inizia nella capitale del paese”. Secondo dati forniti dallo stesso DHS, ad oggi, sono già pervenute 100.000 candidature per arruolarsi nell’ICE; non privo di significato anche il modo scelto per annunciare la notizia: “l’ICE riceve 100.000 candidature di americani patriottici che vogliono aiutare a rimuovere assassini, membri delle gang, pedofili e terroristi dagli USA”. Non stanno tardando ad arrivare, inoltre, i primi endorsment provenienti dal mondo dello spettacolo, con casi emblematici come quello di Dean Cain, che ha dichiarato pubblicamente di essersi arruolato: “il Presidente Trump sta mantenendo le promesse. È quello per cui ha votato la gente. È quello per cui ho votato io e lui lo porterà a compimento. Io farò la mia parte e darò una mano per essere sicuri che succeda”. Livelli tali di mobilizzazione (e polarizzazione) non si vedevano almeno dai primi anni della “guerra al terrorismo” e, considerando da un lato le più che allettanti condizioni contrattuali garantite dall’ICE (50.000 dollari di bonus alla firma del contratto, opzioni per ripagare il proprio student debt, condizioni pensionistiche agevolate) e dall’altro il profilo demografico della maggioranza degli elettori di Trump (maschi, bianchi, a basso reddito), non è difficile immaginare chi andrà ad ingrossare le fila dell’ICE.
E pluribus unum: attualità e prospettive della classe lavoratrice negli Stati Uniti
Il punto di caduta di queste riflessioni non può che essere un’analisi delle condizioni attuali e delle prospettive future della classe lavoratrice statunitense. Senza mezze misure, quest’ultima versa in condizioni disastrose: reduce da mezzo secolo di sconfitte, divisa, precarizzata, scarsamente sindacalizzata e, soprattutto, prigioniera di sponde politiche e sindacali opportuniste, inefficaci e votate alla sconfitta. Sulle colpe dei Democratici si è già detto, sulle loro (mancate) risposte alla repressione trumpiana si dirà brevemente. Neanche di fronte alla barbarie di questi mesi, i Dem sono riusciti a compattarsi e ad assumere una postura di opposizione netta e progressista: non più tardi di Giugno, 75 congressmen Democratici hanno votato a favore di una risoluzione in cui si “esprime gratitudine alle forze dell’ordine, inclusi gli agenti dell’ICE, per aver protetto la patria”; la linea di partito ufficiale è, infatti, ancora una volta quella del compromesso e della moderazione: paralizzati dall’ennesima buzzatiana attesa per le prossime midterm elections, procedono in equilibrio tra la condanna assoluta e insindacabile di qualsiasi risposta conflittuale all’ICE e gli sterili attacchi morali e legalitari contro Trump, appigliandosi alle richieste di fantomatiche “politiche migratorie giuste e umane”. Similmente, al netto di meritori casi di generosità individuale, nessun sindacato numericamente rilevante ha voluto mobilitare i propri iscritti per contrapporsi in maniera chiara (ed economicamente significativa) a Trump, optando piuttosto per mettere in atto sporadiche proteste simboliche e testimoniali; in questo senso è paradigmatico il caso di David Huerta, rappresentante sindacale californiano della SEIU (parte della AFL-CIO) manganellato, ricoverato per le percosse e successivamente arrestato per aver preso parte ad una protesta pacifica contro un raid dell’ICE: in seguito all’arresto sono seguite proteste e messaggi di solidarietà (uno su tutti, quello del governatore californiano Newsom, in quota Dem), ma il tutto è terminato rapidamente e senza tante cerimonie in seguito al suo rilascio su cauzione. Eppure, nonostante il contesto a dir poco proibitivo, a Los Angeles si sono verificate proteste partecipate, multietniche e intergenerazionali, caratterizzate da rivendicazioni radicali (abolish ICE, vale a dire smantellate l’ICE) e da un elevato livello di conflittualità (scontri fisici con l’antisommossa, lancio di oggetti, bombe carta e fuochi d’artificio, barricate, blocchi stradali). Naturalmente, por ahora, si tratta di un episodio circoscritto, nato in una classe lavoratrice ancora lontana dallo sviluppare anticorpi contro gli opportunismi, così come dal produrre forme organizzative autonome e proposte strutturalmente alternative. Tuttavia, già il solo pieno riconoscimento della questione migratoria quale questione economica e della componente migrante come parte integrante della classe lavoratrice statunitense rappresenterebbe un risultato notevolissimo e una maturazione teorica e pratica inestimabile; le premesse, purtroppo e per fortuna, non mancano: se c’è una legge della storia, infatti, è che guerra e repressione possono rappresentare potenti catalizzatori della coscienza di classe. Dopotutto, qualcuno diceva che ci sono dei decenni in cui non accade nulla e delle settimane in cui accadono decenni…