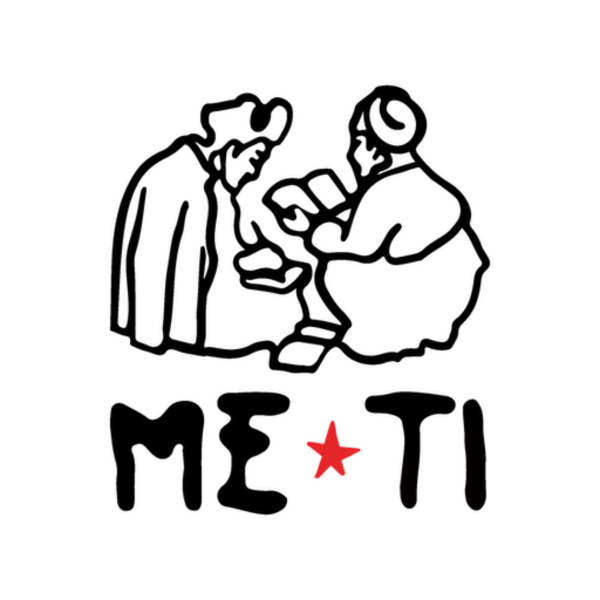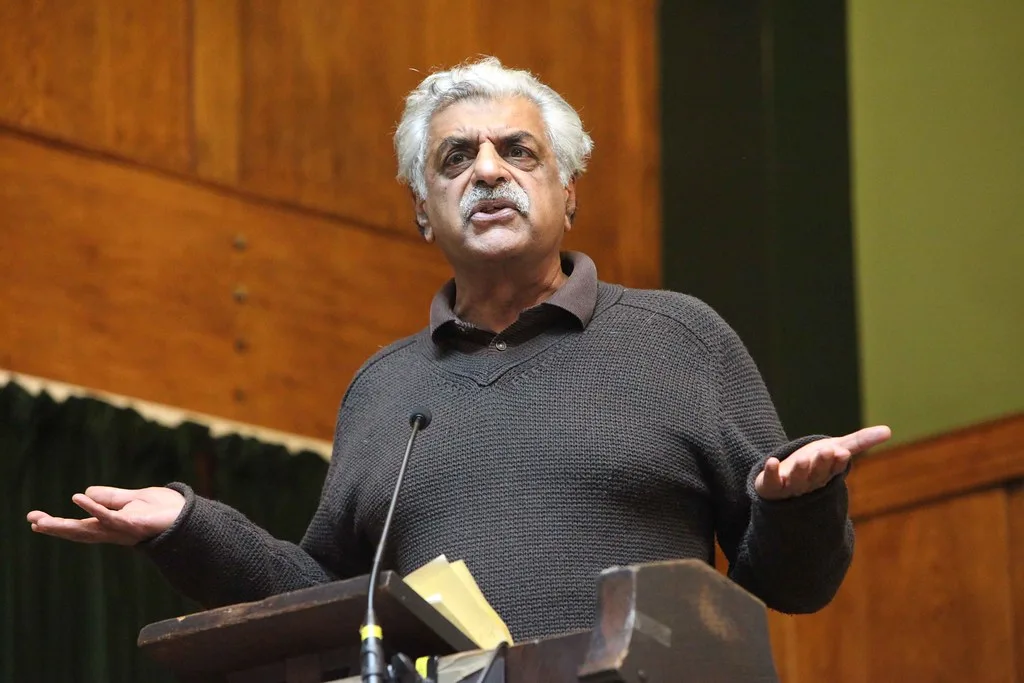In occasione del Forum Internazionale per la Pace che si è tenuto il 23 e 24 giugno 2025 a Bruxelles, diverse forze politiche e sociali europee hanno presentato le loro tesi e posizioni sull’economia di guerra in cui siamo stati gettati dall’Unione Europea e dai diversi governi conservatori e neoliberisti. Durante gli stessi giorni, all’Aia i Paesi membri della NATO, sotto pressione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, hanno firmato un nuovo accordo che prevede un aumento delle spese militari al 5% del PIL.
La continuazione del genocidio in Palestina e il coinvolgimento degli Stati Uniti negli attacchi contro l’Iran ci impone, ancora più di prima, di avere chiarezza sulla nostra prospettiva programmatica. In questo momento storico non possiamo avere nessuna ambiguità sulle posizioni da assumere, né possiamo barattare i nostri contenuti per “accontentare” partiti istituzionali, associazioni pacifiste o chissà chi in nome di un “fronte ampio pacifista” che però non è capace di mettere al centro le contraddizioni maggiori in cui ci troviamo né d’altra parte di incidere nel modificare realmente i rapporti di forza. Assumere queste posizioni in questo momento storico non equivale a un “estremismo”, bensì significa identificare in modo chiaro e netto il nemico che dobbiamo combattere. Sono perlopiù tre i temi attorno ai quali non possiamo concedere nulla.
1. Lo scioglimento completo della NATO e lo smantellamento delle sue basi militari in tutto il continente europeo. L’aumento delle spese militari per i Paesi europei attribuisce all’Europa un nuovo ruolo nella “divisione internazionale del lavoro” all’interno della controffensiva dell’imperialismo USA: nella nuova guerra fredda contro la Cina, gli USA si stanno sempre di più concentrando su un possibile intervento nell’Indo-Pacifico. Questo implica una ridefinizione (leggi: riduzione) dei suoi effettivi bellici in Europa, la quale deve assumere un ruolo centrale sul fronte russo, mentre Israele – massicciamente supportato da USA, Germania e Italia – conferma il suo ruolo di “cane da guardia” degli interessi imperialisti occidentali in un Medio Oriente che detiene un ruolo centrale nel sistema-mondo capitalista per le massicce risorse fossili. Se questi ruoli si vanno sempre più nettamente definendo nello scacchiere internazionale, in una prospettiva antimperialista “fuori la NATO dall’Europa, fuori l’Europa della NATO” non può essere ridotto a un semplice slogan, ma diventa una condizione fondamentale per far uscire l’Europa dalla spirale imperialista e colonialista.
2. Questo impone inoltre una rottura con la sottomissione del continente europeo agli Stati Uniti – militarmente, economicamente e politicamente. Il ruolo degli USA non si manifesta solo nell’alleanza transatlantica, ma anche nella perpetuazione del genocidio contro il popolo palestinese e nei bombardamenti israeliani contro l’Iran. Senza il supporto militare e politico statunitense, Israele non potrebbe condurre la sua politica genocidaria e distruttiva in Medio Oriente. In mancanza di una politica estera comune e indipendente (segno dell’assenza di una vera e propria borghesia europea) e di un’autonomia economica (pensiamo all’immenso peso del capitale statunitense nelle maggiori aziende europee), l’Europa si è semplicemente accodata alla linea dettata dagli USA. Eppure sono gli Stati Uniti che violano costantemente il diritto internazionale e rappresentano quindi la principale minaccia mondiale. La sottomissione dell’Europa agli USA rafforza queste politiche. Un passaggio imprescindibile per lo staccamento dell’Europa dagli USA è il ritiro dei soldati statunitensi e la chiusura delle basi militari USA in tutto il continente.
3. Infine è fondamentale assumere una posizione chiara sull’attuale costituzione dell’Europa: all’interno del quadro politico-istituzionale europeo non può nascere una difesa comune che rispetti i bisogni dei popoli. Molto spesso l’autonomia strategica e militare dell’Europa ci viene presentata come alternativa ai progetti conservatori di rafforzamento degli eserciti nazionali. Si tratta però della solita falsa opposizione tra estrema destra e centro liberale. Queste due opzioni politiche sono oggi più che mai intrecciate e interconnesse (infatti in Francia si usa la categoria “estremo centro” per descrivere in modo molto adeguato il carattere “conservatore” del liberismo dei nostri tempi). Ne è un esempio la politica migratoria: ad inizio giugno, il Premier polacco liberale e pro-europeista Donald Tusk – che contende ai tedeschi e ai baltici il primato nelle politiche guerrafondaie – si vantava del fatto che dal 2022 la militarizzazione e il rigido controllo della frontiera tra il suo Paese e la Bielorussia hanno portato ad aumentare l’efficacia del blocco dei migranti al 98%. Quali sono oggi le differenze tra i governi di destra dura, estrema e fascista e i governi cosiddetti liberali? Nella forma forse qualche differenza la si può ancora trovare – anche se le differenze si riducono sempre di più –, ma nell’epoca dell’economia di guerra i contenuti si sono avvicinati in modo eclatante, fino a coincidere.
Solo con una idea chiara su questi nodi critici fondamentali dei nostri tempi si riuscirà a mettere le basi per la costruzione di un campo politico alternativo a quelli compromessi con il sistema e l’economia di guerra, evitando di scivolare in una politica opportunistica che ambisce più a coprire posizioni all’interno delle istituzioni che a creare le condizioni socio-politiche per rompere con l’ordine stabilito.
Questo richiede anche di identificare i soggetti sociali che oggi possono farsi portatrici e portatori di queste posizioni nella quotidianità delle lotte. Perché solo la mobilitazione popolare diffusa, costante e organizzata ci permette di avanzare su questo campo politico e costruire una reale alternativa. La ricomposizione di un blocco sociale è un passaggio fondamentale in questo lavoro politico. Quindi, dove sono i “nostri“?
1. Le lavoratrici e i lavoratori. Può sembrare banale partire da questa categoria, ma non lo è, soprattutto con alle spalle decenni di riforme che hanno precarizzato il mondo del lavoro e una politica sindacale confederale che ha relegato il conflitto sociale nei libri di storia. Fortunatamente, però, esistono anche controtendenze. In questi ultimi anni i portuali di tutto il mondo hanno dimostrato di poter interrompere il flusso di armi destinate in zone di guerra, iniziando dai portuali di Genova, che già nel 2021 si erano rifiutati di caricare e scaricare una nave destinata in Arabia Saudita che all’epoca era impegnata a bombardare e distruggere lo Yemen. Nel 2022 è poi toccato ai lavoratori dell’aeroporto di Pisa che hanno scoperto che dentro a un carico ufficialmente dichiarato come “aiuti umanitari” si trovavano armi e munizioni destinate all’esercito ucraino. Ultimamente, ad inizio giugno 2025, sono stati ancora i portuali, questa volta quelli di Marsiglia e Salerno, ad impedire il transito di armi destinate a Israele nel genocidio contro il popolo palestinese, infine i lavoratori dell’aeroporto di Brescia-Montichiari a bloccare il trasporto di missili.
L’esempio dei portuali ci dimostra che il potere dei lavoratori aumenta perché le catene globali del valore si estendono sempre di più. Il commercio internazionale connette sempre di più e direttamente operai europei e popolo mediorientale, contadini sudamericani e lavoratori statunitensi etc. Gli investimenti a lungo termine negli armamenti e la conversione dell’industria civile in industria bellica approfondirà questa interconnessione: lo stipendio di un operaio tedesco della Rheinmetall sarà ancora più strettamente legato alla vita di una ragazza palestinese a cui l’esercito israeliano spara – con armi tedesche – mentre è in attesa di ricevere un pacco di farina. Non si tratta qui di assumere una posizione moralista, bensì di riconoscere che il modello economico e industriale capitalistico si è da sempre basato sullo sfruttamento e l’oppressione dei popoli del Sud globale (cosa che alcuni autori, analizzando la crisi ecologica, definiscono come “modo di vita imperiale“) e che questa tendenza in questa fase di crisi generalizzata si intensifica.
In tutta Europa, in nome della “difesa dei posti di lavoro”, i sindacati confederali si sono allineati alle politiche industriali dei vari governi, indipendentemente da quello che si produce nelle fabbriche, dalla loro circolazione nel mercato mondiale e dall’esito del loro “consumo”. Il sindacato tedesco IG Metall ha perfino chiuso il “AK Internationalismus”, un gruppo di lavoro all’interno del sindacato che da decenni ormai era diventata la sua voce antimilitarista, pacifista, internazionalista. Si tratta di una delle più palesi dimostrazioni del funzionamento dell’egemonia: il sindacato, organizzazione della società civile, si fa portatore di una determinata ragione di stato (in questo caso la difesa incondizionata di Israele e l’investimento nell’economia di guerra per ritornare tra i big player della guerra) in cambio di garanzie per i propri “clienti” (gli operai tedeschi).
In altri Paesi i sindacati non agiscono molto diversamente, ma la pressione dei movimenti sociali e antimilitaristi ha avuto anche conseguenze positive sulle loro politiche. In Francia, per esempio, grazie a un minuzioso lavoro fatto da movimenti e partiti della sinistra radicale, i sindacati hanno aderito alla campagna antimilitarista “guerra alla guerra” partecipando a una delle sue principali manifestazioni. Certo, questo non è affatto una garanzia per una loro svolta radicalmente antimilitarista e internazionalista, ma apre degli spazi e ci dimostra la necessità di investire nel campo sindacale, costruendo collettivi operai, rafforzando i sindacati di base e esercitando pressione su quelli confederali.
2. Gli studenti e le giovani generazioni. C’è poco da spiegare: in Occidente il “momento Gaza” ha prodotto una mobilitazione di giovani e studenti per la Palestina, mobilitazione che non si era prodotta in tal modo durante l’apice della resistenza palestinese come nella prima (1987-1993) e la seconda intifada (2000-2005). Il “momento Gaza” ci ha rivelato che ci troviamo di fronte a una generazione che è tutt’altro che indifferente e passiva come molto spesso ci viene raccontata, ma che ha un profondo sentimento di giustizia e uguaglianza. La loro spontanea attivazione di fronte alle immagini del “genocidio in diretta televisiva” ha prodotto occupazioni e acampadas alle università, il rilancio delle campagne BDS e manifestazioni militanti, attività culturali e azioni dirette di sanzionamento di aziende belliche e pro-israeliane.
Si tratta qui del primo ciclo di lotte globali dopo almeno un decennio di quasi totale “pace sociale”. La Palestina infatti non ha solamente svelato il carattere coloniale, imperialista e genocidario di Israele e dell’intero Occidente, ma ci ha permesso anche di riconoscere le condizioni di sfruttamento e oppressione in cui noi ormai ci siamo abituati a vivere. Questo ha aperto una finestra di opportunità per intervenire nella “battaglia delle idee” (vedi per esempio l’opuscolo “La questione palestinese e noi” e il podcast “76 anni e 8 mesi” che lo accompagna); ma non basta formare le e i giovani, vanno organizzati in modo da dare struttura e continuità alla loro militanza politica. Il futuro non è scritto e appartiene a loro.
3. Migranti, rifugiati e seconde generazioni. Il movimento per la Palestina ha svelato anche un’altra cosa: in tutta Europa, migranti e seconde generazioni non compongono solo quantitativamente una parte importante delle nostre società, occupando le posizioni dell’economia più precarie e sfruttate. Negli ultimi due decenni hanno anche composto la parte più disposta a mettersi in gioco e lottare per un miglioramento delle proprie (e altrui) condizioni di vita e di lavoro: durante il ciclo di lotte nel settore della logistica (2011-2015), nelle lotte dei sans-papiers che occupano lo spazio pubblico per rivendicare un permesso di soggiorno e contratti di lavoro, nelle mobilitazioni per i diritti di cittadinanza etc.
A Berlino, Bruxelles, Parigi, Milano, Madrid e tante altre città europee le figlie e i figli di lavoratrici e lavoratori provenienti dal “mondo arabo” compongono la parte più combattiva delle piazze per la Palestina. La Palestina ha contribuito, almeno in parte, a ricomporre politicamente la loro frammentazione sociale. La feroce repressione da parte delle autorità e le dinamiche di movimento hanno però provocato un momento di reflusso e in molti hanno abbandonato le piazze. Di fronte alle esperienze degli ultimi anni, diventa fondamentale dare continuità alla loro mobilitazione, integrandole in una nuova politica di classe e, in questo modo, ricomporre quel “noi” politico tra lavoratori europei e seconde generazioni.
Un altro esempio italiano invece ci offre un elemento interessante nell’ottica di ricostruzione di uno spirito antimperialista tra i nostri. A Torino, Bologna e Napoli, le comunità burkinabé e maliana non si organizzano solo nel movimento migranti e rifugiati per il permesso di soggiorno, ma anche in associazioni in difesa del processo anticoloniale nel Sahel. I colpi di Stato contro la Francia in Burkina Faso, Mali e Niger hanno aperto una finestra di opportunità e prodotto un coinvolgimento politico da parte di ampie fasce di popolazione sia nel Sahel che nei Paesi occidentali. In questo modo, la lotta sociale e sindacale qui è in diretta connessione con la lotta antimperialista lì. Si tratta praticamente di una sorta di capovolgimento della “doppia assenza“: il sentirsi “fuori luogo” prodotto dalle condizioni subalterne di rifugiato/migrante in Occidente si trasforma, grazie alla mobilitazione sociale e antimperialista, in una prospettiva internazionalista che aggancia il movimento anticoloniale nei Paesi di origine a quello dei migranti e rifugiati nei Paesi di accoglienza.
Per sconfiggere l’imperialismo e costruire un mondo di pace, giustizia e uguaglianza – il socialismo – dipendiamo dalle mobilitazioni popolari. Non c’è dubbio che oggi sono specifici settori di lavoratori (portuali, logistica), le giovani generazioni e la componente migrante a trovarsi all’avanguardia di una prospettiva di rottura in Europa. Non possiamo abbandonare le nostre speranze di un radicale cambiamento ai governi antimperialisti e/o di sinistra. Per fermare la militarizzazione delle nostre vite e le guerre genocidarie non ci resta altro da fare che concentrarci sull’organizzazione dei nostri.