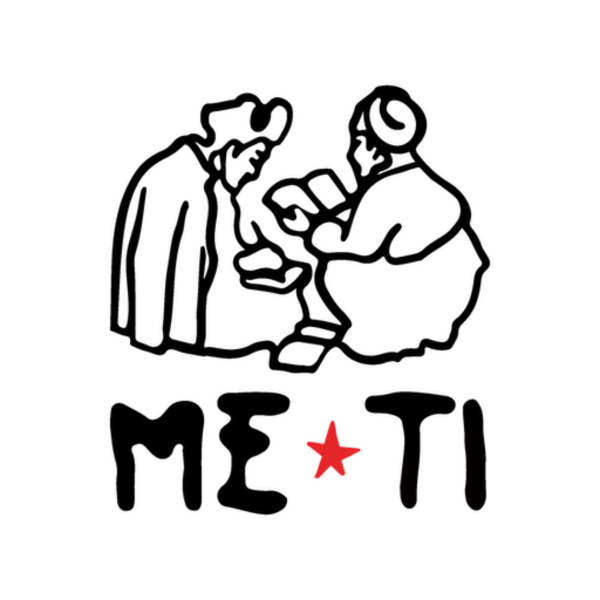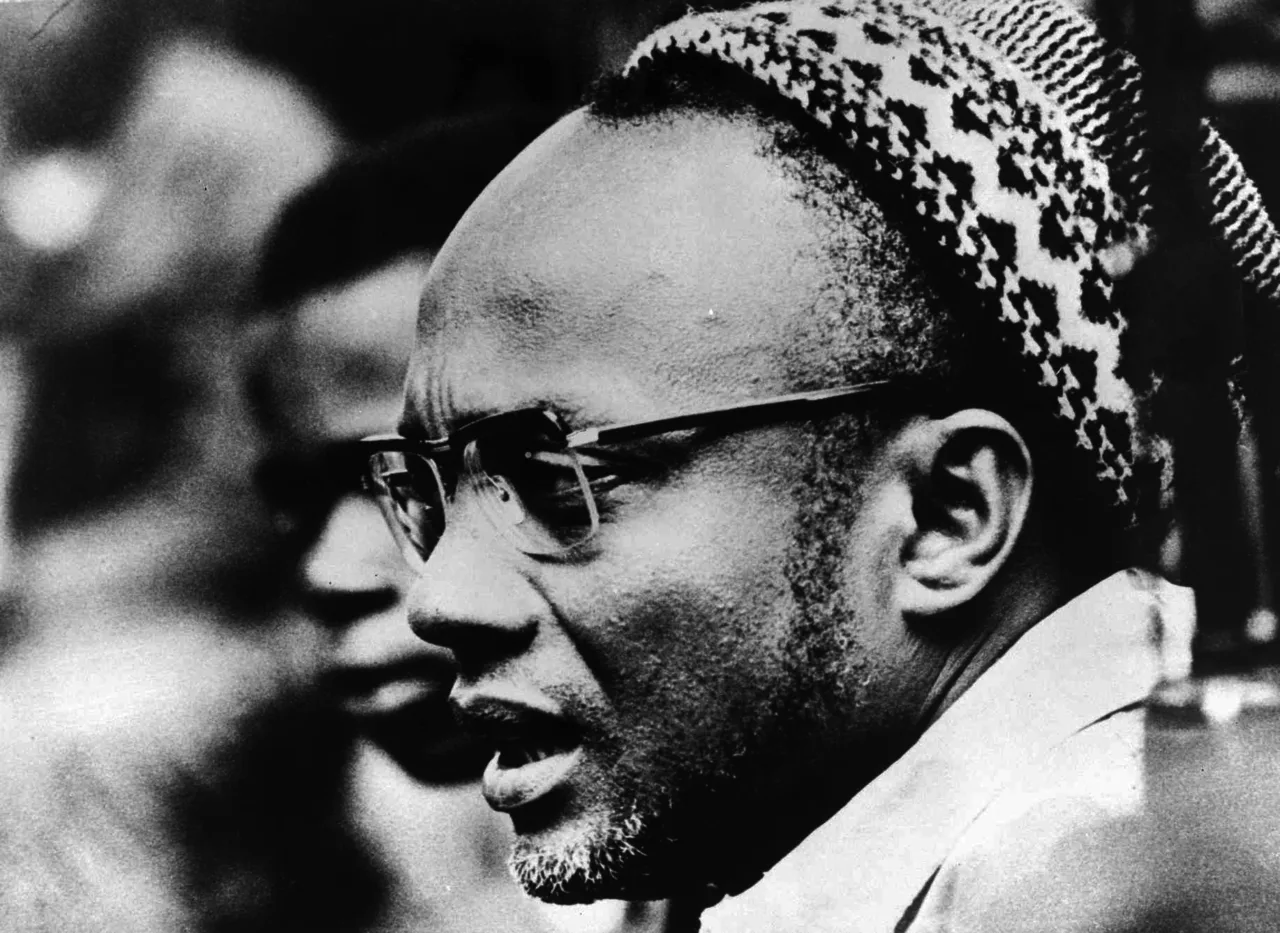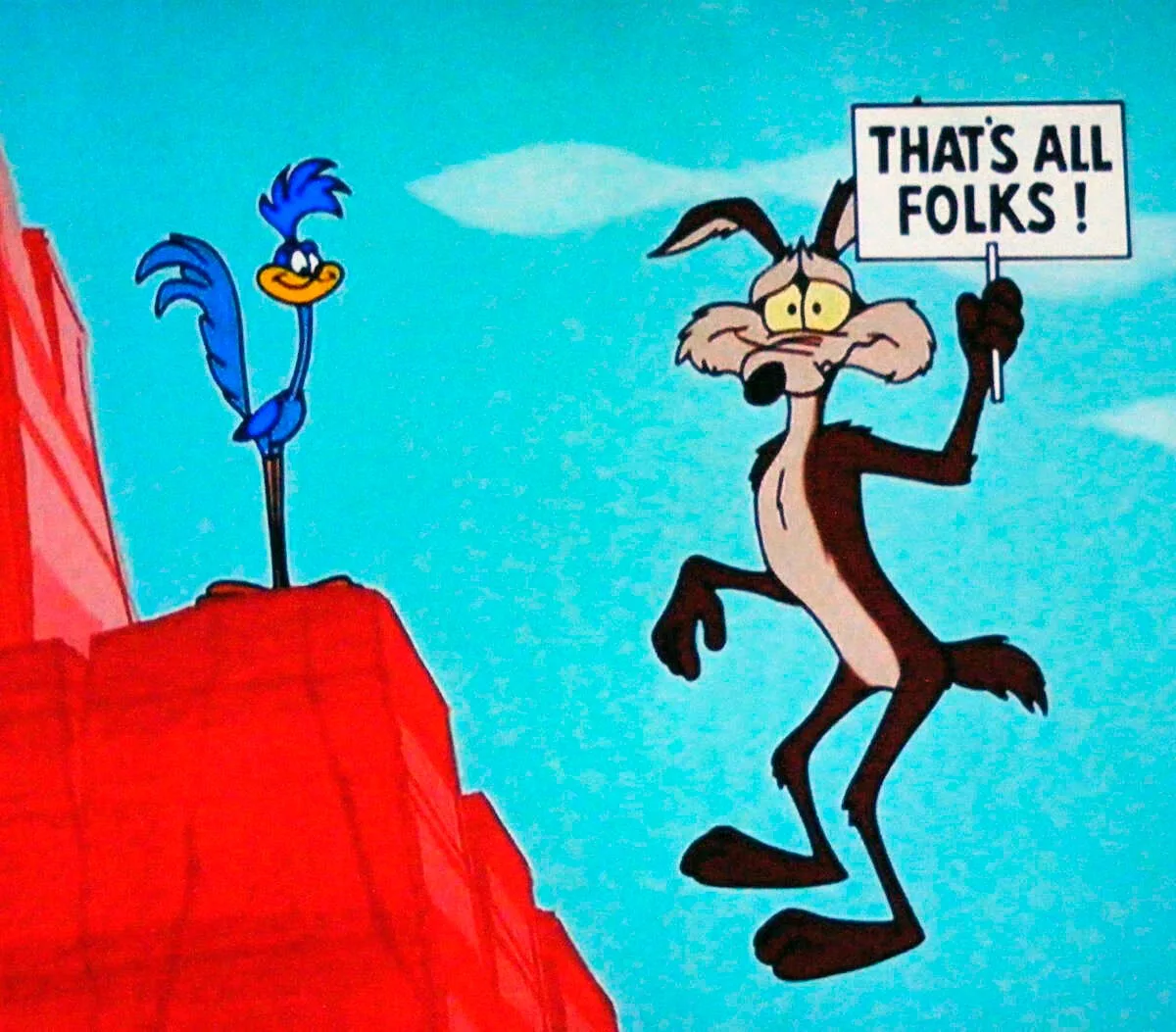Le parole di Roberto Vecchioni, insieme a quelle degli altri ospiti del palco di Piazza del Popolo a Roma lo scorso 15 marzo, hanno fatto emergere ancora una volta il tema della cultura e della identità europee e di che cosa esse rappresentino nei confronti del resto del mondo. Il cantante, infatti, esordisce sottolineando le radici culturali comuni dei singoli stati dell’Unione Europea e procede, utilizzando significativamente una sonante prima persona plurale, elencando diverse qualità di cui gli europei sarebbero depositari: diritti, libertà e soprattutto democrazia (“quella non ce l’hanno tutti, ce l’abbiamo Noi”). Questo discorso, inserito nel contesto in cui viene pronunciato, è molto interessante; la piazza, infatti, è convocata da Michele Serra e intende riunire, stando al giornalista di Repubblica, il popolo di centro-sinistra che sente di condividere i valori identificati come originariamente europei, da difendere dalle minacce internazionali e dal difficile contesto geopolitico1.
Nell’ultimo periodo, del resto, il dibattito italiano è stato attraversato in maniera massiccia e trasversale dal tema dell’identità. Da tempo il partito di governo è stato in prima linea all’interno della discussione in Italia, questa volta di una destra con alle spalle una storia neofascista che, come si apprende dall’introduzione del suo programma politico, si concepisce come alfiere dei valori europei: “Per noi l’Europa rappresenta il nucleo fondante dell’Occidente, quello spazio in cui nella storia hanno preso forma i valori e i principi su cui si basa la nostra civiltà: la libertà, l’uguaglianza, la democrazia, il diritto, l’incontro tra fede e ragione incarnato dalle nostre radici classiche e giudaico-cristiane”2. Tutto questo si traduce in misure concrete adottate dal governo italiano, che decide di inoltrare delle linee guida sull’insegnamento della storia, materia che dovrà rivestire un ruolo centrale nei curricula scolastici. A pagina 69 del documento si legge: «Solo l’Occidente conosce la Storia. Altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia. È attraverso questa disposizione d’animo e gli strumenti d’indagine da essa prodotti che la cultura occidentale è stata in grado di farsi innanzi tutto intellettualmente padrona del mondo, di conoscerlo, di conquistarlo per secoli e di modellarlo». L’impianto che il Ministero dell’istruzione e del merito intende dare è chiaro: la storia dell’Occidente, di cui non si delineano dei contorni precisi, è superiore a quella di altri popoli, ed è per questo che ha potuto dominare anche dal punto di vista materiale.
Quello che preme in questa sede è sottolineare che la costruzione dell’ideologia di una cultura occidentale ed europea risponda a dei fini specifici, che hanno a che fare con la fase storica presente e con la situazione geopolitica sempre più articolata. L’edificio teorico di un Occidente depositario di democrazia, libertà e razionalità, dopo aver giustificato all’inizio del secolo le missioni civilizzatrici militari, la guerra al terrore e la legittimazione di restrizioni sempre più importanti alla mobilità umana, oggi contribuisce all’individuazione di un nemico interno corrispondente al soggetto non conforme al canone, con la conseguente esclusione e marginalizzazione, e di un nemico esterno, utile alle politiche sempre più stringenti di riarmo e di militarizzazione dell’economia. In questo contesto non è utile distinguere tra costruzioni culturali appartenenti a distinzioni politiche, dal momento che sia l’esaltazione della cultura europea proveniente da ambienti progressisti, sia l’urgenza conservatrice di doverla difendere da attacchi esterni rispondono ad una stessa esigenza: quella di esercitare egemonia culturale. È dunque proficuo capire come la costruzione dell’ideologia della cultura occidentale europea sia avvenuta nel tempo.
L’identità occidentale
Il fenomeno della costruzione di un’identità occidentale per nulla neutra non è certamente un fenomeno solamente contemporaneo. È interessante dunque accennare a come questa ideologia dell’identità occidentale si sia formata, e quali siano alcune sue caratteristiche.
In ambito filologico e filosofico, la questione dell’identità e della cultura europea, di che cosa queste rappresentino e della loro crisi risale in verità già all’inizio del XX secolo. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, un caposaldo della filologia classica europea, durante il primo conflitto mondiale, nel 1918, includeva all’interno della Postilla alla seconda edizione del Platon queste parole: “Ho dovuto vedere l’autodistruzione, l’autocastrazione del mio popolo. Nell’oclocrazia e tra gli adulatori vigliacchi e venali, che essa trova in tutte le classi, non c’è più posto per un vecchio che dal cuore non si lascia strappare – da nessun Dio, da nessun uomo – il suo onore di Prussiano. Non gli resta che morire. Ma il regno delle forme eterne che Platone ha dischiuso è indistruttibile, e noi con la nostra scienza siamo al suo servizio: i miasmi della putrefazione non penetrano nel suo puro etere […]. Combatterò sotto il segno di Platone fino a quando avrò fiato.” L’idea di Wilamowitz è che l’Occidente stia attraversando una crisi, e che per capire cosa stia succedente sarebbe necessario tornare all’origine, in quanto la grecità classica costituirebbe la culla della civiltà europea. La crisi della modernità, in questo caso il periodo della Prima guerra mondiale, è per il filologo una crisi in ultima istanza della filosofia: se si vuole rinnovare la filosofia, bisogna tornare agli antichi. Ciò che tiene insieme i tre concetti di civiltà europea, modernità e di filosofia è secondo Wilamowitz la ragione, il logos, che è una prerogativa della grecità. È interessante a proposito osservare che anche un secolo dopo, nella contemporaneità, quando si prende in considerazione la civiltà europea, ciò che caratterizza l’autorappresentazione degli europei e in generale degli occidentali è sostanzialmente l’importanza data alla ragione: la civiltà europea è quella che più di tutto avrebbe messo al centro il logos. Se si riconosce validità a questa idea avviene immediatamente una saldatura con l’antichità: l’origine della civiltà europea viene collocata nella filosofia di Platone, di Aristotele.
Nonostante l’idealizzazione della grecità classica come culla della razionalità e della civiltà europea, è fondamentale riconoscere che questa stessa eredità è stata spesso utilizzata per legittimare strutture di potere oppressive. Mentre Wilamowitz vedeva nel logos greco un antidoto alla crisi della modernità, questo stesso concetto nel corso del tempo è stato impiegato per giustificare divisioni sociali e culturali. La razionalità, celebrata come tratto distintivo dell’Europa, è stata infatti associata a una specifica identità – quella maschile, bianca e occidentale – escludendo chi non rientrava in questi parametri. In questo senso, la stessa tradizione filosofica che Wilamowitz invoca come salvezza è stata anche uno strumento di esclusione, rivelando le ambiguità insite nella costruzione dell’identità europea.
È infatti necessario e urgente sottolineare come il ricorso alla descrizione della cultura europea come portatrice di libertà, di razionalità, di democrazia, legata alla modernità, sia collegato a due esperienze costitutive della modernità europea e occidentale, ovvero quella patriarcale e quella coloniale. Fin dall’antichità i testi che più hanno funzionato da canone della filosofia occidentale, si prenda come esempio la riflessione aristotelica a riguardo, descrivevano la donna (riflessione che viene ripresa anche da Rosi Braidotti3) e lo straniero come la parte irrazionale della società, come la parte da addomesticare. La cultura europea moderna riprende questo sistema dualistico, che riproduce, per citare Paul Girloy, un legame indissolubile tra razza bianca, mascolinità e razionalità4.
Questa critica alla costruzione della cultura europea come portatrice di razionalità e libertà non è rimasta senza risposta; al contrario, ha generato una reazione difensiva da parte degli ambienti conservatori, che vedono nella decostruzione di questa narrazione una minaccia alla stessa identità occidentale. Il concetto di cancel culture, emerso negli ambienti angloamericani, è diventato il fulcro di un dibattito che oppone chi difende l’eredità classico-cristiana come fondamento irrinunciabile della civiltà occidentale e chi, invece, ne critica le implicazioni oppressive ed escludenti. Mentre i primi interpretano ogni tentativo di revisione storica come un attacco alla libertà di espressione e alla tradizione, i secondi sottolineano come questa stessa tradizione sia stata utilizzata per marginalizzare interi gruppi sociali. In questo modo, il dibattito sull’identità occidentale diventa un terreno di scontro tra chi cerca di preservare un’immagine idealizzata del passato e chi ne rivendica una rilettura critica, capace di riconoscere le ambiguità e le ingiustizie che hanno accompagnato la sua costruzione.
Il tema dell’importanza di una “identità occidentale” va di pari passo con quello della sua difesa, che prende le mosse e si sviluppa in modo più ampio all’interno degli ambienti conservatori angloamericani; attraverso i potenti canali d’informazione Fox news5 e Daily mail nasce il concetto di cancel culture6, che velocemente genera aperte discussioni sulla grandezza e sulla necessità di difesa dell’“identità occidentale” e delle sue radici, portate avanti in egual misura da ambienti culturali progressisti e conservatori. La cultura occidentale e il suo eccezionalismo sarebbero in pericolo a causa di un’élite intellettuale con indefiniti fini politici che nell’ultimo periodo starebbe tentando, a partire dall’area angloamericana per poi espandersi in tutto il mondo, di impedirne il riconoscimento; staremmo dunque assistendo a una messa in pericolo della stessa cultura occidentale, in larga parte concepita come derivante da quella classico-cristiana.
Da una parte si sostiene che ogni tentativo di inserire all’interno del dibattito sull’effettiva validità della categoria di cultura occidentale elementi critici o influenzati dagli studi culturali sia parte di questa fantomatica cancel culture, e dunque siano elementi che vorrebbero cancellare aspetti “scomodi”, insopportabili all’occhio contemporaneo, e che dunque andrebbero a minare la libertà di parola; dall’altra che questi elementi siano parte di un tentativo più ampio di revisionismo storico con l’obbiettivo di cancellare l’identità occidentale per sostituirla con quella proveniente da un indefinito “fuori”.
Per fare luce sull’argomento sembra dunque opportuno mettere in discussione l’idea stessa di civiltà occidentale e come questo non sia un concetto neutrale, universale o eterno. Questo mito, infatti, è piuttosto moderno e tende a definire uno specifico modello di progresso tecnologico e sociale, spesso utilizzato storicamente per giustificare gerarchie razziali, culturali o civili. Come sottolinea Rebecca Futo Kennedy, non esiste una definizione di civiltà occidentale che non la dipinga come eccezionale o che non cerchi di presentarla come un valore universale, ed è per questo necessario prenderla in considerazione come radicata nelle esperienze di un ristretto gruppo sociale7. Questo concetto, dunque, rimane un pericoloso mito, funzionale a sostenere una visione del mondo piuttosto razzializzata e in diversi casi una politica coloniale diretta o indiretta.
Soprattutto durante gli anni ’60, si è assistito ad una culturalizzazione dei movimenti sociali: molti soggetti si sono uniti in movimenti organizzativi e trasformativi a partire da temi specifici quali ad esempio razza e genere, riconosciuti come matrici di oppressione e sfruttamento, per arricchire la battaglia sulla redistribuzione della ricchezza e del potere. Alla grande spinta sociale di questi soggetti politici, le istituzioni europee e occidentali hanno reagito con un procedimento analogo a quello messo in atto per quanto riguarda il tema posto in maniera radicale dal movimento ambientalista, depotenziando la carica sovversiva, coniando la categoria di multiculturalismo liberale. All’inizio del XXI secolo, come coglie la filosofa politica Nancy Fraser, grazie al continuo assalto retorico neoliberista all’egualitarismo, il ruolo dei movimenti che portavano al centro del dibattito la redistribuzione è stato notevolmente ridotto e la battaglia si è spostata sempre di più in ambito culturale. Fraser ha messo in guardia innanzitutto contro la tendenza del multiculturalismo (liberale) a nascondere le politiche sociali e le disuguaglianze economiche, e in secondo luogo contro la tendenza ad essenzializzare culture e identità:
In primo luogo, questo passaggio dalla ridistribuzione al riconoscimento sta avvenendo nonostante, o a causa di, un’accelerazione della globalizzazione economica; in un momento in cui un capitalismo in aggressiva espansione sta esacerbando radicalmente la disuguaglianza economica. In questo contesto, le questioni di riconoscimento servono meno a integrare, complicare e arricchire le lotte redistributive che a marginalizzarle, eclissarle e sostituirle. Chiamerò questo il problema dello spostamento. In secondo luogo, le attuali lotte per il riconoscimento si stanno verificando in un momento di interazione e comunicazione transculturale in enorme aumento, quando la migrazione accelerata e i flussi mediatici globali stanno ibridando e pluralizzando le forme culturali. Tuttavia, le strade intraprese da tali lotte spesso non servono a promuovere un’interazione rispettosa all’interno di contesti sempre più multiculturali, ma a semplificare e reificare drasticamente le identità di gruppo. Tendono piuttosto a incoraggiare separatismo, intolleranza e sciovinismo, patriarcalismo e autoritarismo. Chiamerò questo il problema della reificazione8.
Questo processo di essenzializzazione delle culture è un fenomeno che tuttavia vediamo ripresentarsi sempre di più nel periodo contemporaneo, soprattutto sotto la spinta di movimenti razzisti e neofascisti, ma con il contributo essenziale di legittimazione da parte delle élite liberali. Da una parte la cultura europea, radicata nella classicità, dall’altra il “resto”.
Le sirene della cultura classica
L’esaltazione dell’antichità classica e della sua cultura, trattata come un insieme monolitico di caratteristiche specifiche, non è certo un fenomeno che si limita al periodo contemporaneo. Già all’inizio dell’800 il mondo greco e romano rappresentavano un modello positivo e quasi mitologico: la decadenza dell’Italia contemporanea e la grandezza dell’antica Grecia sono, ad esempio, i temi centrali che Leopardi tratta nella poesia All’Italia. Alle prime tre strofe è dedicata la riflessione sulla situazione italiana, mentre le ultime quattro celebrano la gloria greca9. Passando per il momento risorgimentale, nel Novecento, per i regimi reazionari europei il mondo antico ha costituito un presunto modello da cui trarre ideali e canoni estetici. La Germania nazista tentò di presentare il popolo tedesco come il diretto erede di quello greco10: basti pensare al film propagandistico Olympia di Leni Riefenstahl, nel quale la fiaccola olimpica parte da Atene, le statue greche piano piano prendono vita, diventano atleti e corrono fino a Berlino. Anche in Italia, durante il Ventennio, il fascismo tentò di presentare il proprio governo come erede dell’Impero romano. Il clima culturale risentì di questa influenza a tal punto che persino il cattolico antifascista Gaetano de Sanctis appoggiò nel 1936 la “guerra di civiltà” in Etiopia; sempre paradigmi antichi sorressero in generale la politica coloniale dell’Italia di quegli anni, immaginando nuovi Scipioni e «quarte» guerre puniche11. A tal proposito, tuttavia, è molto interessante, in un’ottica dialettica, il testo di abba Ghebreyesus Hailu, il quale capovolge i codici della retorica coloniale utilizzando elementi della cultura classica europea e della letteratura italiana dell’Ottocento per denunciare la brutalità del colonialismo12.
Come si è visto negli esempi all’inizio riportati riguardanti il contesto italiano, il richiamo alla cultura classica continua oggi ad essere centrale, in quanto, come è stato precedentemente ricordato, essa viene considerata l’origine della contemporanea cultura occidentale e più nello specifico europea. Quello che preme sottolineare in questo caso, tuttavia, è che ciò che accade oggi, ovvero l’utilizzo dell’antichità classica, soprattutto della grecità ma non solo, per giustificare un atteggiamento di suprematismo bianco, ha una storia di lungo corso, e ha l’effetto di contaminare l’indagine del mondo antico e la sua rappresentazione con categorie utili solamente a scopi politici contemporanei, a scapito di una seria ricostruzione storica. Per suprematismo bianco in questo caso non si intende semplicemente una forma estrema di razzismo, bensì un hummus culturale che alimenta il razzismo in modo sottile e che giustifica determinati regimi di oppressione e sfruttamento. Il suprematismo bianco è il presupposto della superiorità della razza bianca sugli altri gruppi; è, per riprendere l’analisi fatta da Alessandro Scassellati Sforzolini, parte del «dominio economico-finanziario e politico-militare americano»13.
Un esempio di questo atteggiamento in ambito storico accademico sono le posizioni di Donald Kagan, uno dei più influenti storici statunitensi della guerra del Peloponneso, che sostiene l’unicità della civiltà occidentale, basata su quello che chiama “miracolo greco”, insieme di libertà e democrazia, e considera la filosofia e la letteratura greca come esempi unici di razionalismo e creatività. In modo molto differente, senza sostenere un’esplicita superiorità della cultura europea e classica, anche Maurizio Bettini si inserisce in uno spazio discorsivo creato da ambienti conservatori e reazionari, cercando di dimostrare il perché la cancel culture sarebbe deleteria e stigmatizzando come élite culturali (da campus studentesco) tutti coloro che inseriscono elementi di criticità all’interno del dibattito sul mondo antico; ritornerebbe anche in questo caso la necessità, in momenti di crisi, di recuperare il dialogo con l’autentica classicità: “Il nostro presente – irto di contraddizioni, di splendori e notti buie, di salvezze e condanne – ha insomma tutta l’aria di essere solo e soltanto un presente: che mentre chiude il dialogo con il passato, forse proprio per questo non riesce ad aprirne uno con il proprio futuro”14.
Il richiamo alla cultura classica come fondamento della civiltà occidentale rimane un tema centrale e dibattuto, spesso strumentalizzato per giustificare narrative politiche e culturali contemporanee. L’antichità classica continua a essere un terreno di scontro tra chi ne celebra l’eredità come unica e superiore e chi ne critica l’uso per perpetuare forme di supremazia culturale e razziale.
Conclusione
È necessario quindi mettere in discussione il concetto di tradizione, di cultura come concetto definito e di cui sia possibile tracciare confini definiti. Intravedere le dinamiche di costruzione di una comunità immaginata15 dietro al continuo ricorrere alla distinzione tra Europa e altro, tra Occidente e Altro, permette innanzitutto di depotenziare il tentativo egemonico da parte della classe dominante, e in secondo luogo di intravedere quali siano le dinamiche di oppressione e sfruttamento che si tentano di celare attraverso l’invenzione di una tradizione16 e quali siano le rispettive ricadute materiali.
La costruzione di questo campo egemonico da parte della classe dominante genera la costituzione di gruppi sociali subalterni, i quali risultano essere il prodotto di elaborate strategie rappresentative e auto-rappresentative; il subalterno diventa quindi la figura in cui le contraddizioni della cittadinanza moderna sono intensamente realizzate e rivelate17.
L’uscita dalla subalternità non va quindi concepita come l’aderenza incondizionata ai canoni identitari europei ed occidentali, bensì come trasformazione interna delle relazioni egemoniche che strutturano e producono la cittadinanza come processo di subalternazione.
- https://www.repubblica.it/politica/dossier/una-piazza-per-l-europa/. ↩︎
- https://www.fratelli-italia.it/wp-content/uploads/2024/05/Programma_Europee2024_FdI.pdf. ↩︎
- Rosi Braidotti, Dissonanze. Verso una lettura filosofica delle idee femministe, Roma: Castelvecchi 2024. ↩︎
- P. Gilroy, The black Atlantic. L’identità nera tra modernità e doppia coscienza, Milano: Meltemi 2019, p. 130. ↩︎
- Il media ha addirittura dedicato una sezione alla categoria di cancel culture: https://www.foxnews.com/category/topic/cancel-culture. ↩︎
- A questo proposito: E. Zucchetti, Sotto attacco? Panico morale e cancel culture, <Zapruder>, 63, 2024, pp. 52-73. ↩︎
- R.F. Kennedy, Classics and Western Civilization: The Troubling History of an Authoritative Narrative, in F. Santangelo and J. Bastos Marques (eds.), Authority: Ancient Models, Modern Questions, London: Bloomsbury Publishing 2023, pp. 87-108. ↩︎
- N. Fraser, Rethinking Recognition. New Left Review 3, 2000, pp. 107–20. ↩︎
- […] Piangi, che ben hai donde, Italia mia, / Le genti a vincer nata / E nella fausta sorte e nella ria. […] Oh venturose e care e benedette / L’antiche età, che a morte / Per la patria correan le genti a squadre; / E voi sempre onorate e gloriose, / O tessaliche strette, / Dove la Persia e il fato assai men forte / Fu di poch’alme franche e generose! / Io credo che le piante e i sassi e l’onda / E le montagne vostre al passeggere / Con indistinta voce / Narrin siccome tutta quella sponda / Coprìr le invitte schiere / De’ corpi ch’alla Grecia eran devoti. / Allor, vile e feroce, / Serse per l’Ellesponto si fuggia, / Fatto ludibrio agli ultimi nepoti; / E sul colle d’Antela, ove morendo / Si sottrasse da morte il santo stuolo, / Simonide salia, / Guardando l’etra e la marina e il suolo. ↩︎
- J. Chapoutot, Il nazismo e l’antichità, Einaudi: Torino 2017. ; M. Bonazzi, Il nazismo, l’antichità, l’Europa, «Il Mulino», 2018, pp. 496-501. M. Bonazzi, In cerca di un nuovo Platone: da Wilamowitz al Terzo Reich, in M. Bonazzi e R. Colombo, Sotto il segno di Platone. Il conflitto delle interpretazioni nella Germania del Novecento, Roma: Carocci 2020. ↩︎
- G. Traina, I Greci e i Romani ci salveranno dalla barbarie, Roma; Bari: Laterza 2023. ↩︎
- Abba Ghebreyesus Hailu, L’ascaro. Una storia anticoloniale, Napoli: Tamu 2023. ↩︎
- A. S. Sforzolini, Suprematismo bianco. Alle radici di economia, cultura, ideologia della società occidentale, Bologna: DeriveApprodi 2023. ↩︎
- M. Bettini, Chi ha paura dei Greci e dei Romani? Dialogo e cancel culture, Torino: Einaudi 2023. ↩︎
- B. Anderson, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, Bari; Roma: Laterza 2018. ↩︎
- E. J. Hobsbawm e T. Ranger (a cura di), L’invenzione della tradizione, Torino: G. Einaudi 2002. ↩︎
- P. D. Thomas, Il cittadino sive subalterno, Rivista Italiana Di Filosofia Politica, 1, 2021, pp. 175–192, https://doi.org/10.36253/rifp-1466. ↩︎