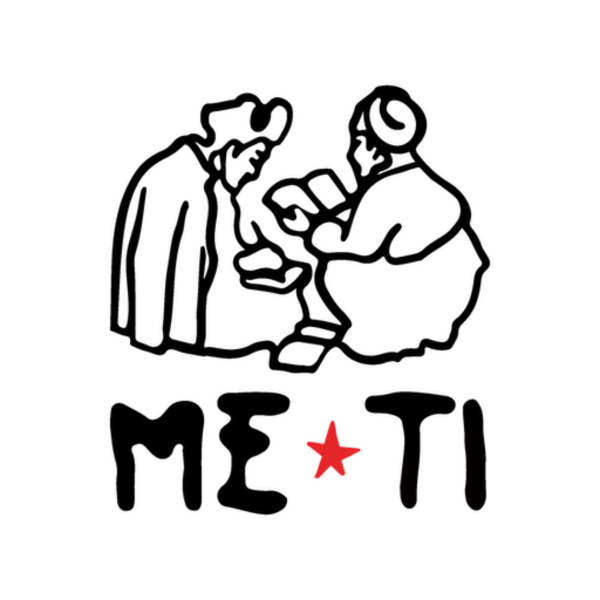“Vogliamo un mondo senza galere!”. Cosa significa oggi questo slogan? Dove ci porta? Si tratta innanzitutto di un’affermazione che ci costringe a ripensare il presente attraverso l’immagine della società che vorremmo domani. Perché un mondo senza galere è necessariamente un mondo rivoluzionato alla radice, infatti “non è possibile smantellare le prigioni lasciando intatto tutto il resto” (p. 88): il capitalismo, il razzismo, il patriarcato. Questa è la tesi di un libro importante di Angela Davis, Gina Dent, Erica R. Meiners e Beth E. Richie uscito in italiano nel 2023 per Edizioni Alegre: Abolizionismo. Femminismo. Adesso.
Oggi questo libro ci sembra imprescindibile per parlare di giustizia trasformativa, di carcere, di mutualismo conflittuale e di organizzazione delle lotte (che poi, non a caso, sono i temi attorno a cui ruotano le nostre prime tre pubblicazioni Ne*ri con le pistole, Alleanze ribelli e Trame).
Il testo di Davis, Dent, Meiners e Richie, nel raccontare la storia dell’abolizionismo carcerario, delle sue pratiche e dei movimenti di lotta che negli ultimi decenni hanno sposato questa causa, mette in evidenza come una delle principali caratteristiche del femminismo abolizionista sia la sua concretezza, la capacità di tenere assieme le risposte immediate necessarie alla comunità, attraverso pratiche solidali e di mutualismo conflittuale, e un quadro teorico e trasformativo d’insieme, volto al cambiamento radicale, rivoluzionario: guarda all’assalto al cielo e contemporaneamente verso qualcosa di molto “terreno”, verso i bisogni materiali delle persone che vuole supportare e coinvolgere nel suo progetto (p. 27).
Questo doppio sguardo fa sì che entrambe le pratiche e le riflessioni, quella di carattere più teorico e quella più immediata e vertenziale, si rafforzino reciprocamente. Se il sistema penale attuale, negli USA come qui da noi, si basa sulla “giustizia retributiva”, sull’inflizione di punizioni come unico sistema di riparazione del danno, l’idea di giustizia a partire dalla quale muovono le autrici cerca di essere meno individualista, meno “vendicativa”, e muove dalla rilettura dei singoli episodi “criminali” come parte di una dinamica sociale complessiva, come espressione di un sistema più ampio.
Iniziare ad ammettere che in carcere ci vanno praticamente soltanto le persone povere o marginalizzate può sembrare un’ovvietà, ma portare fino in fondo questo assunto ci consente di illuminare con una luce nuova tutto ciò che sappiamo su quella che comunemente chiamiamo Giustizia. Significa leggere il carcere – e la possibilità di finire in carcere – non come una devianza, un “fallimento”, un errore da sanare, ma come parte integrante di un’economia dello sfruttamento e dello scarto.
Così, per converso, l’abolizionismo non è altro che il tentativo di rompere questo sistema, a partire da un intervento che ha luogo sul piano della redistribuzione: reinvestire le risorse – materiali e simboliche – che normalmente sarebbero state allocate per la “sicurezza” (in termini repressivi, in senso più o meno ampio, dalle forze dell’ordine agli eserciti) in “sicurezza sociale”. La “riconcettualizzazione della sicurezza richiede la comprensione di un fatto fondamentale: con il pretesto di porre fine alla violenza di genere lo stato si arroga il diritto di determinare quale sia la natura del problema, decidere quali siano le soluzioni ‘ragionevoli’ e categorizzare le persone distinguendo tra quelle che meritano di essere al riparo della violenza e quelle che non lo meritano” (p. 135).
La reclusione nello spazio carcerario non è dunque semplicemente “la giusta conseguenza” per i crimini commessi: “sono moltissime le ragioni per cui le persone finiscono in prigione, oltre al fatto che le persone lese dalle azioni criminali potrebbero avere bisogni che esulano dal vedere incarcerati i responsabili. Centrale in questo processo di rivincolamento è riconoscere che quando si tratta di determinare chi finisce in prigione, razza, genere, classe e orientamento sessuale sono fattori più determinanti rispetto ad aver commesso un crimine” (pp. 69-70). È nell’ottica di questa lettura complessa dei fenomeni “criminali” che il femminismo abolizionista si è mosso anche per contrastare la violenza di genere, richiedendo “un impegno pratico, un lavoro concreto: misure comunitarie preventive che possano essere attuate sia per ridurre l’incidenza della violenza di genere sessuale sia per intervenire senza coinvolgere la polizia quando essa si verifica” (p. 74).
Questo non significa giustificare o sollevare chi commette violenza da ogni responsabilità individuale, tantomeno “abbandonare le vittime a loro stesse”. Ma leggere il fenomeno della violenza in maniera sistemica e, soprattutto, non cercare scorciatoie, affidandosi a soluzioni semplici quanto illusorie. Come scrive Violeta Assiego: “La giustizia femminista non ha nulla a che fare con il desiderio di punizione esemplare e di vendetta su cui si basa il punitivismo. La giustizia femminista è articolata e costruita a partire dalla logica dei diritti umani. Vale a dire, da una logica contraria al diritto penale del nemico, che disumanizza i soggetti che incrimina cancellando i loro diritti individuali con il pretesto di garantire una falsa sicurezza collettiva”1.
Il grande rischio di assorbire e riprodurre questa concezione punitiva della giustizia sta anche nell’alimentare e legittimare – spesso involontariamente – le logiche puramente repressive imposte dalle istituzioni. Lo Stato “fin troppo velocemente sussume o coopta strumenti e linguaggi all’apparenza radicali” (p. 182), così il transfemminismo deve smarcarsi a tutti i costi da questi tentativi di riassorbimento e rifunzionalizzazione delle proprie istanze; in primis dalle loro declinazioni in chiave femonazionalista che associano, in un peculiare slittamento di significati, linea del colore/legalità/sicurezza/giustizia. D’altronde lo abbiamo visto con collettivi “femministi di destra” (sic!) come il francese Nemesis o con le recenti proposte sui femminicidi avanzate dal Governo Meloni: se la soluzione è la punizione, stiamo pur certe che le destre sapranno applicarla e praticarla molto meglio di noi, finendo per strumentalizzare le nostre istanze e rivendicazioni.2
Il punitivismo non è, come si è scritto a proposito del processo a Turetta e delle analisi che ne sono scaturite, “un unicorno”, una semplice invenzione social o giornalistica. Se in questo testo si parla di femminismo carcerario è perché esiste nel senso comune, e anche fra di “noi”, una tendenza (purtroppo tutt’altro che trascurabile o minoritaria) che sostiene che il meccanismo punitivo ha la capacità di proteggere le vittime di violenza.
Criticare il punitivismo non significa smettere di operare anche facendo pressione anche sulla dimensione giuridica – basti pensare all’importanza sociale della riforma/cancellazione di istituti come il “delitto d’onore”, del “matrimonio riparatore” o dello stupro come reato contro la persona e non contro la “pubblica morale” – ma che bisogna indirizzare questa pressione nella direzione di una maggior liberazione, cioè del riconoscimento del diritto di quelle persone che sono normalmente cancellate.
Non si tratta di trascurare le persone che hanno subito un danno, né di negare loro la giustizia, anzi. Come sottolinea Giulia De Rocco “la vittima dopo la denuncia scompare, non ci sono servizi, percorsi, non c’è ascolto. Dalla denuncia in poi, lo Stato si occupa soltanto di chi compie il reato”3, noi chiediamo che di queste persone ci si occupi prima, attraverso la prevenzione, e che dopo aver subito un danno che non si è potuto evitare, non scompaiano e che anzi possano avere a loro disposizione gli strumenti necessari a ricominciare la propria vita.
Dobbiamo portare fino in fondo la lettura sistemica dei fenomeni della violenza (e in senso lato della “criminalità”), “andare oltre l’impulso di condannare i singoli perpetratori” (p. 163), attivando pratiche e mettendo a disposizione risorse che li debellino e li prevengano, nella consapevolezza che non potranno mai essere estirpati alla radice in un contesto nel quale le leggi del mercato e dello sfruttamento sono esse stesse violente e criminali (questa volta non in senso lato!). “Il femminismo abolizionista ci insegna che la violenza di genere è un problema sociale complicato, con profonde radici culturali, che il mainstream ha fatto rientrare in un più ampio progetto carcerario” (p. 14). Anche durante i mesi più duri delle mobilitazioni di BLM seguite all’uccisione di George Floyd, sottolineano le autrici, si è provato a uscire dalla dinamica per la quale punire poliziotti violenti con pene più severe possibili potesse divenire la soluzione richiesta da chi scendeva in piazza. Si richiedeva, piuttosto che pene esemplari per i singoli agenti, che si facessero interventi seri sulla comunità chiedendo un cambiamento strutturale (p. 180).
Come scrive ancora De Rocco: “esiste una contraddizione di fondo nel condannare i singoli che compiono ingiustificabili e dolorosissime violenze private e trattare con imperdonabile tolleranza azioni sistemiche di violenza e dominazione di intere comunità o popoli”4, non si tratta, evidentemente, di fare “benaltrismo” – ci sarà sempre un male più grande, un fatto più grave del quale occuparsi – ma di mettere le questioni nella giusta scala. Di indirizzare sempre più la nostra rabbia e il nostro odio verso l’alto, di renderli politici e non semplicemente reattivi5. La mostrificazione del colpevole ci fornisce solo apparenti sollievo e soddisfazione: produrre il carnefice assoluto, il mostro assoluto porta fuori dallo spazio politico e sistemico la violenza, rischia di farla divenire un fatto privato, che ha a che fare con l’inclinazione individuale, con la dimensione inter-relazionale6.
Durante una delle presentazioni di Alleanze ribelli in giro per l’Italia ci è stata posta una domanda da un’operatrice di un CAV: “Se non incarceriamo come possiamo mettere in sicurezza, nell’immediato, le persone che subiscono violenza? Non rischiamo, per evitare la reclusione di chi produce il danno, di mettere a rischio chi lo subisce, addirittura di costringere la persona danneggiata ad auto-recludersi per proteggersi?”. Ci sembra che la questione sia necessaria, giusta e puntuale. Ci sembra che questo debba essere uno degli snodi fondamentali di un dibattito che, per noi, resta ancora aperto (come anche per chi in Alleanze dove posizioni integralmente abolizioniste si confrontano con posizioni trasformative). Crediamo che, in alcune situazione-limite, la privazione della libertà possa limitare il perpetuarsi del danno, ma sappiamo che non lo ripara e che le misure per cui il danno continua a prodursi sono altre. Soprattutto abbiamo la convinzione che la punizione, la privazione della libertà, debbano essere sempre l’ultima e l’estrema risorsa alla quale attingere, mai la prima (e che questo debba valere anche per gli strumenti come – call out, allontanamenti, etc. – che adottiamo nei nostri spazi7).
In conclusione, nel riflettere sugli spunti fornitici dalla lettura di questo e altri testi sul tema, c’è un ultimo aspetto che vorremmo affrontare. Le prigioni non sono uno spazio separato da tutto il resto, se è così necessario riflettere sulla loro natura e funzione – da Goffman e Foucault in poi – è anche perché rappresentano la cartina di tornasole, il sintomo che si fa spia di un male che affligge la società nella sua interezza, “le prigioni riproducono le forme di violenza che proliferano nel mondo libero” (p. 67). Riplasmare il terreno comune significa anche fare un racconto del carcere come “discarica” – evidenziandone la crudele inutilità – ma anche e soprattutto come luogo umano. Spazio nel quale le persone recluse continuano ad essere esseri umani, con una storia e una fisionomia ben definita.
Considerate come rifiuti irrecuperabili, come deviate e mostruose, “le persone in prigione (…) raramente vengono riconosciute come soggetti in grado di comprendere e trasformare la propria condizione” (p. 68). Lavorare dentro e fuori dal carcere per una giustizia trasformativa significa riconoscere la sistematicità del meccanismo capitalista di sfruttamento e scarto, identificare il carcere come parte interna della società che vogliamo cambiare (non come spazio esterno e separato), far emergere il legame tra persone che appartengono a gruppi diversi, ma che sono tutte implicate in questo meccanismo.
Proprio nei giorni in cui Trame è andato in stampa (aprile 2025) è stato varato dal governo un nuovo decreto sicurezza che si occupa anche di prigioni e CPR – due luoghi che associamo per evidenti motivi. Il decreto vuole garantire “maggior sicurezza” all’interno degli istituti penitenziari. Questa maggior sicurezza, inutile sottolinearlo, non ha a che fare con la vivibilità di queste strutture sovraffollate, con la salute fisica e mentale delle persone detenute, con l’accessibilità alle misure alternative, ma con un inasprimento delle pene e dei provvedimenti disciplinari per gli atti di resistenza (anche passiva) o di disobbedienza.
Il carcere deve diventare sempre più un buco nero in cui si esercita il castigo, in cui si cerca di rimuovere le persone dal resto della società e, più in generale, dall’umanità. Rappresentata come numeri e cose, senza volto, la popolazione carceraria perde la sua natura umana e si trasforma in rifiuti da nascondere ed eliminare. Il lavoro simbolico, giuridico e politico sul cosiddetto “decoro” e sulla sicurezza (intesa in chiave puramente repressiva) va avanti ormai da decenni8. Questo lavoro vuole suggerirci due assunti: che le persone indecorose (povere, marginalizzate, razzializzate, etc.) ci mettono in pericolo e rendono le nostre vite più insicure e che il carcere è necessario perché la società resti protetta. Li rifiutiamo entrambi.
Lavorare politicamente, socialmente e anche in termini di rappresentazione su che cos’è il carcere e a cosa serve, da chi è abitato, significa rimetterlo in continuità con lo spazio sociale e non separarlo da esso, (è quello che nel nostro piccolo abbiamo provato a fare con Trame): “mentre le associazioni locali continuano a trasformare lo spazio di discussione (…) ci sono anche progetti culturali artistici che contribuiscono a naturalizzare lo stato carcerario e a portare le riflessioni e le discussioni sulla violenza istituzionale a un pubblico mainstream (…). La cultura visuale, la musica, l’arte e la letteratura incidono in modo profondo sull’immaginario collettivo, precedendo di molto i cambiamenti nelle politiche e nelle leggi” (pp. 31-32).
Parlare di abolizionismo, di giustizia transfemminista, non significa far scomparire il carcere come per magia, ma disporsi a una trasformazione sociale ampia e radicale in cui la vera anomalia saranno i meccanismi che generano oppressione e marginalità, in cui i concetti di giustizia e sicurezza assumeranno finalmente in maniera diffusa e condivisa un senso sociale.
- In Alleanze Ribelli. Per un femminismo oltre l’identità, p. 95. ↩︎
- Ne abbiamo scritto a proposito di di Faire justice di Elsa Deck Marsault e di Odio di Şeyda Kurt. ↩︎
- Giulia de Rocco, Aboliamo il carcere. Immaginare un futuro senza prigioni, Eris 2025, p. 5. Sul sistema carcerario USA si veda Victoria Law, “Le prigioni rendono la società più sicura” e altri venti miti da sfatare sull’incarcerazione di massa, Mimesis, 2023. ↩︎
- Ivi, p. 30. ↩︎
- Su questo si rimanda a: Rage, Sense and Sensibility di Spazio Catai. ↩︎
- Giulia de Rocco, Aboliamo il carcere. Immaginare un futuro senza prigioni, cit., p. 24. “Le analisi sui legami tra le varie forme di oppressione, diventavano incompatibili con una sempre più diffusa concezione della violenza di genere basata sull’essenzialismo di genere. All’interno di questa cornice una sex worker, una persona queer, una donna di colore non potevano essere vittime ‘legittime’ della violenza di genere e sessuale e di certo non poteva esserlo una persona incarcerata” (Abolizionismo. Femminismo. Adesso., p. 127); su questo tema rimandiamo ovviamente anche a Alleanze ribelli. Per un femminismo oltre l’identità, in part. sulla produzione speculare della vittima come sempre pura, innocente e senza macchia che di fatto esclude dalla protezione e dalla tutela chiunque non corrisponda a questo immaginario. ↩︎
- Ne abbiamo parlato in Il personale è (ancora) politico? ↩︎
- Cfr. H.-P. Michels, The “Underclass” Debate. A discours that Maligns people Living in Poverty, «Social Change Review», vol. 11, fasc. 1 (2013); e in part. sul caso italiano: W. Bukowski, La buona educazione degli oppressi. Piccola storia del decoro, Alegre, Roma 2019; C. Pisanello, In nome del decoro, Ombre Corte, Verona 2017. ↩︎